di Andrea Galgano 16 gennaio 2018
leggi in pdf Edward Thomas: le fenditure di acqua e di vento
 Quando inizia a scrivere poesia nel 1914, Edward Thomas (1878-1917), nato a Londra nel 1878 da genitori gallesi, è uno dei critici inglesi più autorevoli, autore prolifico di prosa d’arte e di viaggio, biografie, antologie, libri su commissione.
Quando inizia a scrivere poesia nel 1914, Edward Thomas (1878-1917), nato a Londra nel 1878 da genitori gallesi, è uno dei critici inglesi più autorevoli, autore prolifico di prosa d’arte e di viaggio, biografie, antologie, libri su commissione.
L’indefesso lavoro pagato con la dipendenza dall’alcool e dall’oppio, la depressione, il tentativo di suicidio, le camminate infinite, l’innamoramento per Hope Webb, il matrimonio, le fughe, la pulsione di morte e la campagna sono la cifra umbratile e sollevata di un altrove ricercato oltre la quotidiana guerra del limite e del lavoro, della densità e della terminale ekphrasis:
«[…] Quanto a me, / dove ho incontrato quell’aroma amaro / non so più. Anch’io sminuzzo le grigie cime, / le annuso e penso e le annuso ancora e provo / ogni volta a pensare cosa sto ricordando, / sempre invano. Quell’odore non può piacermi / però rinuncerei a ogni altro, più dolce / ma insignificante, per quell’amaro. / Ho smarrito la chiave. Annuso il ramoscello / e penso a nulla; vedo e sento un nulla / che pure sembra doversi ascoltare, aspettando / ciò che dovrei, e mai potrò, ricordare. / nessun giardino appare, né sentiero o cespuglio / di brina verde, assenzio, abrotano, né una bimba / lì accanto, o padre o madre, o compagno di giochi; / solo un viale, buio, senza nome, senza fine» (Assenzio).
Con la pubblicazione, presso Elliot di Roma, di una corposa antologia di cinquanta componimenti, La strada presa. Poesie scelte[1], a cura di Paolo Febbraro, la poesia di Thomas ci viene restituita nel suo setaccio di stupefatta austerità, di solcata freschezza e, allo stesso tempo, concentrando l’arma segreta dell’essere, l’appunto e la stesura di una fibra di contrasti.
Una forza enorme che attinge anche alla conoscenza condivisa con Robert Frost, laddove l’amore per le lunghe passeggiate e la dolcezza del Sud dell’Inghilterra diventano il taccuino di uno sguardo e il calore mitopoietico di una leggerezza brezzata:
«[…] Ma, per quanto io sia come un fiume / sul far della sera quando sembra che mai / il sole l’abbia acceso o scaldato, mentre / brezze oblique ne increspano la superficie, / il cuore, frazione di me stesso, felice / si libra per la finestra anche ora, verso l’albero / d’una nebbiosa e fioca, quieta valle; / non come un vanello che torni a gemere / per ciò che ha perso, ma come un colombo / che plani ad ali ferme sul nido amoroso. / Lì trovo riposo, e nel crepuscolo la brezza / solleva ciò ch’è vivo in me. È lì la Bellezza» (Bellezza).
La fuga dalla violenza espressiva indizia un convoglio, invece, di densità sofferta, di memoria cadenzata e nitida, di strettoie esistenziali e di liberazioni esuli, in continua librazione tra caducità e perennità:
«Un tempo avevo dato a ore come questa / il nome di malinconia, quando / non erano quelle di letizia e potenza / che stavano tornando come esuli in patria, / e le fragilità che lasciavano i propri tetti / sorridevano e si godevano, lontane da tutti, / dei momenti di perennità. / E fortunata fu la mia ricerca / finchè ciò che cercavo, nonostante / lo stessi cercando, ancora non indovinavo. / Fu breve quel momento: di nuovo in locande / e per le strade cercai il mio uomo / quando un giorno nel frastuono d’una mescita / a voce alta lui chiese di me, cominciò / a parlare, come fosse stato un peccato, / di come io pensassi e sognassi di lui / e dietro a lui corressi, un giorno dopo l’altro / viveva come uno messo al bando / per questo: cosa avevo da dire? / Non dissi nulla. Non feci che sfuggire. / e ora non oso seguitarlo troppo / da vicino. Provo a tenerlo in vista, / temendone il disgusto e peggio il riso. / Esco furtivo dal bosco della luce; / vedo il rondone lanciarsi dalle travi / presso la porta della locanda: prima d’approdarvi / aspetto e sento gli storni ansare / e piluccare come anatre: aspetto la sua fuga. / Lui va: io seguo: niente liberazione / finchè non finisce. Poi finirò anch’io».
L’annotazione e la memoria, l’accentuato solco della poesia, il rovello spazio-temporale sollecitano sovrapposizioni di colore e suono che si trasferiscono e si intersecano nella densa monografia dell’essere, nel suo ossimoro di voce poetante, che mai rimugina, bensì vive e lotta, nel violento permanere keatsiano dello sguardo e della percezione, come origine e conoscenza feroce nel mondo e del mondo:
«Tutto il giorno l’aria trionfa con due voci, / il vento e la pioggia: / come fosse in collera, forte si solleva / inglobando il suono della terra / che beve, nel soffocato sforzo, e vano, / d’ingoiare la pioggia. / A metà notte, pure, feroce è solo l’aria a parlare / con vento e pioggia, / finchè la muta fonte del fiume erompe / e ingloba pioggia e vento, / mugghia gigante nel gaio tuffo campestre / il trionfo terrestre» (La fonte).
Paolo Febbraro scrive:
«Autore subalterno, compresso dalla proletarizzazione della funzione intellettuale, solo camminando e annotando Thomas cerca di agganciarsi a un tempo diverso, a una cadenza naturale, e quindi ciclica, stagionale, trans-individuale. Le vaste letture della tradizione poetica inglese, la conoscenza di ballate e canzoni del folclore anglo-gallese e le ampie escursioni a piedi o in bicicletta attraverso i territori amati (lo stesso Galles, il Wiltshire, il Gloucestershire, lo Hampshire…) gli forniscono una segnaletica identitaria al tempo stesso precisa e trascendente, ben collocata e metastorica. I tempi della Natura sussumono quelli del lavoro nell’industria culturale, li circoscrivono, invece di inserirsi in essi come un’evasione compensatoria».[2]
Edna Longley, soffermandosi sulla poesia di Thomas e di Frost, unitamente collegate e, allo stesso tempo, disciolte, sostiene:
Le prime poesie di Thomas sono particolarmente ricche di strade e sentieri; anche se questo visibile simbolismo […] deriva dall’intersezione fra il suo labirinto interiore e i suoi viaggi nella campagna inglese e gallese. Tuttavia, The Road Not Taken – e se è una sagoma profetica – può essere a conoscenza di tutto ciò. Può prefigurare più generalmente il paesaggio psicologico della poesia thomasiana. Chi parla è un “Io” diviso: un Sé frazionato sia nelle presente sia in incarnazioni presentie future. E lo stesso titolo della poesia accentua non la strada potenzialmente presa, ma quella impedita: di qui il desiderio. Nella poesia di Thomas, la bramosia per una via “migliore”, per opzioni perdute e sequestrate, si connette con la forza motrice del desiderio.[3]
Se, quindi la poesia celebra il suo vortice epifanico, la taciturna densità dell’istante aggiunge «il ritmo dispiegato e tridimensionale di oggetti naturali, colline, alberi, prati, gorgheggi di uccelli, flussi d’acqua», la stessa epifania «si dispone negli spessori della memoria letteraria, e poetica in particolare, poiché la poesia è la descrizione grafica della propria stessa cadenza, e non ha paura dei propri echi e dei propri calchi, in quanto la memoria non è originalità lessicale, ma riattivazione, connessione con il già esistente, riscoperta sorprendente[4]».
Andrea Caterini afferma:
Ci sono scrittori per cui la poesia è qualcosa di innato, e la consumano così come si consuma o si incendia la giovinezza (Rimbaud, Keats, fino al nostro pittore visionario, Scipione). Per altri, che sembrano nutrire per la poesia un rispetto finanche reverenziale, arriva solo più tardi, quando gli strumenti per leggerla e giudicarla sono tanto solidi da fargli credere sia maturo il momento per poterne loro stessi scrivere. Thomas, che sulla poesia aveva un continuo confronto col suo amico Robert Frost, è di questi secondi (il primo componimento lo scrisse a trentacinque anni), e crediamo sia stata una fortuna abbia atteso, non abbia avuto fretta, così come al contrario ne aveva avuta lavorando agli altri suoi libri, con cui sosteneva se stesso e la famiglia. Ma quella scoperta tardiva della poesia la avvertiamo nel ritmo calmo e paziente dei versi. Non si confonda però la calma per apatia, e neppure per una forma di ostentata saggezza. Thomas è un uomo lacerato dentro (si era sposato giovanissimo perché aveva messo incinta la sua futura moglie, ma segretamente nutriva desideri omosessuali; soffre di depressione e ha fasi acute di irritabilità) e mentre osserva il mondo gli dona la sua cerebralità – come se la sua mente offrisse alle cose, e alla loro organizzazione (cioè a un sistema di significati) un ritmo.[5]
Il segreto pattern dell’esistente, vive di un consueto seppellimento ed esumazione, sommersione ed emersione (Il ponte). La parola appartata, il consorzio memoriale, la materia verbale celebrano, quindi, oblio e ricordo in un odore di interstizi e infanzia, percezione coperta e investimento, lievità di sogni e dimore perdute («E seppe di sale il mio cibo, e la mia quiete, / di sale e di senno poiché quel verso / parlava di quelli coperti dalle stelle, / i poveri e i soldati, esclusi dal riaversi»):
«Tante sono le cose che ho scordato / che un tempo furono – o non furono – molto per me, / perdute, come il figlio di una donna senza figli / e i figli di quel figlio, nell’incorrotto / abisso di ciò che non ci sarà mai più. / Ho scordato anche i nomi dei potenti / che combattendo hanno perso e vinto vecchie guerre, / dei re, dei demoni e degli dèi, e di molte stelle. / E adesso scordo quante cose ho scordato. Ma cose ci sono, ancora ricordate, minori di ogni altra. Un nome che non ho scordato / – per quanto sia solo un vuoto e nudo nome – / non può morire perché ad ogni primavera / i tordi imparano a dirlo col canto. / A mezzogiorno ce n’è almeno uno a dirlo / chiaro e pungente – sempre e soltanto il nome. / Se sto pensando forse all’odore del sambuco / che sembra cibo, o mentre mi appago / con quello della rosa canina, uguale alla memoria, / ecco che a questo nome mi giunge gridato / chissà da quale cespuglio, detto e ridetto ancora / da un volatile, di un tordo la pura parola» (La parola).
Roberto Galaverni scrive:
Thomas è un poeta legato al mondo campestre, alla natura, al paesaggio del Galles e soprattutto dell’Inghilterra meridionale. […] Le sue poesie sono concepite da qualcuno che attraversa la campagna (quanti sentieri, quante stradine nei suoi versi; e poi gli uccelli, gli alberi, le acque, certe figure di viandanti, di uomini al lavoro, di bambini), e che intanto guarda, riflette, soprattutto ascolta. Sono le poesie di un passeggiatore che cammina e pensa, e che dunque si ferma anche ad annotare le sue osservazioni, come cercasse la legittimazione, la solidificazione reciproca tra immagini, pensieri e parole. Saranno proprio le annotazioni su suoi taccuini campestri il punto di partenza della sua scrittura poetica. Questa intensità percettiva, questo sentire così pieno e totale, potrebbe forse far pensare al nostro Pascoli più impressionista, se non fosse che Thomas non cerca nel paesaggio naturale e nei suoi elementi un punto di fuga, un’emozione circoscritta, uno sfondamento nel mistero, quanto un termine di commisurazione affidabile, un territorio non particolaristico su cui provare a definire la propria identità, la curvatura del proprio destino.[6
I field-notes rappresentano sì il tempo campestre, il viaggio naturale, il vissuto periscopio dell’anima e il pronunciamento delle notizie dal mondo («Tutto mi è stato annunciato; niente che potessi prevedere; / ma ho imparato il suono del vento / quando queste cose fossero state vere»), ma sono anche l’implacabile sostanza del parto della sua coscienza, la semina e la potenza dell’attesa, e, infine, la profondità verbale slogata del tempo («Fu un’ora distesa, allungata, / nulla è restato / incompiuto; ogni giovane seme / senz’altro disseminato. / E adesso, dà ascolto alla pioggia / lieve e senza vento, / per metà bacio, per metà pianto, / ad assopire l’evento»), come una faglia di una manciata di terra e di nome:
«Sì. Ricordo Adlestrop – / il nome, per un caldo pomeriggio / in cui il treno espresso vi si arrestò / insolitamente. Era la fine di giugno. / La vaporiera fischiò. Uno schiarirsi di gola. / Nessuno lasciò la nuda banchina, / nessuno vi giunse. Ciò che vidi / fu Adlestrop – il nome soltanto / e salici, epilobio, ed erba, / e regina-dei-prati, e secchi covoni / non meno fermi, disposti e solitari / che in cielo gli alti cirri. / E un merlo in quel minuto cantò / lì presso, e attorno a lui, più persi, / da molto più lontano, tutti gli uccelli / delle contee di Oxford e Gloucester» (Adlestrop).
La decisione di arruolarsi nel luglio del 1915 (morirà colpito da una granata tedesca nei pressi di Arras nell’aprile del 1917), è il fatto distintivo di una netta comunione di illuminazione e sconfitta, in cui la toponomastica e la geografia cadenzata del reale, la connettività del gesto e l’officina muta, il transito ineludibile e dimenticato, rappresentano la feconda energia di labilità diverse, di figure, di natura e di destino.
La sedimentazione esplorata della parola raggiunge l’apicale distinzione oltre l’anonimia dell’umano in guerra. Il tempo frazionato e sincopato del taccuino riconosce la dura e dislocata dis-umanizzazione della guerra meccanica.
È la relazione con le cose a solcare, a dissodare e incavare l’immaginazione decisa di ciò che vive (Scavare), come un acro trascurato e gioioso.
Il tempo, la sua fragranza, il colore accumulato, divengono rammemorazioni, schegge impazzite, restituzioni osservate che si fondono nell’ultima luce uscita dal mondo:
«Dovrei quest’oggi / prendere a cercare, anche se fino al cielo / e all’inferno, senno e forza pari a questa bellezza, calcando la polvere chiara macchiata di gocce scure, / nella speranza di trovare ciò che vado cercando, / dando ascolto a cose liete in apparenza / e passeggere, di cui nulla sappiamo, nel noccioleto? / O devo essere contento con lo scontento / come rondini e allodole lo sono con le loro ali? / O devo chiedere ancora, finito il giorno, / che sia la bellezza, e ciò che posso aver inteso / per felicità? E lasciare che tutto scivoli via, / lieto, sfinito o l’uno e l’altro? O sapere forse / d’esser stato spesso felice, prima, per un po’ / scordando quanto sono imprigionato, / quanto rapido a incupirsi, al nulla vagando, / sia il Tempo? Non so afferrare il cuore del giorno» (La gloria).
Facendosi voce del respiro, poi transitano, trascinandosi nell’analogia, nella metafora e nell’equivalente atonia delle intuizioni, in cui, come asserisce Febbraro:
ogni pianta e le diverse locande rurali, sono profondamente psicologizzati; ma questo non vuol dire totalmente espugnati dalle proiezioni mentali, né tradotti in equivalenze simboliche. È una strada a due sensi, come in ogni vero mondo poetico: gli elementi esterni alla coscienza sono investiti dalle proiezioni della mente, ma conservano una sufficiente autonomia per scompigliarne le geometrie. Le cose accolgono getti di luce – spesso oscura – del Sé, ma rimandano anche riflessi diversi, anche soltanto oggettivi, che agiscono come fattori in architetture più solide, cose, forse più sane, di certo esteticamente felici.
È una sospesa e decisa vitalità che si muove decisa verso il numinoso stupore epifanico e che, nella stessa direzione, frequenta ogni instabilità di luce e paesaggio.
Le strade rappresentano la continuazione non obliata della realtà. Una perdurata compiutezza che non esclude e in cui le curvature svelano un paradiso ottenebrato.
L’esito di una transazione, conclusa tra memoria conscia e inconscia, porta così all’estremo la tesa finitudine, l’oscurità fatale e la rivelazione: «E tuttavia sono quasi innamorato del dolore, / di ciò che è imperfetto, di gioia e di guerra, / di quanto ha una sua fine, di vita e di terra, / di questa luna che mi abbandona oscuro sulla porta».
Il sentiero, sezionato e descritto, dischiude il suo rasentato e fragile percorso di stille, serpeggiante d’argento, intuito e battuto dai bambini, infine socchiuso di illusione e meraviglia:
«Al di là di un argine, di un parapetto / che protegge da un bosco che scoscende / sotto la via, corre un sentiero. Consente / ai bimbi di guardare il lungo e uniforme pendio, / fra i rami di faggio e di tasso, fin dove / un albero caduto ferma la vista: mentre gli adulti / si accontentano della via e di quanto vedono / al di qua dell’argine, e di quanto i bambini dicono. / Il sentiero, con un serpeggiare d’argento, è stillante, / rasentato e infine invaso dal muschio più sottile / che tenta di coprire le radici e il calcare friabile / con oro, olivastro o smeraldo, ma invano. / I bambini lo segnano. Hanno spianato l’argine / sulla cima e l’hanno inargentato fra il muschio / col camminarvi sopra, anno dopo anno. / Pure la via è senza case, e non conduce a scuole. / vedervi un bambino è raro, e lo sguardo / non coglie che la via stessa, il bosco che v’incombe / e sotto si spalanca, e il sentiero che sembra / condurre a qualche leggendaria o fantastica / contrada in cui gli uomini hanno voluto andare, / finchè, all’improvviso, cessa dove cessa il bosco» (Il sentiero).
Per Thomas, allora, la stessa poesia
vuol dire vitalità in attesa della condanna, intrattenimento della fine, intensificazione della presa su oggetti che si stanno per lanciare via da sé, per lasciarli al loro tempo permanente e fragilissimo. Combattere nel fango francese vuol dire salvare la terra inglese; lo stesso è scrivere poesie: rappresentare l’intero campo arato, non più il semplice solco della stenografia appoggiata sui taccuini.[7]
Il luogo è la bruta bellezza di una prodezza in atto, per dirla alla Hopkins, in cui poter sperimentare l’accento del mito e della tradizione, la narrazione tumefatta e stupefatta di un culto di voce e sopraffina luce. La meditata estasi dei rimandi, che si increspano, si disabitano, chiude le sue aperture di interezza alla spezzata solitudine:
«Pioggia di mezzanotte, solo la pioggia selvaggia / su questa capanna tetra, e solitudine, ed io / a ricordare ancora che dovrò morire / senza ascoltare la pioggia o ringraziarla / perché mi dilava e mi fa puro come mai / da quando sono nato a questa solitudine. / Beati i morti cui la pioggia dà pioggia: / ma prego che chi ho amato, un tempo, / non stia morendo, stasera, o a letto sveglio / solitario, ascoltando la pioggia, / nel dolore o in tale impotente / compassione fra i vivi e i morti, / come un’acqua gelida fra canne spezzate, / spezzate a milioni, rigide e ferme, / come me, privo d’ogni amore che questa pioggia / selvaggia non abbia dissolto, tranne quello per la morte / se amore può esserci per ciò che è perfetto / e non possa, dice la tempesta, disilludere» (Pioggia).
L’elegia, il residuo, il detrito dei lasciti, il mondo conservato compiono il loro passaggio. La mentalizzazione delle sillabe raggruma ogni fatalità nell’attesa. L’opacità di Thomas è il riflesso di un’opzione negativa, laddove la creaturalità, e quindi la corporale presenza degli oggetti e della Natura, rappresentano la metafisica unione di ritagli splendenti e sbandamenti.
Non è evasione e nemmeno fuga ciclopica dello sguardo, bensì rifratta tenebra, somiglianza e accoglienza di immagini emergenti, che agganciano e intrecciano «abstract meditation» e «visible beauty».
Pertanto, «il suo materialismo darwinista gli impedisce le fughe nell’irrazionale, nell’animistico, e apre in lui piuttosto alla rappresentazione della quarta dimensione, il tempo[8]». Il suo ingresso nella dimensione naturale è subìto, diventa parcellizzazione della mens semplificata e poesia dell’io frantumato, come arguisce Febbraro:
«Va nella Natura per subirla, per farsi da lei interrogare, o sconcertare, incalzando la “strada ogni volta presa” con le altre potenziali, perdute e per questo attivanti. Un paesaggio di colline, stagni e boschi come quello dell’Inghilterra meridionale è anche una forma della mente: attraversarlo, rievocarlo, comporta condensamenti e rarefazioni, accostamenti alla pienezza e svuotanti emorragie».[9]
Tale frantumazione riprende la coscienza di una dislocata rappresentazione e narrazione sconvolta. È poesia-crocevia, dramma lacerato e lacerto di speranza, segno unico e irripetibile di un incontro fervido di figurazione e mondo, in cui la percussione di ogni abbozzo si situa nella nostalgia rifilata e congiunta della fitta scomoda della propria demarcazione, che ha forma nella sottigliezza[10], nella terminazione contrappuntata, nella sintassi esperita e nella mancanza come sparo di flatus vocis.
[1] Thomas E., La strada presa. Poesie scelte, a cura di Paolo Febbraro, Elliot, Roma 2017.
[2] Febbraro P,., Introduzione, in Thomas E., cit., p.19.
[3] Longley E., Under the Same Moon. Edward Thomas and the English Lyric, Enitharmon Press, Londra 2017, pp.182-183.
[4] Febbraro P., cit., p. 20.
[5] Caterini A., Edward Thomas «La strada presa» per incontrare (tardi) la poesia, in “Il Giornale”, 1 dicembre 2017.
[6] Galaverni R., Il cantore gentile della natura che una granata mise a tacere, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 26 novembre 2017.
[7] Febbraro P., cit., pp. 23-24.
[8] Id., cit., pp.26-27.
[9] Id., cit. p.28
[10] Cfr. Schmidt M., in Lives of the Poets [1998], Vintage Books, New York 2000, p.571.
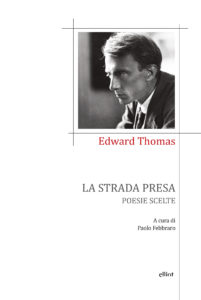 Thomas E., La strada presa. Poesie scelte, a cura di Paolo Febbraro, Elliot, Roma 2017, pp. 192, Euro 19,50.
Thomas E., La strada presa. Poesie scelte, a cura di Paolo Febbraro, Elliot, Roma 2017, pp. 192, Euro 19,50.
Thomas E., La strada presa. Poesie scelte, a cura di Paolo Febbraro, Elliot, Roma 2017.
Caterini A., Edward Thomas «La strada presa» per incontrare (tardi) la poesia, in “Il Giornale”, 1 dicembre 2017.
Galaverni R., Il cantore gentile della natura che una granata mise a tacere, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 26 novembre 2017.
Longley E., Under the Same Moon. Edward Thomas and the English Lyric, Enitharmon Press, Londra 2017.
Marucci F., Storia della letteratura inglese. Dal 1922 al 2000. I. Il Modernismo, Le Lettere, Firenze 2011.
Schmidt M., in Lives of the Poets [1998], Vintage Books, New York 2000, pp.568-576.
