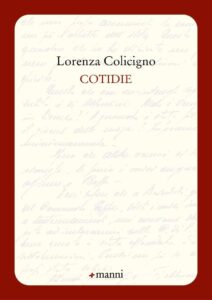di Carmen Cucinotta
9 settembre 2022
 Apparteniamo tutti allo stesso canneto: ciascuna canna è mossa dal vento in maniera unica, inconfondibile, ma tutte seguono insieme lo stesso movimento indistinto.
Apparteniamo tutti allo stesso canneto: ciascuna canna è mossa dal vento in maniera unica, inconfondibile, ma tutte seguono insieme lo stesso movimento indistinto.
Le poesie della raccolta di Andrea Galgano, Non vogliono morire questi canneti, sono così, seguono il vento come canne fragili e forti al contempo, divenendo meravigliosa metafora dell’esistenza umana.
Rainer Maria Rilke afferma nelle Lettere milanesi[1]:
<<Nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte; soltanto a poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo, e ogni giorno più definitivamente>>.
Andrea Galgano compie all’inizio della raccolta un viaggio di ricomposizione di sé, alla ricerca di ciò che ha avuto origine prima del sole, della luna e della terra e lo va cantando nel suo tragitto, mosso dal vento di quanto ha amato e ama ancora nella sua vita. Il desiderio dell’Amore primordiale, che ha dato origine a tutto, lo porta a celebrare i suoi luoghi della rivelazione, cartografie del suo cuore, come richiama il titolo della prima sezione delle sue poesie.
I paesaggi interiori sono luoghi realmente esistenti nella geografia delle sue personali esperienze e si affacciano alla viva memoria col nome delle splendide località che si stendono su un lembo di costa lucano straordinariamente risparmiato dal tempo e dall’uomo. Veri e propri paradisi terrestri hanno il nome di Acquafredda, Maratea, Cersuta, Castrocucco, Fiumicello, Cala Grande e Cala Jannita. Ciascuna località ha caratteristiche proprie e parla all’autore nella lingua dello stupore primordiale di sentirsi parte del Creato. Una lingua scomposta, frammentata in visioni e sensazioni allo stato puro, senza mediazioni di sorta, se non quelle della forma poetica, fatta principalmente di analogie, assonanze, metafore, similitudini, personificazioni. Il poeta non si rivolge mai a sé stesso, ma si apre costantemente ad un “Tu” che è presente prima di tutto: un io altro da sé nelle cose, altrove, nella terra a cui si rivolge, nella donna amata, nei ritratti umani tracciati.
Cartografie
Il primo componimento poetico è un vero e proprio punto di partenza, una via da intraprendere, “Via Lilio”, tracciata da una figura adulta e cara al poeta, una guida scomparsa purtroppo prematuramente. Una presenza visibile attraverso “l’incavo dei palmi”, le mani che lo accompagnavano da bambino. E di un compagno in effetti si tratta, con cui condividere “l’assalto/del sangue e il riso /tra le aiuole.” Via Lilio” sembra evocare la figura di Virgilio, la guida di Dante nei suoi mondi ultraterreni.
“La pietra opaca del Baltico” è invece la seconda poesia, dedicata alla città di San Pietroburgo, con i suoi canali e monumenti. In un’atmosfera alquanto oscura, nebbiosa e tremolante, il fiume che attraversa la città, la Neva, di notte scorre simile al sangue nelle vene. All’improvviso, con il suo guizzo esso dona al poeta quella straordinaria visione del “lampo della luce genitrice”, un fascio di luce che tutto rischiara (un’immagine analoga, ma di luce albeggiante era già presente nella prima poesia) e disvela le cose nella loro policromia, come “dono o cominciamento” di un tutto. Il poeta sembra in tal modo uscire dalla “selva oscura” dantesca.
Le sette poesie successive sono quelle dedicate ai luoghi percorsi nella costa tirrenica della sua terra, la Lucania, tutti paesaggi femminili bellissimi da incontrare, scoprire, contemplare, annusare, sfiorare, amare. C’è un amore del poeta verso queste spiagge lambite dal mare che diventa non solo colloquio intimo e personale con esse, ma soprattutto adesione totale di corpo e anima verso l’origine di ciò che è stato creato.
Sotto un sole che scalda fino a screpolare la “spalla dei canneti”, “Acquafredda” si stende in tutta la sua bellezza sensuale: “le gambe distese, /il crepuscolo delle palpebre/e il seno nudo della sabbia, separato dal vento/sullo smalto flesso”. La bellezza corporea del paesaggio-donna attraversa l’io lirico e lo trascende fino alla contemplazione dell’”argento di baia”, delle spiagge come strofe poetiche e delle “calligrafie delle maree”. Qui è evidente come la visione della Natura in Galgano si pone nettamente in antitesi con quella di Leopardi nel Dialogo della Natura e di un Islandese.
“Cersuta, la donna curcuma” è invece il paesaggio-donna lunare che instilla il desiderio d’amore nell’animo (“La falce delle lune marine/ha faville di sete). Un “nardo d’acqua” rivela l’anima lieve del luogo, mentre le sue rocce scure raccontano la storia della loro conformazione come croste di sangue rappreso, il mistero della vita come nascita e morte, ascesa e caduta (“il mistero/ del fiorire e del cadere”) in un ciclo perenne.
La luna del pastore errante leopardiano non è mai stata tanto vicina e amica quanto nell’io lirico di Galgano, altrettanto errante. Il paesaggio lunare, infatti, continua “Verso Castrocucco” con il suo “novilunio di acqua limpida” nel ricordo di una notte trascorsa dal poeta in compagnia della persona amata. Gli isolotti di scogli somigliano a una “veste di mare sfogliato” e le sere d’estate si ricoprono di veli leggeri come nella località di “Fiumicello”, dove il velo remoto dell’estate è “il lembo delle fiamme di Venere”, mentre tremano gli amanti nell’abbraccio della loro “deriva riarsa”.
“Cala Grande (Macarro)” è ancora una poesia della rimembranza, il paradiso perduto e ritrovato tra le “pinete scoscese” e il profumo di mirto portato nell’aria dal vento caldo dello scirocco, tra le spiagge laviche e roventi del luogo. Il nostos dell’autore è desiderio di recuperare la felicità perduta nel “cupo oblio delle onde” generate dalla luna e racchiusa all’interno di una splendida pietra simbolica, il diaspro, che con la sua durezza minerale corrobora la fragilità umana che intanto si perde nei suoi “fragili raggi” tra le insenature della costa.
Le spiagge nere dello straordinario lembo lucano accolgono il viandante a “Cala Jannita”, dove la visione dell’isola di Santo Janni restituisce un’immagine che non rasserena, “come un duomo nudo/di roccia violata”, mentre la spiaggia diventa “Chimera /che scioglie/ il fasto di onde a gradini/ sul congedo di ogni oscurità”.
La visione si apre e si riempie di sole e di luce quando si giunge a “Maratea”, città raffinata e omaggiata dai fiori dei balconi, labirintica nei suoi dedali di strade, segnata dal tempo e dalle calamità naturali, tra le “tende desuete/ la scala delle logge e dei portali” e i vicoli ancora cosparsi di cenere nera. La forza erosiva del sale non vince sui soliloqui d’amore davanti alle porte aperte delle case silenziose e segrete come le absidi delle chiese. Maratea è l’emblema della resistenza dei canneti: i versi del poeta qui diventano “canto”, d’amore e di bellezza, autodifesa dalla distruzione del Tempo e della Materia.
Con “Maratea” il canto del poeta è ormai stillato come acqua di sorgente e “Oltre il fiume”, la decima poesia della raccolta, rappresenta una sorta di spartiacque tra ciò che di scomposto si è rivelato alle origini e ciò che adesso si presenta più strutturato. Le dieci poesie successive sono dedicate a strade e a città dove l’esperienza umana del poeta si è formata ed è diventata consapevolezza poetica, ma sempre accompagnata da una figura amante e amata, una presenza che lo accompagna.
[…]
“Ricordi quando digradava
la nostra mano
non vogliono morire questi canneti
scaldati dai lidi
sul corpo delle pietraie”
[…]
Di fronte alla ferocia della forza distruttiva del Tempo, che piega le “colonne porpora” al tepore del cielo, incide di rosso la linea del volo dei gabbiani e “strema il tramonto” già spoglio sulle correnti, resta il ricordo della “nostra mano”, capace di plasmare il mondo, e la visione struggente della resistenza dei canneti, in social catena come la ginestra tanto amata da Leopardi.
Le dieci poesie successive sono cartografie di paesaggi antropici, luoghi che insegnano all’uomo come resistere e durare nel tempo, in armonico e simbiotico rapporto con la Natura, esercitando i cinque sensi per la comprensione della realtà sensibile a cui appartiene.
“Livorno” è un’“anima terrazza” con “balaustre e scacchi di albe”; “Il sole di Salerno” ride al mattino rischiarando il porto con i suoi giacinti e la facciata del duomo. La costiera lascia il posto ai viali, al lungomare, “alle bitte e agli intonaci stinti”. Le luci del treno si muovono rapide e rischiarano i luoghi circostanti riflettendosi nell’acqua del mare.
“Rimini” d’estate è un felice connubio di spiagge, di darsene e “moli trasparenti”; i lettini dei lidi si gonfiano di pioggia mentre i gabbiani si levano in volo, le luci dei litorali, dove passeggiano le donne scollate, accendono di desiderio i cuori innamorati.
“Marsiglia” non è solo porti e traghetti: profuma delle tante varietà dei suoi fiori e dona scorci dai mille colori.
A “Paestum” si sente il richiamo all’antico tra le baie di “malta romana e giallo indiano”. La frescura della sera cala come una preghiera tra le rondini in volo “illese/come loquele”.
Le due successive poesie sono riservate a Firenze. La prima, “Via Gioberti” è una strada poetica attraversata da meravigliose assonanze, parole che sembrano richiamarsi a vicenda come passanti.
“L’anagrafe del sole
è il sale della luce
nell’estate delle rondini
o quando le ali di freddo come cortili
sfiorano le persiane”.
Particolari sinestesie si legano invece alla visione del cielo, che di notte strepita di stelle e di mattina si tinge di rosa appena accennato, mentre sulla strada si riversano gli uomini con le loro storie fatte di sguardi di donne che rimescolano antiche ferite e di desiderio di tenerezza nell’intimità inviolabile della casa.
Nella “Via Panzani”, invece, a dominare sono oggetti legati al vetro e al cristallo in un raffinato gioco di luce filtrata e di riflessi come promesse future.
“Monopoli” è un nuovo gioco di luci e colori, un omaggio alle tele di Edward Hopper, esponente di quel realismo americano dove la vivacità dei colori brillanti viene stemperata dalle note struggenti di ciò che si prova: un forte senso di solitudine e d’inquietudine.
“Le inclinazioni dei litorali
le tinte dei tavolati
occhio abraso e mercurio
sulle statue serali
acque selci che assiepano
i pavimenti
dei muri scrostati”
[…].
Merita infine un’attenzione particolare la poesia dedicata a Potenza, città delle origini del poeta. In “Via del popolo”, infatti, aleggia un’atmosfera densa di baci, ricordi, case e muri familiari, campagne in lontananza, pensieri che s’involano nella routine quotidiana delle macchine in difficoltà di transito nelle strettoie, striature dei marciapiedi come consolazione di errori nel tempo. Non manca la visione dei cortili in preda alle bufere e ricordi legati alle estati sui balconi o alle grida nelle sere tra i portoni. C’è la vita di tutti i viandanti, passata, presente e futura, lungo questa strada che attraversa lo spazio ed il tempo.
Je suis un autre
Rainer Maria Rilke in Quaderni di Malte Laurids Brigge[2] scrive:
<<I versi, sono esperienze. Per scriverne anche uno soltanto, occorre aver prima veduto molte città, molti uomini, molte cose. Occorre conoscere a fondo gli animali; sentire il volo degli uccelli; sapere i gesti dei piccoli fiori, quando si schiudono all’alba. Occorre poter ripensare a sentieri dispersi in contrade sconosciute, a incontri inattesi; a partenze a lungo presentite imminenti; a lontani tempi d’infanzia ravvolti tutt’ora nel mistero; al padre e alla madre, che eravamo costretti a ferire quando ci porgevano una gioia immensa incompresa da noi perché fatta per altri; alle malattie di puerizia, che così stranamente si manifestavano, con tante e sì profonde e gravi metamorfosi; a giorni trascorsi in stanze e silenziose e raccolte; a mattini sulla riva del mare; a tutti gli oceani; a notti di viaggio che scorrevano altissime via, volando sonore con tutte le stelle. E non basta. Occorre poter ricordare molte notti d’amore, sofferte e godute; e l’una, dall’altra, diversa; grida di partorienti; lievi e bianche puerpere che risarcivano in sogno la ferita. Occorre aver assistito moribondi; aver vegliato lunghe ore accanto ai morti, nelle camere ardenti, con le finestre chiuse e i rumori che v’entravano a flutti. E anche ricordare, non basta. Occorre saper dimenticare i ricordi, quando siano numerosi; possedere la grande pazienza di attendere che ritornino. Perché i ricordi, in sé, non sono ancora poesia. Solo quando diventano in noi sangue, sguardo, gesto; quando non hanno più nome e più non si distinguono dall’essere nostro, solo allora può avvenire che in un attimo rarissimo di grazia dal loro folto prorompa e si levi la prima parola di un verso>>.
Le poesie di Andrea Galgano riflettono in pieno il pensiero di Rilke. Le Cartografie sono la mappatura delle esperienze sensoriali che il poeta compie per comprendere l’essenza di sé e gli permettono di compiere il secondo passo cui l’uomo è chiamato nella sua esistenza: aprirsi nei confronti dell’esterno, del reale inteso come Altro e Altrove. Questo comporta un decentramento di sé e un compimento attraverso l’incontro dialettico con l’Altro. Di qui lo stravolgimento della frase di Artur Rimbaud come titolo della seconda sezione del libro: “Je suis un autre” e non “Je est un autre”. L’io esistenziale, che è frammentato nel magma primordiale della Creazione, si ricompone proprio riconoscendosi nel sé in quanto Altro.
Scrive a proposito Lorenza Colicigno in “Talenti lucani”[3]:
Nella seconda parte del libro, “Je suis un autre”, Galgano confronta la sua solitudine con compagni di viaggio che sceglie diversi tanto quanto consente l’ampiezza del campo di gioco della vita, allora la solitudine si fa ansia di dialogo, di reciproco riconoscimento”.
Io credo invece che tutte le sensazioni provate da Andrea in precedenza siano diventate adesso sentimento: l’io riesce a sentire amore, solitudine, paura, compassione, speranza, fede negli altri e ritrova sé stesso nell’incontro con il loro essere più puro e profondo. Questo gli permette di ritrovarsi come canna mossa dal vento in mezzo a un canneto dove si può resistere alla morte soltanto se si rimane stretti gli uni con gli altri, nella comprensione e nel sostegno reciproco.
Alcune poesie sono dedicate a personaggi famosi che sono morti lasciando nei cuori un vuoto incolmabile e il ricordo indelebile di ciò che di bello hanno saputo creare e donare. Galgano riesce a cogliere in loro l’essenza più nascosta e misteriosa dell’anima traducendola in versi. In intimo colloquio con loro, come Dante e i suoi personaggi o Leopardi con Silvia, si pone in ascolto delle loro parole segrete, ne interpreta sguardi e gesti, pone loro domande di senso, riflette e apre orizzonti di meditazione al lettore.
L’animo schivo e discreto di Andrea va alla ricerca di chi ha vissuto il suo passaggio terreno con la stessa umiltà e discrezione, come Massimo Troisi, Enzo Jannacci, Pino Mango e Paolo Villaggio che hanno sempre lavorato in religioso silenzio, mettendo la loro arte in ascolto dell’Altro. Autori che sono stati capaci di trasformare le ferite dell’umanità in Memoria e Bellezza.
A Troisi, attore e regista che ha saputo mettere in scena “l’amore che si sbaglia: e poi ritorna”, domanda:
“Dimmi Massimo, questo caldo bagliore
che sgretola le ruggini degli angiporti
o delle macchine
è striatura di labbra?”
Soltanto l’Amore può ridare luce al dolore e significato alla gioia. Ed Enzo Jannacci scriveva canzoni per questo, con “le lacrime che parlano con le matite”, calzando “le scarpe nelle ferite” e indossando “sciarpe dei colori/calpestati di gioia”.
Più solare di Jannacci si rivela invece Pino Mango, cantante e compositore lucano come Galgano, con il quale Andrea condivide l’adesione totale, pura e sincera con la natura come fonte generatrice di senso e di vita. L’amore sensuale di Mango si traduce in dolci parole e melodie “che smagliano il bilico/dell’anima nei suoi capitoli”, disvelando in questo mondo corporeo “ciò che per l’universo si squaderna” nella dimensione trascendentale del Paradiso di Dante.
La dimensione terrena come limite umano è un tratto importante della cinematografia di Paolo Villaggio, autore a cui Galgano si accosta con un sentimento di misericordia, posando gli occhi sul buffo copricapo di Fantozzi, allo stesso modo con cui l’attore velava con un sorriso la miseria umana di fronte alle avversità.
Un discorso a parte meritano invece le poesie di Andrea dedicate ai fari di luce morale e spirituale della sua vita. Oltre allo zio evocato in “Via Lilio” nella precedente sezione, il poeta ha tre figure importanti a cui rivolgersi sempre: gli zii Anna Antonia e Michele, e don Luigi Giussani.
Non mancano appelli a personaggi mitici ancora viventi, come Paolo Maldini e Mel Gibson che hanno incarnato per molti della generazione di Andrea valori come il coraggio, il rispetto, la dedizione al lavoro, la fede, la capacità di sognare in grande e di sapersi rialzare nelle inevitabili cadute della vita.
C’è un componimento che rimane in un certo senso isolato dai modelli delle poesie precedenti, “Mancusedda”, una donna a sua volta isolata dalla cattiveria del mondo per il suo aspetto esteriore e la sua semplicità, morta tragicamente anzitempo. Andrea la fa rivivere in un dolce ricordo, guardandola con gli occhi del cuore, quasi levando a Dio una preghiera perché quest’angelo possa adesso riposare al Suo fianco:
“[…]
non finirà
il tuo scampato numero
che non è più solo, non ha bisogno
di camminare,
di poggiare le mani
avute l’una sull’altra
giunte nella vertigine di Dio”.
Quando la vita è un cammino consapevole, come quello tracciato da Galgano fino a questo momento, le direzioni intraprese diventano destinazioni, “Meridiani nel vento”, come il titolo della tredicesima poesia della seconda sezione della raccolta.
“Non conoscevo ancora
l’estate del vento
le tende come meridiani
allora la mia voce era pioggia
senza vederla
la notte delle angurie
come clessidre”.
“Meridiani nel vento” è un’altra poesia spartiacque, come “Oltre il fiume” nella prima sezione. E’ la linea di longitudine immaginaria che s’interseca con tutte quelle parallele che incontra nel suo cammino, la metafora dell’incontro con quel “Tu” vivente capace di farci non solo provare il sentimento, ma soprattutto l’esperienza dell’amore, quel passaggio vitale che fa passare il poeta all’uso sempre più frequente del “noi” e del “nostro”. Le poesie che seguono a questa sono infatti narrazioni retrospettive dei primi sguardi e baci adolescenziali, i tremori, i sogni comuni, fino al raggiungimento dell’amore maturo, con il quale è davvero possibile aggrapparsi alla vita come canna mossa dal vento:
In “Partenza riflessa” c’è tutto il compimento del sé nell’Altro, l’amore come abbandono felice, donazione totale:
“[…]
dirsi mani aperte
il granello che freme sui seni
sa essere altare di eco
e tramontana
sulle penisole azzurre
e aprire i sensi
è una partenza riflessa”.
Algoritmi
Il nostro Rainer Maria Rilke profetizza un futuro redento in Lettere a un giovane poeta[4]:
<<Un giorno […] esisterà la fanciulla e la donna, il cui nome non significherà più soltanto un contrapposto al maschile, ma qualcosa per sé, qualcosa per cui non si penserà a complemento e confine, ma solo a vita reale: l’umanità femminile.
Questo progresso trasformerà l’esperienza dell’amore, che ora è piena d’errore, la muterà dal fondo, la riplasmerà in una relazione intesa da uomo a uomo non più da maschio a femmina. E questo più umano amore somiglierà a quello che noi con lotta faticosa prepariamo, all’amore che in questo consiste, che due solitudini si custodiscano, delimitino e salutino a vicenda>>.
Andrea Galgano abbraccia questa speranza e ne compone gli algoritmi per la resistenza alla morte: “chiudere i tuoi occhi/è radunare il sole/prima delle cene” (“Tortora, Estate”).
Le illusioni non salvano l’uomo, soltanto l’amore può farlo:
“Il taglio del nudo mondo
ci insegue
nei muri spezzati
è grazia
è terra”.
[1] Rilke R.M., Lettere milanesi, Mondadori 1956
[2] Rilke R.M.,Quaderni di Malte Laurids Brigge, Garzanti 2014
[3] Colicigno L., Andrea Galgano “Non vogliono morire questi canneti”, in https://www.talentilucani.it/cronache-di-carta-viaggio-nelluniverso-della-scrittura/
[4] Rilke R.M,, Lettere a un giovane poeta, Adelphi Edizioni 1980
Andrea Galgano, Non vogliono morire questi canneti, Capire Edizioni 2019.