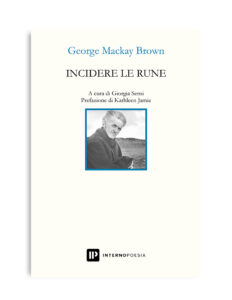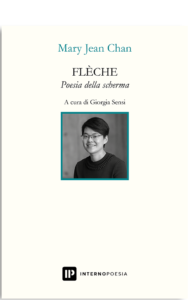Traduzione di Emanuele Emma e Chiara Ciccolella
 Molly McCully Brown è l’autrice della raccolta di saggi Places I’ve Taken my Body pubblicata negli Stati Uniti nel giugno 2020 da Persea Books e nel Regno Unito nel marzo 2021 da Faber & Faber e della raccolta di poesie The Virginia State Colony For Epileptics and Feebleminded (Persea Books, 2017), che ha vinto il Lexi Rudnitsky First Book Prize nel 2016 ed è stata nominata tra i migliori libri del 2017 dai critici del New York Times. Insieme a Susannah Nevison, è anche coautrice della raccolta di poesie In The Field Between Us (Persea Books, 2020).Brown è stata destinataria della Amy Lowell Poetry Traveling Scholarship, della United States Artists Fellowship, Civitella Ranieri Foundation Fellowship e della Jeff Baskin Writers Fellowship dell’Oxford American magazine. Le sue poesie e i suoi saggi sono apparsi su The Paris Review, Tin House, The Guardian, Virginia Quarterly Review, The New York Times, The Yale Review e in magazine minori. Cresciuta nella Virginia rurale, si è laureata al Bard College at Simon’s Rock, alla Stanford University e all’Università del Mississippi, dove ha conseguito il suo MFA. Vive e insegna a Laramie, Wyoming, dove è direttrice del programma di scrittura creativa presso l’Università del Wyoming.
Molly McCully Brown è l’autrice della raccolta di saggi Places I’ve Taken my Body pubblicata negli Stati Uniti nel giugno 2020 da Persea Books e nel Regno Unito nel marzo 2021 da Faber & Faber e della raccolta di poesie The Virginia State Colony For Epileptics and Feebleminded (Persea Books, 2017), che ha vinto il Lexi Rudnitsky First Book Prize nel 2016 ed è stata nominata tra i migliori libri del 2017 dai critici del New York Times. Insieme a Susannah Nevison, è anche coautrice della raccolta di poesie In The Field Between Us (Persea Books, 2020).Brown è stata destinataria della Amy Lowell Poetry Traveling Scholarship, della United States Artists Fellowship, Civitella Ranieri Foundation Fellowship e della Jeff Baskin Writers Fellowship dell’Oxford American magazine. Le sue poesie e i suoi saggi sono apparsi su The Paris Review, Tin House, The Guardian, Virginia Quarterly Review, The New York Times, The Yale Review e in magazine minori. Cresciuta nella Virginia rurale, si è laureata al Bard College at Simon’s Rock, alla Stanford University e all’Università del Mississippi, dove ha conseguito il suo MFA. Vive e insegna a Laramie, Wyoming, dove è direttrice del programma di scrittura creativa presso l’Università del Wyoming.
AFTER ALL (EVERYTHING)
this morning I wake up and for a moment I think the visions have vanished
then I realize everything is shaded green the visions have alit like luna moths
around the dormitory on the doorframe and the table and the face
of every sleeping girl when I blow out my breath they travel noiselessly into the air
I pass an hour like this this is what no one tells you about suffering
sometimes you would not give it up for all the world
DOPOTUTTO (TUTTO)
questa mattina mi sveglio e per un momento penso le visioni sono scomparse
dopodiché realizzo che tutto è ombrato di verde le visioni sono atterrate come falene luna
intorno al dormitorio sugli stipiti della porta e sul tavolo e sul viso
di ogni ragazza addormentata quando esalo il mio respiro viaggiano senza far rumore nell’ aria
passo un’ora così questo è quello che nessuno ti dice della sofferenza
a volte non ci rinunceresti per nulla al mondo
Transubstantiation
It’s the middle of the night. I’m just a little loose on beer,
and blues,
and battered air, and all the ways this nowhere looks like
home:
the fields and boarded houses dead with summer, the
filling station rowdy
with the rumor of another place. Cattle pace the distance
between road
and gloaming, inexplicably awake. And then, the
bathtubs littered in the pasture,
for sale or salvage, or some secret labor stranger than I
know. How does it work,
again, the alchemy that shapes them briefly into boats, and then the bones
of great felled beasts, and once more into keening copper
bells, before
I even blink? Half a mile out, the city builds back up
along the margin.
Country songs cut in and out of static on the radio. Lord,
most of what I love
mistakes itself for nothing.
Transubstanziazione
È notte tarda. Sono soltanto un po’ sciolta dalla birra,
e il blues,
e dall’aria maltrattata, e da tutti i modi in cui questo niente assomiglia
a casa:
i campi e le pensioni morte con l’estate,
la stazione di servizio ricolma
del brusio di un altro posto. Il bestiame scandisce la distanza
tra la strada
e l’imbrunire, inspiegabilmente desto. E poi, le vasche da bagno
abbandonate nella radura,
da vendere o da riparare, o per farci qualche lavoro segreto più strano di quel che io
sappia. Come funziona,
ancora, l’alchemia che le trasforma brevemente in barche,
e poi le ossa
di grandi bestie abbattute, e poi di nuovo in campane ramate
disperanti, prima
ancora che io possa batter ciglio? Mezzo miglio più in là, la città si ricostruisce lungo
il margine.
Canzoni country vanno e vengono dall’interferenza della radio. Signore mio,
quasi tutto quel che amo
è in torto nel credersi effimero.
Virginia, Autumn
October, I’m dragging the dog away from perfect birds lifeless on the pavement. By the water, boys in dress blues with bayonets, the blistered hulls of boxships. Everything is sunshine. Everything is dead, or dying, and this isn’t a new thought. I grew up here, but farther from the ocean. Each April, they took us to the battlefield, marched us in schoolhouse lines up courthouse steps: here is where the war ended. Never mind that it was fall before the final battleship lowered its flag; never mind that we still haven’t fired the last gun. What business do I have wanting a baby here: in this body where I can’t keep my balance, this country where we can’t keep anything alive that needs us, or dares not to, not even the switchgrass pale and starved for groundwater? And still, I do want. I search the news for mention of the birds, whatever poison or disease I’m sure is claiming them in such great numbers: meadowlarks, house wrens, chickadees, starlings. Once even a gray gull, pulled open at the chest before we found him, hollowed of his organs. It takes a long time—too long— for me to understand the sun in this season is blinding, and the birds are flying into windows all around me, fourteen stories up. Flying into glass and falling. What we love is rarely blameless. Is it a failure that I wouldn’t trade this brightness? I imagine pointing upward for my daughter: Look, there, how it catches in the changing trees.
Virginia, Autunno
Ottobre, sto trascinando il cane via dai perfetti uccelli senza vita sul marciapiede. A riva, ragazzi in divisa blu con le baionette, lo scafo piagato delle navi cargo. Ogni cosa è luce. Ogni cosa è morta, o morente, e questo non è un pensiero nuovo. Sono cresciuta qui, ma più lontana dall’oceano. Ogni aprile, ci portavano al fronte, ci facevano marciare in fila indiana sui gradini del tribunale: qui è dove è finita la guerra. Non importa che fosse ancora autunno prima che l’ultima corazzata abbassasse la sua bandiera; non importa se non abbiamo ancora sparato l’ultimo proiettile. Che diritto ho io di volere un bambino qui: in questo corpo in cui non riesco a mantenere l’equilibrio, questo paese in cui non siamo in grado di sostentare ciò che ha bisogno di noi, o che osa non averne, neppure la gramigna pallida e affamata di acqua dal terreno? Eppure, io lo voglio. Cerco nel giornale notizie sugli uccelli, su qualsivoglia veleno o malattia sono sicura li stia portando via in gran numero: allodole, scriccioli, cince, storni. Una volta persino un gabbiano grigio, squarciato in petto prima che lo trovassimo, vuotato dei suoi organi. Mi ci vuole tanto tempo- troppo tempo- per capire che il sole in questa stagione è accecante, e gli uccelli volano contro le finestre intorno a me, al quattordicesimo piano. Volano contro il vetro e cadono. Quel che amiamo è raramente senza colpa. Mi sbaglio a non voler rinunciare a questa luce? Mi immagino di indicare il cielo per mia figlia: guarda, là, come si intrappola tra gli alberi che mutano.