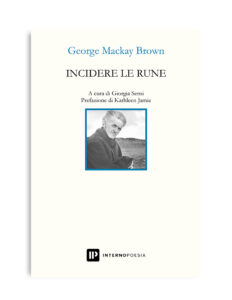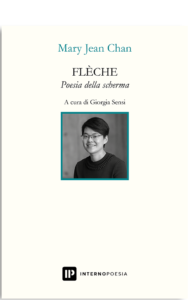Traduzione di Emanuele Emma e Chiara Ciccolella
Brown: Harry Crews: Mentore ed Amico
Biografia
Larry Brown (9 luglio 1951 – 24 novembre 2004) è stato un romanziere americano, scrittore di non-fiction e di racconti brevi . Ha vinto numerosi premi, tra cui il Mississippi Institute of Arts and Letters award for fiction, il Lila Wallace-Reader’s Digest Award e il Governor’s Award For Excellence in the Arts del Mississippi. È stato anche il primo a vincere due volte il Southern Book Award for Fiction.Tra le sue opere più importanti ci sono Dirty Work, Fay, Joe, Father and Son e Big Bad Love. Quest’ultimo è stato adattato per un film omonimo nel 2001 , interpretato da Debra Winger e Arliss Howard. Nel 2013 è stata rilasciata una versione cinematografica di Joe, con Nicolas Cage. Il regista indipendente Gary Hawkins, scrittore della sceneggiatura di Joe, ha diretto nel 2002 un documentario pluripremiato sulla vita e il lavoro di Brown intitolato The Rough South of Larry Brown. In italiano è stato tradotto da Mattioli con 92 GIORNI, uno dei suoi racconto più celebri. Il saggio seguente è tratto dalla raccolta Billy Ray’s Farm: Essays from a Place Called Tula ed è dedicato al leggendario Harry Crews, uno degli scrittori più importanti e rappresentativi del gotico sudista del secondo novecento.
Harry Crews: Mentore ed Amico
Leggo Harry Crews da così tanto tempo che non ricordo esattamente quando scoprii per la prima volta il suo lavoro. Fu probabilmente tempo addietro in qualche anno immemore vicino al periodo in cui iniziai a scrivere, ovvero nel 1980. Ricordo che il mio amico e cugino, Paul Hipp, venne a trovarmi un pomeriggio quando mia moglie, i bambini ed io vivevamo a casa con mia suocera. Aveva in mano una copia tascabile de La Fiera dei Serpenti, e me la prestò. Ricordo che ero seduto a leggerla sul dondolo in veranda. I miei figli erano piccoli all’ epoca, Billy Ray aveva tre o quattro anni, Shane era soltanto un infante, LeAnne non era ancora nata. Ricordo come quel libro mi commosse, mi scosse e mi inchiodò. Non avevo mai letto nulla di simile e non sapevo che si potessero fare cose del genere in un libro. Non sapevo che un uomo potesse inventare personaggi come Joe Lon Mackey, o sua sorella, Beeder, o Buddy Matlow, lo sceriffo con la gamba di legno. Era una combinazione di ilarità e cruda realtà e bellezza e tristezza. Dall’epoca l’ho letto diverse volte, e come tutti i grandi libri diventa migliore ad ogni lettura.
Avevo già visto qualche suo saggio in riviste come Playboy ed Esquire, e ad un certo punto andai nella nascente libreria di Richard Howorth ad Oxford e comprai una raccolta di saggi chiamata Florida Frenzy, nella libreria diedi un’occhiata ad un libro chiamato Blood and Grits, e ad un altro intitolato Un’Infanzia. Fui stupito dalla sua scrittura, dalle storie della sua vita, dalla sua infanzia e dalle sue fatiche nel diventare uno scrittore, dai luoghi in cui fosse stato e dalle cose che avesse fatto. I suoi romanzi erano difficili da reperire. La libreria pubblica ne aveva un paio, The Gypsy’s Curse and The Hawk Is Dying. Li lessi entrambi e li amai, ma non riuscii a trovare altra sua fiction. Sapevo che ci fosse da qualche parte, ma nessuno sembrava sapere dove.
Non ricordo quanto tempo impiegai a leggerlo, ma stavo provando a scrivere a quel tempo. Stavo cercando di trovare dei mentori, scrittori i cui lavori potessi ammirare e da cui potessi trarne ispirazione. Volevo leggere il resto di quei titoli, romanzi citati nelle prime pagine degli altri suoi libri, romanzi con titoli come Karate Is a Thing of the Spirit, Naked in Garden Hills, This Thing Don’t Lead to Heaven, Car, The Gospel Singer.
Andai alla ricerca di una biblioteca più grande e la trovai all’ Università del Mississippi. Imparai di nuovo come usare il catalogo della biblioteca, e dopodiché, armato con un pezzo di carta su cui avevo scarabocchiato lettere e numeri, iniziai ad aggirarmi tra le pile di libri. E iniziai a trovare i titoli. La maggior parte dei quali erano là, senza sovracopertina, e li presi in prestito, li portai a casa e li lessi. Car fu pubblicato in edizione tascabile e lo comprai, e
quando The Gospel Singer venne finalmente ripubblicato nel 1988, lo comprai. Quando libri più recenti vennero fuori, come The Knockout Artist e All We Need of Hell e Lucidi Corpi e Scar Lover e The Mulching of America, li comprai. Ho letto o comprato tutto ciò che sono riuscito a procurarmi , e sono grato che uno scrittore come lui cammini su questa terra.
Nel1985 avevo scritto cinque romanzi inediti e quasi un centinaio di racconti brevi che giacevano indesiderati. Vendetti una storia ad Easyriders, una al Fictional International, ed una ad una rivista di New York, ormai scomparsa, chiamata Twilight Zone. Avevo ormai imparato che il prezzo del successo per uno scrittore è alto, che ci fossero anni di una cosa chiamata il periodo di praticantato, e che nessuno ti avrebbe avvisato su quando sarebbe finito. Dovevi soltanto continuare a scrivere con fede cieca, e speranza, e credere in te stesso che con il tempo avresti trovato la tua strada, che il mondo un giorno avrebbe accettato il tuo lavoro.
Ogni qualvolta cadevo in un periodo oscuro di depressione, il che avveniva abbastanza spesso, potevo prendere una raccolta dei saggi di Harry e leggere di nuovo di quel che aveva passato, di come avesse lavorato per anni senza successo. Era confortante in un qualche modo sapere che un uomo del suo calibro non fosse nato con questo talento, ma lo avesse coltivato, e avesse posseduto la perseveranza, la testardaggine, il carattere, o qualsiasi cosa fosse che possedeva per permettergli di non arrendersi di fronte ai rifiuti. Lessi anche di quanto avesse perso: la sua famiglia, uno dei suoi figli. Non si lamentò mai di quanto fosse stato duro. Non disse mai quanto difficile fosse mettere giù le parole. Quel che invece disse fu che dovevi tenere il culo sulla sedia. Anche se non riusciva a scrivere niente un giorno, se niente sarebbe venuto in quella seduta in particolare, si sarebbe lo stesso forzato di sedersi sulla sedia per tre ore. Sapevo che nel tempo in cui era ancora inedito, doveva aver desiderato il successo tanto quanto me . Ed io ero tremendamente rincuorato nel leggere queste cose. Significava che non ero l’unica persona che avesse passato quel che io stessi sopportando, che fosse probabilmente un’ esperienza universale, questo periodo di praticantato, questo tempo in cui scrivevi cose di scarsa qualità solo per buttarle via o per vederle rifiutate in modo tale da scrivere abbastanza da imparare come farlo.
Bruciai uno dei miei romanzi nel giardino dietro casa. Collezionai le mie lettere di rifiuto e le conservai in una logora busta di manila gialla. Continuai a scrivere, e a sperare, e provare a fare di meglio. Facevo turni da ventiquattro ore ai vigili del fuoco di Oxford dieci giorni al mese, e negli altri giorni martellavo chiodi, imbustavo la spesa altrui, pulivo tappeti, facevo qualsiasi cosa fosse necessaria per fare qualche dollaro in più per sfamare la mia famiglia in
crescita, riscaldare la casa e pagare le bollette che tutti abbiamo. Nei fine settimana o per qualche ora di notte andavo in cucina e provavo a scrivere qualcosa che avesse un senso. Continuavo a scrivere storie, ed avevo iniziato un altro romanzo. Quell’anno scrissi una storia su un uomo e una donna seduti nella loro camera da letto a guardare Ray Milland in Nei Giorni Perduti. Fu un punto di svolta per me quella storia. Tutto ciò che avevo scritto e buttato via negli anni passati mi aveva portato a scrivere quel racconto, chiamato Facing the Music. A quel punto avevo trovato altri mentori, altri modelli guida: William Faulkner, Flannery O’Connor, Raymond Carver, Cormac McCarthy, e Charles Bukowski. Insieme a Harry Crews erano gli scrittori che ammiravo di più, e che ammiro tuttora.
Due anni dopo mi fu offerto un contratto per dieci storie, gliele mandai, e il libro fu accettato, e il mio periodo di praticandato era finalmente terminato, dopo sette anni. Quello di Harry ne durò dieci, il che non mi era sfuggito. Quando la mia editrice mi chiese di proporle alcuni scrittori a cui poter inviare bozze per dei trafiletti pubblicitari, io nominai i miei amici del Mississippi Barry Hannah, Ellen Douglas, Jack Butler e Willie Morris. E le chiesi di inviare una bozza anche ad Harry Crews.
Passò un po’ di tempo, le bozze uscirono e cominciarono ad arrivare i trafiletti. La mia editrice me li mandava man mano che arrivavano, ed eravamo soddisfatti di averli. E poi un giorno mi inviò una cartolina postale che le era stata recapitata da Harry Crews, ed anche lui aveva risposto gentilmente e positivamente. Ero grato a lui e ad i miei amici. Ma non pensai mai di provare a scrivergli e ringraziarlo. Presumevo che fosse un uomo impegnato, e non volevo disturbarlo. Lo tenevo in così alta stima , e rispettavo lui e il suo lavoro così tanto, che pensavo sarebbe stato meglio essergli riconoscente a distanza, e non provare ad intrudermi nella sua vita. Continuai a scrivere, così come fece Harry. Continuai a comprare i suoi libri quando uscivano. Pubblicai il mio primo romanzo, e continuai a scrivere storie, e nel 1990 Algonquin pubblicò la mia seconda raccolta. Fu nell’ottobre di quell’ anno che lessi una recensione di Big Bad Love che Harry Crews scrisse sul Los Angeles Times. La recensione era buona ed ero veramente felice di vederla, ma quel che mi sorprese fu ciò che disse sul mio primo romanzo: in venticinque anni di scrittura era la prima volta che avesse preso il telefono e provato a chiamare l’autore. Non era stato in grado di contattarmi, ma decisi che gli avrei scritto, e lo avrei ringraziato per le cose che aveva fatto per me, e avrei provato a raccontargli quanto avessi ammirato il suo lavoro nel corso degli anni e quanto questo avesse significato per me durante i miei sforzi nel diventare uno scrittore. Ottenni il suo indirizzo dalla mia editrice, scrissi la lettera e gliela mandai, qualche tempo dopo, un
sabato pomeriggio in cui stavo lavorando seduto nella mia stanza, il telefono squillò, ed era lui. Penso che parlammo per almeno un’ora e mezza, e dopodiché iniziammo a scriverci per corrispondenza. Parlammo delle nostre vite, dei cani, del bere, delle donne, di ogni cosa. Una volta ogni tanto lo chiamavo e lui faceva lo stesso. Infine, organizzò un reading all’Università della Florida e offrì di ospitarmi per un paio di giorni, ed io accettai prontamente.
Era appoggiato ad una parete quando scesi dall’aereo a Gainesville, indossava un paio di jeans, scarpe da ginnastica, e una felpa con le maniche tagliate degli Oakland Raiders. I lati della testa erano rasati. Appena mi vide, si allontanò dal muro con scioltezza, mi tese la mano e ce la stringemmo. Era più alto di quanto avevo immaginato, davvero un uomo possente. Sulla spalla aveva un tatuaggio di un teschio, e disotto la scritta leggendaria:
How do you like
Your blue-eyed boy
now, Mr. Death?
Mi fece salire sul suo pickup nero ed iniziammo a parlare e non ci fermammo per diversi giorni. Mi portò a casa sua e scaricai la mia valigia e mi sistemò in una stanza in più che aveva. Mi aveva chiamato precedentemente per chiedermi che tipo di birra e whisky mi piacessero e mi aveva preparato una scorta di entrambi. Sedemmo e parlammo nel soggiorno per un po’, e fuori nel giardino sul retro, dove il suo terrazzo si affacciava su un terreno incolto. Il soggiorno era incassato rispetto al resto della casa, incontrai il suo vecchio cane, Heidi, e dopodiché mi portò fuori per mangiare qualcosa. Diedi un reading quella notte e non ricordo cosa lessi, ma il posto era affollato e lui mi presentò. Fu uno dei momenti più belli della mia vita. Più tardi quella notte sedemmo nel soggiorno e leggemmo l’uno all’altro altri brani dai libri ai quali stavamo lavorando. Il giorno dopo andai a lezione con lui, e quella notte diede una festa a casa sua in mio onore. Mi trattò come avrebbe fatto uno zio prediletto e mi disse che se avessi avuto bisogno di qualcosa, dovevo solo chiederlo. Il tempo assieme passò troppo in fretta, ma il solo fatto di aver potuto passare un po’ più di tempo con lui fu un grande regalo che non ho mai dimenticato. Abbiamo continuato a sentirci nel corso degli anni, e so che sta ancora lavorando, che non ha smesso di scrivere e che probabilmente non smetterà mai. Sono lieto di questo.
È importante avere persone da ammirare all’inizio della propria carriera. Devi cercare persone che hanno trovato la propria strada nel dire cose che tu stesso vuoi dire. Non è mai facile e ora credo che diventerà ancora più difficile tanto più si invecchia e più si scrive. Il praticante arriva alla cima lentamente, con molti inciampi ed imprecazioni, percorrendo costantemente strade a senso unico e partendo per tangenti che non portano da nessuna parte. L’incredibile quantità di cose che devono essere scritte e dopo buttate via è probabilmente quel che spaventa molti giovani scrittori. Non credo che lui abbia mai pensato di smettere. So certamente che io l’ho fatto, ma qualcosa mi ha fatto perseverare. Il merito fu in buona parte di Harry Crews. Sapere dei suoi duri primi anni mi fece capire che fosse possibile riuscire nel mio intento, e mi aprì gli occhi su quel che fosse richiesto. All’inizio pensavo che avrei scritto e spedito un romanzo via posta a New York, e che mi avrebbero risposto con un assegno da un milione di dollari, e mi ci vollero un paio di anni per scoprire che non funziona in questo modo. Ogni tanto capita un colpo di fortuna, ma chi inizia a scrivere letteratura si ritrova già con una bella gatta da pelare. Per sua stessa natura, la letteratura è la cosa più difficile da scrivere, perché gli standard sono molto alti, e a volte le ricompense sono misere. Probabilmente è quasi impossibile guadagnarsi da vivere solamente da questa, ammenoché’ tu non sia fortunato. Molti degli scrittori letterari che conosco insegnano da qualche parte e scrivono i loro libri tra una lezione e il lavoro sulle storie degli studenti. Harry lo fece per un lungo tempo, e lo feci io stesso, anche se non ho un’ istruzione avanzata e a malapena sono uscito dalla scuola superiore.
Tempo fa sentii che fosse andato finalmente in pensione, ma non avevo parlato con lui da un pezzo. L’ultima volta che lo vidi fu qualche anno fa, quando venne ad Oxford per leggere in libreria dal suo ultimo libro, The Mulching of America. Il mio amico Mark ed io lo guardammo scendere dall’aereo a Memphis, e lo aspettammo quando raggiunse la cima delle scale. Mi avvolse in un abbraccio da orso , mi sorrise e si strinse le mani con Mark dicendogli quanto gli fosse piaciuto il suo libro, e poi lo accompagnammo ad Oxford nel vecchio Caddy di Mark. Quella sera mi ubriacai un po’, e me ne pentii, ma mi disse in seguito in una lettera di dimenticarmi di quanto accaduto, che facesse parte del mestiere. Sapevo fosse sincero, e smisi di preoccuparmene. Ero soltanto onorato di poter passare ancora un po’ di tempo con lui.
Una volta, quando ero a Washington, D.C., per le prove di un adattamento teatrale di uno dei miei romanzi, avemmo una brutta giornata. Niente andava per il verso giusto, e le frasi erano sbagliate e tutti continuavano a scordare le proprie battute, tanto che il regista mandò tutti a casa in anticipo. La notte d’esordio non era così lontana, ed io scesi in una strada innevata verso un
negozio di liquori e presi una bottiglia di Wild Turkey, tornai nella mia camera d’hotel con il desiderio di sotterrarmici dentro. Un po’ più tardi recuperai il numero di Harry dalla mia valigetta e provai a chiamarlo, ma trovai la segreteria telefonica, quindi potei solo lasciargli un messaggio. Volevo dirgli quanto tutto stesse andando a rotoli, e chiedergli cosa dovessi fare. Non mi richiamò quella notte ma lo fece il mattino seguente, pieno di buon umore e di rassicurazioni. Mi raccontò delle prove del suo spettacolo a Louisville, e di come qualche volta le cose andassero terribilmente, ma come il tutto si risolse la notte prima del debutto, e mi fece sapere che la stessa cosa sarebbe successa a noi. E aveva ragione. Aggiustammo tutte le battute e gli attori diedero il meglio di sé, e lo spettacolo si congegnò come i pezzi di una scatola ad incastro finemente lavorata. Sapeva di cosa stesse parlando.
Se non avessi scritto alcun libro, non avrei mai conosciuto Harry Crews, né potrei considerarlo un amico. In un’attività che consiste nello stare da solo per la maggior parte del tempo, e lavorare con incertezza e talvolta con paura verso un risultato dubbio, le ricompense possono essere poche e rare, e proprio questo può fare indurre un uomo a dubitare della propria sanità mentale. Ma altri scrittori capiscono quello che stai facendo e quel che è necessario per farlo. E nulla importa se non il libro finito. Non importa quanta sofferenza ti costa. Non puoi lamentarti e piagnucolare, lo devi soltanto fare. Credo che probabilmente sia la lezione più preziosa che abbia imparato da Harry: fai il lavoro migliore che tu possa fare, a qualunque costo, qualsiasi sia il prezzo da pagare.