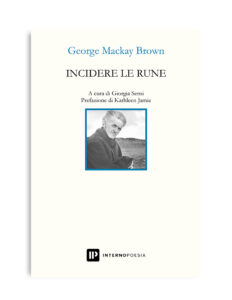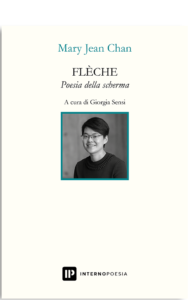di Andrea Galgano 14 maggio 2018
leggi in pdf KATHLEEN JAMIE E IL CENTRO DELLO SGUARDO DEL MONDO
 La compagnia più bella (The Bonniest Companie)[1] di Kathleen Jamie (1962), che ha vinto il Saltire Society Book of the Year e il Poetry Book of the Year, ed è stato ora edito da Medusa, nella elegante traduzione di Giorgia Sensi, consegna l’energia ciclica e immutata del mondo, il viaggio dello spazio naturale[2], la sottigliezza dei confini, che diventano agoni temporali e spostamenti memoriali che incidono la densità infranta del presente come gemme ibride, attingendo anche dagli eventi scozzesi referendari del 2014, che si sono conclusi con la vittoria del “No”.
La compagnia più bella (The Bonniest Companie)[1] di Kathleen Jamie (1962), che ha vinto il Saltire Society Book of the Year e il Poetry Book of the Year, ed è stato ora edito da Medusa, nella elegante traduzione di Giorgia Sensi, consegna l’energia ciclica e immutata del mondo, il viaggio dello spazio naturale[2], la sottigliezza dei confini, che diventano agoni temporali e spostamenti memoriali che incidono la densità infranta del presente come gemme ibride, attingendo anche dagli eventi scozzesi referendari del 2014, che si sono conclusi con la vittoria del “No”.
La poesia scorge, così, il confine liminale di lingua e affermazione. Nella sconfitta e nella terminalità rattrappita, il tempo della rinascita annulla ogni frantume, raccontando lo splendore numinoso della Scozia, il temporale come canto stregato, la ribellione dell’autunno e la madre persa negli occhiali:
«Dunque eccoci qua, / abbattuti e sfiniti, / ammantati di speranze in frantumi, / (un’onesta povertà). / Riposte le nostre bandiere, / le foglie secche di alberi striminziti / volano nelle piazze deserte, / e il vento / – foriero d’inverno – / / fruga fra le statue di granito / – e così via e eccetera. / Tutto ciò lo sappiamo. È martedì. Di nuovo in piedi. / Oggi si ricomincia» (23/9/2014).
Giorgia Sensi scrive:
«Il mondo naturale in The Bonniest Companie è, in genere, più familiare che in precedenti raccolte, meno selvaggio. Non ci sono balene e squali elefante ma cigni, un topo-ragno, aironi, falchi pescatori che lei stessa può osservare col binocolo dalla finestra della cucina, molti merli – il merlo della poesia “Merle” «è il centro dello sguardo del mondo», rondini e rondoni, e tanti altri (Jamie è un’esperta ornitologa). È significativa questa commistione di selvatico e domestico, di quotidiano, spesso presente all’interno di una stessa poesia. Per esempio in “The Heronry” la voce parlante, che in questo caso possiamo identificare con l’autrice stessa, in una giornata di febbraio decide di andare a vedere se gli aironi si sono già radunati nel solito posto non lontano da casa, prende la bicicletta e corre là, non prima, però di aver compiuto un gesto quotidiano e molto pratico, essere andata a comprare il giornale e il pane. […] Quello di Kathleen Jamie è un mondo naturale e in continuo movimento, ed è fonte di rinascita, di conoscenza».[3]
Unire la folgorazione naturale alla specifica dimensione quotidiana consente di precisare la luce di un cambiamento, il territorio identitario e il dramma di una demarcazione di corsa splendente e colpita. Vi è, in Kathleen Jamie, una sorta di fragilità spaesata, una vitalità mai ridotta che si dischiude («Su, facciamo sosta qui, riprendiamo fiato / e inaliamo il dolce profumo di quella ginestra / che è in fiore oggi / guardiamo laggiù in fondo per miglia, da ora / e fino a che non ritornerà la lince, e il lupo»):
«Portatemi al fiume, ma non subito, non con questa raffica gelida, che da est / con furia sale su dal mare / come un iroso pastore – / e quanto a voi oche, nate sull’Artico, che sembrate a vostro agio / nei nostri campi, / che bisogno c’è di tornare al nord al più presto – / neve sui monti, zolle arate e ghiacciate – / così da settimane, e ci basta / – ma quando verrà la mia ora, / lasciatemi andare come il toporagno / proprio qui sul sentiero: spinto dal vento su quel suo pelo da moscerino, / colto a metà pensiero, a metà corsa».
Il legame tra contemplazione e finitudine lambisce strappi di quotidianità e stupore: gli aironi sono pronti per radunarsi «negli allampanati salici dell’isola», in una scintillante promessa di bellezza eveniente.
Jamie esplora l’iniziazione del particolare a una esatta destinazione della realtà. Le cose nude si accompagnano alle radici, agli spostamenti, alle terre percorse come una vitale e feriale disposizione di immagine, che diventa parte nevralgica del Tutto, unione sacrale di “visibile invisibilità”:
«Quel merlo tra i rovi / sull’argine esterno / non sa di esser nato / non sa di esser gloria e parte / di questo mattino domenicale / in stile nord-atlantico. / Dal becco giallo il canto scende / alle prime celidonie dell’anno; / la gola pulsa. Con un artiglio giallo / gratta l’orecchio sinistro / Tra poco si dissolverà la nebbia / a rivelare il Rum Cuillin / coperto dalla neve di marzo, e le acque del Minch / ma per ora è il merlo / il centro dello sguardo» (Merlo)
Irene Battaglini afferma:
Kathleen Jamie è una poetessa che richiede una comprensione contro-intuitiva, un modo di essere “letta” che ella stessa pretende dal lettore insegnandogli a leggere tra i chiasmi dei livelli organizzativi del discorso. Il suo sguardo oscilla dalla terra al cielo con la rapidità di un falco, e con la voracità di sguardo di chi sa cogliere i colori netti della natura, le sue indicazioni chiare, i segni della magnificenza nelle cose piccole; e si muove trasversalmente, con moto ondulatorio, come un sisma d’acqua contro la corrente superficiale, nell’oceano delle grandi emozioni umane, quelle di appartenenza, di scelta, di nascita e morte. E sembra riuscirci con un ampio ricorso alla metafora paradossale, come un ampio ventaglio che si muove al ritmo di una musica silenziosa, come se le parole fossero i tasti di un pianoforte, e il pianoforte fosse il ventaglio che come un pentagramma antico cambia la sua chiave di lettura su basi nascoste, il cui mistero sta nel vero cuore della poetessa. Un cuore sconosciuto forse anche a se stessa, orientata a capire il mondo, ad averne una qualche ragione, abitata da un talento che si ritira nelle segrete stanze delle cose apparenti. [4]
La pulsionale bellezza della realtà scopre, nel dettaglio, la genesi della rappresentabilità, l’ombra infinitesima della lontananza e del moto delle cose. L’autrice insegue ogni germinazione nutrita, i passaggi ellittici senza grumi ma che però avvertono tutta l’imprevedibilità di una ricognizione che mischia finito e infinito:
«Una gran bella arrampicata, ora il giorno è quasi concluso / sulla collina di fronte al rifugio – / un ruscello asciutto, poi una nocca di basalto / come un trono, / se mai volessi far regina / tra felci tremolanti / qualche pecora al pascolo. / Già le Isole Occidentali / profilano rosa polverose all’orizzonte, / e come il prodigo al locale notturno, / il faro di Scalpay / continua a lampeggiare la sua firma / tre raggi bianchi ogni venti secondi» (Il faro).
L’attesa di una liberazione salvifica come nascita («Sto aspettando il sorgere della stella / – forse un pianeta / che ogni sera s’impiglia / tra i rami ancora spogli / del sicomoro / incorniciato dalla tua finestra più piccola / e là sembra palpitare e tremolare») tremola e accade, per lasciare alla parola un interstizio nel mondo: «Su, tentiamo la sorte qui con il mortale, / il banale e il mortale, / e passeggiamo tra le distese di armeria rosa / della scogliera, / le zaffate di guano di procellaria che ti prendono alla gola / e lasciamo che si apra uno spazio / tra parola e mondo / pizzicato dal vento, tremante» (La scogliera).
Sono ricordi di stupore inatteso e febbrile come fioriture («eppure esito, in attesa / che la mia anima pigna / sobbalzi al tocco del mondo»), svolte e ricordi che determinano l’esistente in una conclusa e radiosa domanda elementare di compimento: «Una notte, in braccio a mio padre / fui portata dalla nostra villetta di mattoni / a vedere le stelle sopra il bagliore delle acciaierie».
O ancora il nitore di una adesione che cerca il suo acquisto di voce alta e di ricordo intarsiato: «Sulla mia altalena rossa volai / in alto, fin dove consentivano / le catene di ferro, il cielo / verso cui mi lanciai non si degnò / di accogliermi; spiegai le ali, / stordita da quel blu, dalle nuvole ribelli – / torna, disse la Terra / ho la tua ombra».
E poi il tremore dei nidi che solcano timori di perdite e indugi come abbandoni: «[…] invece eccola! Apparsa come d’incanto / da pioggerella e foschia di marzo, gli artigli gialli / a uncino sull’orlo roccioso – / l’occhio che tutto abbraccia / mentre plana di nuovo / sui nostri tetti e il firth».
L’orizzonte di Kathleen Jamie ha una rigogliosa prospettiva di sguardo che si protende e prolunga nella soglia di ogni veglia stazionata – dalle foschie delle vallate alla piena delle stagioni o alle primavere arrampicate nella vecchiaia, come se il mondo dovesse sorvegliare la sua genesi, i silenzi e la lingua del cielo che sopravanza l’essere: «Da troppo tempo / non guardo il mare / per dieci interi minuti! / l’orizzonte che brilla come una chiave magica, / un nitrito di spuma ai piedi della scogliera, / e tutti i silenzi del cielo, i suoi dialetti… / Ecco ora arriva un turbine di vento / tutto vestito di grigio / e si precipita verso la terraferma – / uno sbaffo di arcobaleno / stretto come la borsa della spesa / nella mano destra».
La sua ornitologia diventa una descrizione epistemologica di volo e di attitudine alla cadenza, al colpo del respiro, alla decrittata spoliazione della realtà, per affermarla, avvertire ogni sporgenza o precipitazione, custodirne la potenza e attestarne la profonda freschezza delle linee vaste di marea:
«Una pergola sul mare, un capanno da giardino, / messo assieme con legni raccolti in spiaggia e arredato / di un divano sfondato / è qui che sono seduta, / e mi sforzo di coltivare la filosofia del prendere-o-lasciare / sulla linea di marea, felice di rimanere / finchè l’ultimo piccolo merlo / lascia il nido / incastrato nella rosa canina alla mia sinistra. / Di tanto in tanto padre merlo / saltella attraverso il comune quadrato erboso, / inclinando la testa. / Amico, è il mare che senti, vasto e giusto / oltre quelle dune, oltre la tua contezza di merlo, / ma io cosa so? Maggio è di nuovo disteso / per tutto l’emisfero settentrionale, e oggi / è il mio compleanno. Chicchi di grandine improvvisi / pungono questo asilo provvisorio. Non è ancora finita» (Pergola).
Lo splendore attonito si attesta davanti al mistero e al segreto del vivente, per essere parte non esclusa di un giacimento protratto di sé, in cui ogni particolare celebra l’apparizione stupefatta di ogni sconfitta della ripetibilità, attraverso la capacità di visione che illumina sugli ottenebramenti di – quasi nulla- che la vita tocca e conosce: «C’è mistero nel giardino dietro casa […] Della pioggerella / che fa luccicare il susino / l’ombra della catasta di legna, / il porta noccioline che vibra / quando un passero prende il volo – / e queste margherite / tutte accampate sull’erba / – le stesse della settimana scorsa, dell’anno scorso, stesse / ma non identiche / a quelle che osservavo da ragazza / innocenti e senza pretese / tutte ricevono la loro parte».
In Le cerve (The Hinds), che dà il titolo alla raccolta, allude alla vecchia ballata Tam Lin, dove il cavaliere viene salvato da un’intrepida e aristocratica fanciulla, Janet, rimasta incinta al loro primo incontro. La Regina delle Fate si lamenta con rabbia e afferma: «Si è portata via il più bel cavaliere di tutta la mia compagnia».
Il senso di stupore placato, libertà e abbandono (Le bacche), determinati da questi probabili cervi rossi, eliminano ogni sentiero alienato, attraverso l’agilità vigile della loro energia. I balzi, i movimenti dello sguardo, le visibilità individuali («poi a turno saltare, / saltare il torrente scuro di torba / da poco rigonfio») che tracciano pienezza, l’antropomorfismo enfatico, la topografia mimetica, l’epica minima, che riporta alle illuminazioni percettive di Kavanagh[5], accordano suoni e rime, in un gesto fluido che non consente indugi e promettono inviti trascritti senza ritorno, oltre ogni argine.
Giorgia Sensi commenta: «In un sogno a occhi aperti, l’autrice incontra diciannove cerve, che con aria regale la fissano e in modo seducente la invitano ad andare con loro, sarà felice – sembrano dirle – a un costo, però, quello di non più ritornare[6]».
Nella fissazione, che sembra frenare ogni movimento, vi è un rallentamento che esclude ogni ritorno, portando energia flessibile, libertà, indipendenza, passo dell’anima nella voce profonda della notte e solstizi come passaggi di luce: «La luce del giorno è al massimo, e ha ancora da fare qui, / almeno così pensa – / ma i rondoni della città sono nascosti / sotto le gronde misteriose / ed è quasi mezzanotte. Poi è finita – / solstizio: una porzione di meno per noi, / una di meno lasciata nel vaso».
La dimensione memoriale è l’esito di una relazione con ciò che si è perduto, guardato con tenerezza modulata nella ricerca di incontro (come The Stair – La scala, dedicata alla nonna) e nella lingua scozzese che meglio affina la dimensione memorativa.
Esiste una dolce e fitta oscurità che lega ricordo e presente, come in The Girls (Le ragazze) in cui i richiami e le rievocazioni scheggiano l’estate nel crepuscolo imminente o nella drammatica Smarrita (The Missing) che riconduce l’allungamento ellittico delle strade a un’assunzione di responsabilità. Non sappiamo come finisce la sua storia e quella di Sandra McQueen, apprendiamo l’apparenza di una scomparsa, di un attimo vibrato e breve che segna e conclude.
Vi è, dunque, in Jamie una vivida sproporzione memoriale e un orlo frastagliato di realtà, che desume sì dalla rievocazione, ma lo riporta in una condizione di attualità emersa, come la penisola di Fianuis, nelle isole Ebridi:
«Bene, amico, eccoci qui di nuovo, / a goderci l’ultimo mezzo miglio fino all’orlo frastagliato della terra / per vedere cosa ci è stato imbandito qui, sparso sul manto erboso – / piume di gabbiano, conchiglie sbiancate, / un intero maschio di foca, essiccato, / esausto per la fregola / (bussiamo sulla testa di cuoio, ma non c’è nessuno in casa). / Cambiamento, cambiamento – gridano le sterne laggiù / sulle rocce verso il mare / nubi in fuga e bacio salato – / tutto il resto è temporaneo, / noi e tutte le nostre opere. / Ecco perché ci piace qui, credo. / Ascolta: una breve pausa, / le note di una pispola piccole come semi» (Fianuis).
Il tentativo di recupero assomiglia a una migrazione che decifra l’esistente in una raccolta condensazione di immagini, che descrivono il singolo gesto come un’approfondita bellezza di suono e visione. Come se la realtà, appunto, dovesse essere registrata, non tanto in una percezione realista quanto piuttosto in un’affermata meta, che ora ripropone Hölderlin, ora asserisce ogni segno possibile che resiste a ogni dileguo di sgomento e congedo. Per farsi intreccio, ascolto e luce sulle maglie («Sento ancora il prurito di quella maglia che portavo, / verde a puntini marrone fatta ai ferri, / assorta su quella spiaggia / a raccogliere una conchiglia dopo l’altra. / Dov’è finita / – la lampada, e tutto quel ricamo / che illuminava / senza sprecare luce?»):
«Ricordi quel cigno? Quello selvatico che trovammo / sul prato col collo inerte, la testa rivolta a nord come un segnale, / e tu ti chinasti ad aprirgli l’ala? / Io prestai scarsa attenzione / all’elenco che facesti delle sue parti: copritrici, ulna, primarie / non sopportavo quel posto, le burrasche e il ruggito del mare / ma quell’aria – quella era una dichiarazione! / Un’ala per il vento, una potenza del bagliore del quarzo! / Un varco radioso / che si poteva aprire e da cui fuggire… / Trascinammo il cigno a ridosso di una vecchia diga / lo coprimmo per bene, una pietra bianca, / poi ci arrampicammo su fuori dal vallone. Al crinale / di nuovo, fummo investiti da una bella raffica di vento, / procedemmo incespicando, mezzo euforici, mezzo sgomenti» (Migratorio I)
[1] Jamie K., La compagnia più bella, a cura di Giorgia Sensi, Medusa Edizioni, Milano 2018.
[2] Cfr. Power P., The Bonniest Companie by Kathleen Jamie, (https://www.thelondonmagazine.org/the-bonniest-companie-by-kathleen-jamie/), Dec 22, 2015.
[3] Sensi G., Introduzione, in Jamie K., La compagnia più bella, cit., pp. 10-11.
[4] Battaglini I., Lezioni alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, a.a. 2017-2018.
[5] Rumens C., Poem of the week: The Hinds by Kathleen Jamie, (https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/oct/05/poem-of-the-week-the-hinds-by-kathleen-jamie), Oct 5, 2015.
[6] Sensi G. cit., p.11.
 Jamie K., La compagnia più bella, a cura di Giorgia Sensi, Medusa Edizioni, Milano 2018, pp. 131, Euro 16.
Jamie K., La compagnia più bella, a cura di Giorgia Sensi, Medusa Edizioni, Milano 2018, pp. 131, Euro 16.
Jamie K., La compagnia più bella, a cura di Giorgia Sensi, Medusa Edizioni, Milano 2018.
Battaglini I., Lezioni alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, a.a. 2017-2018.
Power P., The Bonniest Companie by Kathleen Jamie, (https://www.thelondonmagazine.org/the-bonniest-companie-by-kathleen-jamie/), Dec 22, 2015.
Rumens C., Poem of the week: The Hinds by Kathleen Jamie, (https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/oct/05/poem-of-the-week-the-hinds-by-kathleen-jamie), Oct 5, 2015.