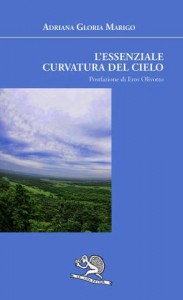leggi in pdf Commentario a L’ essenziale Curvatura del cielo
Il Commentario sul sito della casa editrice La Vita Felice
L’ EQUAZIONE ESSENZIALE DI ADRIANA GLORIA MARIGO
di Irene Battaglini 29 novembre 2014
La poesia di Adriana Gloria Marigo è un fiume che sgorga e nel contempo include. Mentre s-gorga dal suo cuore immaginale, in-clude attraverso una catena di membrane linguistiche il materiale psichico e relazionale che ella ritiene necessario e utile al compito generativo, che assomiglia molto all’espressione di un gene dello stupore, quasi che si attivasse una catena epifenomenica dell’Esser-ci. Il verso: «[…] nell’ora più confusa / sciolti e ricomposti / i miei nervi issarono vele alla carne / incisero il canto bruno dell’abbraccio […]»2, sembra quasi snodare questo stampo originario.
Il processo creativo di Adriana Gloria Marigo – già in Un biancore lontano ma in modo ancora più marcato in L’essenziale curvatura del cielo – è di fatto ricerca di una Lichtung della parole nitida tra gli ingarbugliati sentieri della memoria delle cose: un discernimento di dritto e rovescio nel suburbe disorganizzato delle parole scomposte e vacue, occultate nell’ambiente protolinguistico delle emozioni. In questo gioco serio la sua scrittura arretra, in alcuni casi, nell’extrema ratio della sofferenza d’amore, quando scrive: «Di questo sogno tocco le sponde mobili / l’acqua che non si fa golfo e / ogni erba declinante il verde // il riverbero dell’ora dentro la / pupilla che sazia il mondo di ogni / tuo mondo, semplice e assente. (A Francesco M.)»3, a mitigare quel che altrimenti sarebbe un intarsio di filigrane in guerra con la perfezione apollinea di un inchiostro di Animus, come nei versi potenti e fieri di “3 febbraio 2012”: «Benedico la sottile luce / levantina / il graffio di gelo / l’eterna aria dissimile / la stirpe dei Reti che / mi arde d’intelletto, / di non fragile cuore»4.
Versi scolpiti e sottili, stagliati, intagliati, decisivi. Parole che decidono il destino di un universo di alberi, bruma, vento, orti conchiusi in un vaso che conserva immortali pianure di fiori incolti, che aspettano una luce che benedice, nomina, assegna identità. Vi è come una scheggia che vien fuori da questi versi, una scheggia che ferisce perché non chiede eco, ma una risposta fresca e chiara, come in una radura che si apre alla Lichtung ma che non consegna al vuoto, se mai raccoglie un seme in un palmo di mano per farvi germogliare mondi intrisi di mito, come qui: «[…] – memoria tenue di universi – / mentre io sgranavo giorni nei miei occhi di ninfa / mi feci vertigine d’ala / intesi l’ammanco originale / la tua nascita sotto un graffio di vento»5.
Potrebbe essere paragonata alla scultura di Giacometti, alla pittura di Morandi, se non fosse per quella delicatezza delle immagini che si svincolano dal cuore e che aprono all’orizzonte di una lettura mercuriale quando non dionisiaca. S-gorgare come a voler uscire dall’ingorgo, vincendone l’inganno di forma con l’astuzia del segreto di Anima. Ci si senti liberati e offerti alla vita, come in questi versi: «Precipita la luce nel mattino. / Impallidisce l’ombra nel mare delle rifrazioni. Emerge una filigrana eretica d’amore»6.
Una poesia che ti mette spalle al muro perché non ha paura, non ha bisogno di nascondersi dietro alla tecnica di assemblaggio delle parole. I segni, i suoni, restano lì scarniti, elementari, magri e sostenuti da un tratto deciso, che afferma anche senza dire dell’oltre, senza raccontare. Con l’ausilio di una punteggiatura che fa emergere le idee come il chiaro-scuro le divergenze tra due petali di uno stesso fiore. Una tensione grafica che possedeva lo stesso Morandi, un ritmo del quotidiano che si appropria a pieno titolo del metafisico, come nelle acqueforti, minime e meditate, ma distese nell’ovvio potente di un quadrilatero di carta.
Una poesia che non sa il tradimento dell’arte, ma che conosce il dolore dell’attesa, il fuoco argenteo di un parto che fa i conti con l’illusione. Scrive Cristina Campo a Maria Zambrano: «In nessun modo Maria, e da nessuna circostanza, tu devi lasciarti indurre a tornare a Roma se prima non hai finito il tuo libro. Hai freddo, sei triste, sogni poco, non hai la forza. Non importa. Tutto questo fa parte del tuo libro, mentre la vita di Roma non ne fa parte, e ti dividerebbe da esso ancora una volta – e questa volta forse per sempre. Che tu scriva o non scriva, che tu sia triste o allegra, non tornare. Aspetta il tuo libro là dove gli hai dato appuntamento. Non lo tradire»7.
Per questo occorre soffermarsi sulla genesi di quest’opera, perché anche Adriana Gloria Marigo ha aspettato, ha scritto e ha dovuto assentare la sua voce dalle cose di ogni giorno per esplorare il cielo di questa sua “essenziale curvatura”. La bellezza di questa poesia non sta tanto nel suo equilibrio tra forme, colori, immagini, spessore, sapienza compositiva – tutte qualità inequivocabilmente espresse al massimo grado della poesia contemporanea – quanto nel sapersi astenere dalla seduzione della parola data. La parola in Gloria Marigo non è data. È pesata e pensata. Vi sono studio e ricerca; il biancore non è candore, il cielo è incurvato ma non curvo sotto il peso del suo azzurro di sperdimento. Ella conosce la trappola del talento, e non vi indulge. Sa che la poesia, quando è scritta, acquista una sua precipua soggettività e di conseguenza sa ben misurare il potere che ha la facoltà, per mezzo del talento e della passione di poeta, di conferire all’espressione arricchitasi di senso compiuto.
Pensiamo, per esempio, alla pienezza di: «Qui cadono tutti i vaticini / […] / Impera solo l’essenziale curvatura del cielo»8. Il rimando è a immagini che oscillano tra il desiderio di elevarsi nella sintesi e la ricaduta del rosso del cuore che precipita dentro se stesso, che ama. Nuvole in movimento che rifondono ogni giorno la volta celeste, ma pur sempre fatte di ossigeno e di idrogeno. Si scalda l’aria al passo di donna, come quando dice: «Io fui lontana / non per mio volere […]», e dunque si avvicina ancheggiando prima di decidere: «[…] un potere / retrogrado indusse la scelta – / distanza che unì l’ammaliante differenza»9.
Adriana Gloria Marigo ha imparato la lezione dei Maestri nel dosare e nel fare, sa spendere e sa confinare le sue creature in una saggia spartitura di note, lasciando come in una jam-session al lettore la libertà di improvvisazione emozionale. La sua poesia è quindi adatta ai gusti di un pubblico colto, ma vivamente raccomandata per i palati più esigenti, perché è una poesia autentica e consapevole. Come dire: so di piacervi, ma mi interessa che sappiate che qualora decidessi, potrei tornare a me stessa, alla mia meditazione sulle cose più grandi, senza tema di solitudine. Come in “Impermanenza”, ai versi: «Mi stanca il volo d’ape / […] / Tra fiore e ape sarebbe / l’estate, se non fosse / la corolla votata al suo destino»10, in cui vi è alternanza di giorno e di notte, di assertività per il proprio compito e di perdono per il proprio destino, ed in misura più sottile e implicita di amore che non esclude, ma determina con il peso di chi sa il proprio valore nella relazione.
Infine, Adriana Gloria Marigo – poeta, ha compreso la differenza tra equilibrio ed equazione, sapendo calibrare i suoi gesti in questa ultima dimensione, alimentando la danza tra significato e segno, tra quantità e numero, e approfittando della sospensione per farne un vuoto che conosce il suo contrario: «Tutto si consuma nell’autunno, / anche quest’alba che disincarna / il mattino devoto al richiamo dei tigli / nel frammento di brina, […]»11, dove tutto diventa frammento, il mattino si trasforma nell’autunno, che è la sera consumata dell’anno, l’alba disincarna al pari della brina, come se una molecola di ghiaccio – con la sua articolazione originale – avesse la stessa qualità categoriale di un movimento di luce come l’alba nel cielo. L’equazione di una curva che invade il cielo di accensioni ancora da realizzarsi.
L’ESSENZIALE CURVATURA DI ADRIANA GLORIA MARIGO
di Andrea Galgano
La poesia di Adriana Gloria Marigo si confronta con la stoffa del tessuto amoroso, non come slancio intellettuale o sintassi concettosa, bensì come forza e spasmo.
La sua posa non ama la frenesia spasmodica, per quanto brillante e sfuggente di un attimo conclamato, ma si appropria del richiamo della realtà, della salmodia del tempo e dello spazio e non cede al ricatto di una energia fine a se stessa, ma comunica al mondo il ritmo del suo divenire esistenziale e metafisico.
La brillantezza dell’essenziale, se da un lato si offre come possibilità di tempo liberato e non ricattato, dall’altro percepisce la “lentezza” della libertà, e quindi, l’apertura del pensiero.
La stagione poetica di Gloria Marigo ha la fecondità-primizia di uno spazio esplorato, di un cosmo raccolto e infine dell’incisione del contatto.
Poiché il contatto con la stoffa della realtà è il suo ornato, il rigore esatto e lucente di una obbedienza: «Precipita la luce nel mattino. / Impallidisce l’ombra / nel mare delle rifrazioni. / Emerge una filigrana eretica d’amore».
L’io che si dona, si pone in ascolto, celebra il barlume della quotidianità vivente e condivisa, è disposto a perdere il proprio fondo, per restituire il mistero, il cuore disvelato, la domanda di se stessi e la sproporzione: «Per felice intuizione compitai / la sintassi del tuo cuore / gli ossimori del tuo volto quando / nell’ora più confusa / sciolti e ricomposti / i miei nervi issarono vele alla carne / incisero il canto bruno dell’abbraccio / da palpito a palpito / per la mistica della rosa».
Scrive Eros Olivotto nella postfazione: «[…] il linguaggio assume una profonda valenza simbolica, si carica cioè di una tale riferibilità da divenire evocativo e, quindi, rivelativo; nel senso che come caratteristica specifica trova in sé la possibilità di evidenziare gli angusti limiti di un modo di sentire che tende ad escludere l’accettazione di quel rischio che rappresenta la vera sfida dell’amore, tutta la sua forza più autenticamente rivoluzionaria. Solo se siamo disposti a perdere, a perderci, l’amore si trasforma in quel qualcosa che ci permette di cambiare […] ed è ancora l’amore che, misteriosamente, ci rende presenti alla vita e agli altri, restituendoci di conseguenza a noi stessi».
L’essenziale di Gloria Marigo diviene, pertanto, il territorio del respiro, o meglio, diventa compito del respiro conoscerlo e riconoscerlo.
È nell’amore, con la sua misteriosa linea dura e vivente, che il dispiegarsi del “Tu” rivela e disvela il colore profumato della grazia e della gioia, la sofferenza solitaria, la mancata declinazione e il dono proteso, come indagine di metamorfosi: «Mi metterò nel silenzio / bianco dei meli ora che / (assassinato dalle tue stesse mani) / tu vivi nella morte del mare / dove le tempeste flagellano / il tuo sorriso / pallido più dell’ombra dell’inverno» o ancora «Quando la stagione si alzò in canti / fin dentro la notte e / l’aria fu mutamento / mi scheggiai come selce: / lame al limine / di ogni mia fattezza».
La materia creativa della realtà invoca l’attraversamento della libertà, che si lascia penetrare dall’intimità essenziale e immediata dell’essere, e, attraverso tocchi ripidi e rapidi, restituisce un’emergenza, una conoscenza di sguardo: «Vedo la terra nella mano del sole / Ogni profumo è incandescenza d’aria».
Ma questa curvatura e questo spasmo non si limitano a dire il limine d’amore e il suo ritmo, ma anzi tentano di riavvolgere le mappe e il piegarsi della terra, per la promessa di un eterno principio: «Riavvolgo le mappe. / Riconosco la terra dal piegarsi / dei rami, dal gioco del vento – / viene la primavera a darci / l’eterno principio».
La sorpresa dello sguardo, lo stupore di quel che rimane quando tutto sembra crollare, il desiderio oltre-limite e il sapore del giorno celebrano l’orizzonte ventaglio dei viaggi, il punto che si curva per restare, l’epifania che conosce prossimità e avvenimento: «M’assesto i pensieri / come un cappello di fiori/ così che per un’aria bizzarra / s’involino petali fino ai segni / del tuo viaggio di vela / fino alla lamina dell’orizzonte / prossimo al tuo sguardo / che addensa le rose».
Questa poesia che conosce e sconfina, morde la grazia per vivere, si affianca al dato dell’esistenza per celebrarne il sofferto e lucente accadimento e verso cui farsi «libellula di parola / per la fuggevole tua presenza / il nominare all’infinito futuro / e il vocativo che non / sapesti declinare».
È con l’avvenimento della realtà che la poesia di Gloria Marigo fa i conti. Ed è con la sua trama misteriosa e la sua lingua duttile che l’amore, che in essa proclama tutto il suo bagliore, sogna e tocca «le sponde mobili / l’acqua che non si fa golfo e / ogni erba declinante al verde / il riverbero dell’ora dentro la / pupilla che sazia il mondo di ogni / tuo modo, semplice o assente».
Il prezzo della parola è la libertà di qualcosa che cerca la vita, come perla d’aria e memoria tenue: «S’inclusero le tue parole / in una perla d’aria / – memoria tenue di universi – / mentre io sgranavo giorni / nei miei occhi di ninfa / mi feci vertigine d’ala / intesi l’ammanco originale / la tua nascita sotto un graffio di vento».
La capacità di decifrazione del segreto del mondo e l’ulteriorità della parola testimoniano una vertigine metafisica in cui lavora il silenzio, la sua geografia, il fraseggio del suo bagliore (o biancore, per usare un termine caro alla poetessa).
I toni di cui si impossessa l’intimità poetica di Gloria Marigo trascina in profondità, ed è nella proprietà della rarefazione che essa puntella il verso, lo scalfisce, lo modella per conoscere la gemmazione «dalle oscure radici, / il contrasto apparente del rigore / verde scioglie nel cristallo che / magnifica le linfe».
Le lamine dell’orizzonte poetico hanno rimbalzi specchiati, domanda continua e addensata. Ed è proprio l’addensarsi, l’oscura e vibrante parola che sconfina nella sua poesia, forse la traccia immemore che si ricompone naufraga: «così io resto immemore / impigliata dove s’addensa / l’alga nata tra la roccia e / l’acqua» (Il corsivo è mio).
La lotta, allora, tra inclusione ed esclusione non ha vincitori. Anzi, semmai, queste due forme umane sembrano fondersi sia nei paesaggi di luce sia nelle barene dell’oscurità.
È il contrasto umano che si abbandona per vivere, che incontra «il grumo incandescente / della tua corta follia», per rivelare poi «il vento / l’altezza della notte abbandonata / sulle rapide del giorno / nel duplice destino / di corolla e spina».
È l’approdo lucido e remoto alla pienezza dell’essere che intaglia la terra, cesellandola e ornandola, che nulla esclude o censura, spingendosi in un abbandono ricolmo e in una umida trafittura di pianure.
Il paesaggio della sua poesia non si misura con il vuoto, anzi, nella sua percezione sensoriale, avviene l’attesa del prodigio, «l’orbita rovesciata / nella gravità dei corpi, l’urto / scomposto della letizia».
Scrive Rita Pacilio: «Lo spazio-tempo in cui l’autrice errante diventa peregrina intellettuale è destinato a diventare uno spazio cosmico-riaccolto, mai immaginato, bensì definito dall’analisi degli elementi conoscitivi fisici e mentali sempre in tensione. L’attesa, l’incontro, l’illusione, l’incanto, il ricordo, il disincanto, l’ostinatezza costituiscono la colonna vertebrale di questa raccolta poetica che sorprende per le dinamiche metaforiche descritte, originali e possibili come unica via di scampo alla fuggevole e insoddisfatta sensibilità del mondo».
Ciò che accade, quindi, scontorna l’incontro di cielo e terra ed è per questo che il posarsi dell’amore si fa coltre radicale e matura e orizzonte di gioia precisa.
Il germoglio della natura (e le sue stratificazioni), che si spinge fino al «delta del vibratile verde», rappresenta la preda e l’intuizione dell’io («Della stagione prediligo / il sortilegio terra-cielo / i cantori delle fronde / l’aria di vela azzurro Tintoretto / l’arancia della notte / tra l’albero e il tetto»), il dato vivente, il gioco oltre-tempo («Fuori dai tuoi occhi cadono / tutte le nebbie del mondo») e la dismisura sbrecciata, per farsi, agostinianamente, carnale fino allo spirito e spirituale fino alla carne: «Qui cadono tutti i vaticini. / La tua voce di oracolo soave / s’infrange contro l’alloro. / Impera solo l’essenziale curvatura del cielo».
________________________________________________________________________
«Colui che il gran commento feo» è l’appellativo con cui Dante Alighieri chiama Averroè nella Divina Commedia (Inferno, IV, 144).
– In età ellenistica e successivamente medioevale, il termine commentario passò a designare anche un lungo ed erudito commento riguardante un’opera di particolare importanza, specialmente dell’antichità: esso consisteva quindi in un’interpretazione o esegesi dell’opera trattata per renderla accessibile ai contemporanei. Ad esempio il filosofo arabo Averroè compose un poderoso Commentario ai libri di Aristotele, che lo rese noto nell’Europa cristiana.
– Commentari sono anche chiamate le memorie dello scultore fiorentino Lorenzo Ghiberti, una delle fonti primarie più antiche sul Rinascimento.
– Si chiamano Commentari le memorie di papa Pio II.
* Pittrice, Docente di Psicologia dell’Arte e Coordinatrice della Formazione alla Scuola Quadriennale di Specializzazione Post Laurea in Psicoterapia Erich Fromm di Prato, riconosciuta dal MIUR.
** Poeta, Scrittore e Critico Letterario, Docente di Letteratura alla Scuola Quadriennale di Specializzazione Post Laurea in Psicoterapia Erich Fromm di Prato.
2 A.G. Marigo, L’essenziale curvatura del cielo, La Vita Felice. Milano: 2012, “Per felice intuizione”, p. 46.
3 Ivi, “Di questo sogno”, p. 32.
4 Ivi, “3 febbraio 2012”, p. 18. 5 Ivi, “Senza titolo”, p. 53.
6 Ivi, “Giorno”, p. 26.
7 Cristina Campo, dalla lettera a Maria Zambrano del 25 luglio 1962, in Se tu fossi qui. Lettere a Maria Zambrano 1961-1975, p. 27. 8 Ivi, “Senza titolo”, p. 59.
9 Ivi, “Io ti fui lontana”, p. 58.
10 Ivi, “Impermanenza”, p. 42. 11 Ivi, “Tutto si consuma nell’autunno”, p. 9