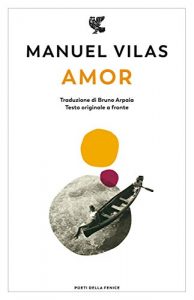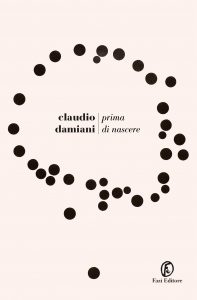di Andrea Galgano 24 agosto 2022
 La sradicata tensione, la caduta come legame, la sfrontata immersione lirica che abbacina sogno e vitalità disperata («Con la Sua spina dorsale Dio formò la Palestina / Con un solo osso: Gerusalemme. / Cammino come attraverso mausolei – Pietrificata è la nostra Città Santa. / Pietre riposano nei letti dei suoi laghi morti / […] / Gli abissi fissano con durezza il viandante – […] / Ho paura, e non riesco a vincerla»), porgono il tempo di Else Lasker-Schüler, in tutta la sua dolorosa parabola.
La sradicata tensione, la caduta come legame, la sfrontata immersione lirica che abbacina sogno e vitalità disperata («Con la Sua spina dorsale Dio formò la Palestina / Con un solo osso: Gerusalemme. / Cammino come attraverso mausolei – Pietrificata è la nostra Città Santa. / Pietre riposano nei letti dei suoi laghi morti / […] / Gli abissi fissano con durezza il viandante – […] / Ho paura, e non riesco a vincerla»), porgono il tempo di Else Lasker-Schüler, in tutta la sua dolorosa parabola.
Il suo magnetismo trasfigurato, lo sfarzo della lingua, come ebbe a dire Gottfried Benn, che esprime la eveniente sopravvivenza della nostalgia, segnano Il pianoforte blu[1], edito da Ibis, con cura e traduzione di Michele Gialdroni, l’ultimo libro di poesie, pubblicato in Palestina nel 1943, dove la poetessa tedesca di famiglia ebraica visse dal 1939, dopo che la Svizzera le revocò il permesso di soggiorno: «A casa ho un pianoforte blu / Ma non conosco una sola nota. / Sta al buio, dietro la porta della cantina, / Da quando il mondo s’è imbarbarito. / Suonavano quattro sideree mani / – La donna-luna cantava sulla barca – / Ora i ratti ballano nello stridore. / In pezzi è la tastiera… / Io piango la defunta blu. / Ah, cari angeli, apritemi / – Ho mangiato il pane amaro – / Già in vita la porta del cielo, / Anche contro il divieto».
Poesia di esilio, sentimento di feritoie[2] e dislocamenti, come gioco e dramma, la sua solitudine non è balba è magnetica. Qui la voce, come afferma Roberto Galaverni:
«appare quella di una sopravvissuta: alle speranze della giovinezza, agli anni d’oro della vita, al sogno di una superiore civiltà (l’armonizzazione tra le culture europea, ebraica, orientale), alla perdita degli amori, degli amici, e ancor più dell’unico figlio (Paul, morto non ancora trentenne di tubercolosi […]) […] Il senso d’abbandono e di posterità sono anzi così forti che questa sopravvissuta non sembra nemmeno poi così sicura di esserlo».[3]
Michele Gialdroni, nella postfazione, scrive:
«Il pianoforte blu è il giocattolo dell’infanzia, uno strumento che non si suona nella realtà (ed Else Lasker-Schuler effettivamente non sapeva suonare), eterna fonte di ispirazione per dei versi di purissima nostalgia e musicalità. Ma il calore umano della raccolta definitiva di Else Lasker-Schuler è tutto condensato nella soglia del libro: il disegno in copertina che la ritrae come Principe Yusuf nella stretta cerchia dei suoi amici, nella dedica in cui promette loro eterna fedeltà. E nella prima poesia “Ai miei amici”, che non rivela nomi e permette ai lettori passati e presenti e futuri, di essere ammessi alla corte del principe di tebe, quella corte che può essere nella casa di famiglia a Eberfeld, in un caffè berlinese o in una povera stanza d’albergo di Gerusalemme, e di rendere omaggio alla sua lucida follia, alla sua imprudente e vana promessa di vita eterna».[4]
La sua luce è fuorilegge, un fiore segnato, un dramma calibrato e fermato da una sproporzione, colta nella desolazione infiammata, in cui l’avversione è un contrasto di sguardo, un’opposizione lirica o un franamento, come un lampo che annusa le cose, si scontra con il nulla, si impasta con quel nulla mai innocuo, così vicino alla nascita e alla saturazione di nubi. Il tempo è un rovescio che appartiene al passato, all’infanzia, alla giovinezza. È il territorio del buio, del sonno, della morte:
«Non la morta quiete – / Son già riposata dopo una placida notte. / Oh, espiro il soffio del sonno, / Mentre ancora cullo la luna / Tra le mie labbra. / Non il sonno della morte – / Già discuto con voi / Celestiale concerto… / E prorompe di nuovo la vita / Nel mio cuore. / Non il nero passo dei sopravvissuti! / Sonni calpestati frantumano il mattino. / Stelle coperte da un velo di nubi / Nascoste al mezzogiorno – / Ritrovarci così ancora e ancora. / Nella casa dei miei genitori / Abita ora l’angelo Gabriele… / Vorrei proprio celebrare lì con voi / In una festa la beata quiete – / Si mischia l’amore con la nostra parola. / Dal molteplice addio / salgono stretti l’un l’altro i filamenti dorati, / E non c’è giorno che non sia dolce / Tra il bacio melanconico / E il rivedersi! / Non la morta quiete – / Così amo essere nell’alito divino…! / Sulla terra con voi già in cielo. / Dipingere di mille colori su sfondo blu / La vita eterna!».
Fausta Antonacci, a tal proposito, scrive:
«La sua infanzia ha una funzione salvifica e risanatrice, vi torna sempre per lenire le sue molteplici ferite, nel corso della vita. Una infanzia che viene recuperata attraverso il ricordo, ma poi trasfigurata dal linguaggio poetico, una infanzia vissuta nuovamente e trasmutata per bonificare il ricordo e rendere il presente sopportabile. Non si tratta tuttavia di una finzione, ma di un processo di eufemizzazione, che tiene insieme l’immaginazione (come facoltà del possibile) e la memoria (come facoltà di rielaborazione)».[5]
I rapporti con l’arte selvaggia e ossessiva di Kokhoschka, Kraus e la sua esattezza, Benn e il sottosuolo lirico, Marc e il tragico azzurro di Trakl recano incisività alla sua poesia, che porta il senso del ritorno e della contraddizione e scaraventa aridità e nudità di luoghi:
«Potessi tornare a casa – / Si spengono i lumi – / Si estingue il loro ultimo saluto. / Dove devo andare? / Oh madre mia, lo sai? / Anche il nostro giardino è morto!… / Giace a terra un grigio mazzo di garofani / In un angolo della casa materna. / Aveva ricevuto ogni cura. / Coronava il benvenuto ai cancelli / E si è consumato tutto nel colore. / Oh cara madre!… / Emanava rosso di sera, / Al mattino soffice nostalgia – / Prima che il mondo finisse nell’infamia e nelle pene. / Non ho più sorelle né fratelli. / L’inverno giocò con la morte nei nidi / E la brina gelò tutte le canzoni d’amore».
Ma l’apice di Else è il suo Heimat, la sua agnizione, la sua catarsi nata in esilio, scontratasi con il vento violato, le strade chiuse, la percezione avvolta di un dolore, vissuto nello scioglimento lessicale, nella necessità di una concordia oppositorum. Il suo contro-orizzonte, come dice Galaverni, vive lo sperdimento della separazione dei preludi, la patria negli occhi («Bisogna percepire l’attimo dell’amore, / Quando vediamo reciprocamente la patria negli occhi. / Dolce miraggio sul pendio del nostro amore, / Fiorisce dai cactus la regina della notte»).
L’appartenenza, il disorientamento («Viene la sera e mi immergo nelle stelle / Per non disimparare nell’animo la strada di casa / Anche se il mio povero paese da tempo si è velato a lutto»), la passione naturale, l’ispirazione verso l’invisibile si concentra nella parola, nel volto e nella luce del suo sguardo, che toglie ogni aratura davanti al Divino, respirando la tensione dell’eterno e della sua trasfigurazione, del lavoro archetipico dell’anima, della infinita rastremazione dell’io.
Fausta Antonacci afferma:
«L’appartenenza e il disorientamento, l’Oriente e l’Occidente, la notte e il giorno, l’amore e la solitudine, il riconoscimento e l’abbandono, sono tra i poli più faticosi che ardono, nelle sue parole, in cerca di conciliazione. Tale tensione è carica di sofferenza, perché la passione amorosa di Lasker-Schüler è intrecciata alla passione per la natura, per il creato, per Dio, che testimoniano sempre una distanza, uno scarto, una impossibilità di sostare nell’unione mistica, alternando la felicità più folle all’angoscia e alla disperazione. […] Il poeta non è immune dall’ansia di sentire una concreta rispondenza nel cuore del lettore, di sentirlo palpitare all’unisono col proprio battito creatore. Lasker-Schüler, come ogni artista sente una incommensurabile distanza tra il suo desiderio di comunicare e le sue capacità espressive. E sente che nella sua opera, pure intrecciata tra diversi linguaggi (poetico, figurativo, performativo), persiste una distanza tra le cose e la loro dicibilità, permane un non detto, impermeabile a qualunque forma espressiva. Eppure questa distanza non placa la sua fame di contatto col mondo che rimane assoluta, feroce, iperbolica».[6]
Nel cuore giocano paradisi[7], nonostante il sentimento della fine, del dolore in terra («Il mio cuore riposa stanco / Sul velluto della notte / E sulle mie palpebre si posano stelle…») e l’amore stellato induce la veglia al riposo, alla stretta, allo schiudersi delle labbra. Else fiancheggia l’amore («Io barcollo sul prato dorato del tuo corpo, / Brilla lungo il sentiero d’amore la ghiaia adamantina / E anche al mio grembo / Portano turchesi d’ogni colore»): «Io sogno così lontano da questo mondo / Come se fossi morta / E non fossi più incarnata. / Nel marmo del tuo gesto / la mia vita si ricorda più vicina. / Eppure io non so più le vie. / Ora la sfera scintillante mi avvolge / Gravemente nell’abito di diamante. / Ma io annaspo nel vuoto».
[1] Lasker-Schüler E., Il mio pianoforte blu, cura e traduzione di Michele Gialdroni, Ibis, FINIS TERRAE, Como – Pavia 2022.
[2] “Io costeggio l’amore, da tanto tempo vivo dimenticata – nella poesia”: vorrei accarezzare la povertà di Else Lasker-Schüler (www.pangea.news/else-lasker-schuler-ritratto/?fbclid=IwAR0FRoyi7p7tHnHS7sFrWrR4N080Axsn7sav6beVSn05ChjXJxjbo).
[3] Galaverni R., Il lirismo che unì ebraismo e tedesco, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 14 agosto 2022.
[4] Gialdroni M., Amici per sempre, in Lasker-Schüler E., cit. p.99
[5] Antonacci A., “In vita muoio e con le immagini rinasco”. Il cuore poetico di Else Lasker-Schüler (http://www.metisjournal.it/metis/anno-vi-numero-2-122016-cornici-dai-bordi-taglienti/192-saggi/871-in-vita-muoio-e-con-le-immagini-rinasco-il-cuore-poetico-di-else-lasker-schueler.html?fbclid=IwAR0Mr0CRvP0mFu8Q7qWZsrylA42xLDjs0MM-nltkNW7z812oX1jCa9vdCUA).
[6] Antonacci A., cit.
[7] «Sono profondamente scossa, la mia anima si è dissolta, da essa sgorgano smeraldi e rubini e zaffiri, anche pietre di luna come sorgenti variopinte. […]. Non ho quindi più nessun segreto, il mio cuore non riesce più a conservarne alcuno e il mondo può disporne. Onde marine portano a riva i suoi segreti, si risveglia all’alba e muore al tramonto. Ma il mio cuore è sempre di seta, lo posso chiudere a chiave come un portagioie». (in Lasker-Schüler, Il mio cuore e altri scritti, traduzione e nota critica di Margherita Gigliotti e Enrica Pedotti, Giunti, Firenze 1990, p. 71).
 Lasker-Schüler E., Il mio pianoforte blu, cura e traduzione di Michele Gialdroni, Ibis, FINIS TERRAE, Como – Pavia 2022, pp.106, Euro 12.
Lasker-Schüler E., Il mio pianoforte blu, cura e traduzione di Michele Gialdroni, Ibis, FINIS TERRAE, Como – Pavia 2022, pp.106, Euro 12.
Lasker-Schüler E., Il mio pianoforte blu, cura e traduzione di Michele Gialdroni, Ibis, FINIS TERRAE, Como – Pavia 2022.
- Il mio cuore e altri scritti, traduzione e nota critica di Margherita Gigliotti e Enrica Pedotti, Giunti, Firenze 1990.
- Ballate ebraiche e altre poesie, introduzione, traduzione e note di Maura Del Serra, Giuntina Firenze, 1985; II ed., ivi 1995, con nuova introduzione ed alcune variazioni testuali e bibliografiche.
“Io costeggio l’amore, da tanto tempo vivo dimenticata – nella poesia”: vorrei accarezzare la povertà di Else Lasker-Schüler (www.pangea.news/else-lasker-schuler-ritratto/?fbclid=IwAR0FRoyi7p7tHnHS7sFrWrR4N080Axsn7sav6beVSn05ChjXJxjbo).
Antonacci A., “In vita muoio e con le immagini rinasco”. Il cuore poetico di Else Lasker-Schüler (www.metisjournal.it/metis/anno-vi-numero-2-122016-cornici-dai-bordi-taglienti/192-saggi/871-in-vita-muoio-e-con-le-immagini-rinasco-il-cuore-poetico-di-else-lasker-schueler.html?fbclid=IwAR0Mr0CRvP0mFu8Q7qWZsrylA42xLDjs0MM-nltkNW7z812oX1jCa9vdCUA)
Belski, F., Wo soll ich hin? Else Lasker-Schüler e i luoghi della poesia. Aracne, Roma 2009.
Galaverni R., Il lirismo che unì ebraismo e tedesco, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 14 agosto 2022.