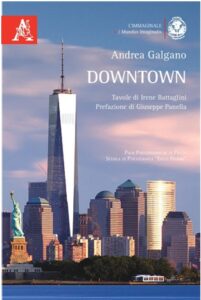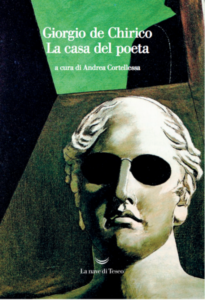di Yvette Marie Marchand*
17 gennaio 2021
leggi in pdf Downtown di Andrea Galgano – recensione di Yvette Marie Marchand
 Leggere le poesie dell’antologia “Downtown” di Andrea Galgano significa partecipare al mondo emozionale di questo giovane poeta e scrittore. Mi arriva a fior di pelle tutto il suo entusiasmo per il conoscere, per l’analizzare e per l’entrare nel tessuto dei luoghi del Nord America e nelle menti dei suoi abitanti, per sondare i loro abissi e salire sulle loro alture. In quanto, come newyorkese, questa terra appartiene anche a me, sono stata toccata fino alle emozioni più remote, più inespresse, più preziose nel leggere queste intriganti poesie: intriganti in quanto la materia dei componimenti, le immagini e le riflessioni, restituiscono un quadro allo stesso tempo curiosamente veritiero e riconoscibile dei luoghi “esaminati” e, allo stesso momento, inaspettatamente “scheggiato”, immagini distorte come se fossero viste attraverso un prisma, immagini che fuoriescono da una consapevolezza razionale, squarci di paesaggio e di vita volutamente alterate, più per svelare la sua anima che per nasconderla.
Leggere le poesie dell’antologia “Downtown” di Andrea Galgano significa partecipare al mondo emozionale di questo giovane poeta e scrittore. Mi arriva a fior di pelle tutto il suo entusiasmo per il conoscere, per l’analizzare e per l’entrare nel tessuto dei luoghi del Nord America e nelle menti dei suoi abitanti, per sondare i loro abissi e salire sulle loro alture. In quanto, come newyorkese, questa terra appartiene anche a me, sono stata toccata fino alle emozioni più remote, più inespresse, più preziose nel leggere queste intriganti poesie: intriganti in quanto la materia dei componimenti, le immagini e le riflessioni, restituiscono un quadro allo stesso tempo curiosamente veritiero e riconoscibile dei luoghi “esaminati” e, allo stesso momento, inaspettatamente “scheggiato”, immagini distorte come se fossero viste attraverso un prisma, immagini che fuoriescono da una consapevolezza razionale, squarci di paesaggio e di vita volutamente alterate, più per svelare la sua anima che per nasconderla.
L’America e i suoi “splendori”, ecco quello che ha voluto condividere Andrea Galgano con i suoi lettori: ha voluto farli partecipare al suo “rapimento” materiale e intellettuale e alla sua passione da “viaggiatore al contrario”, proveniente, cioè, dal mondo del Gran Tour, un mondo colto e “competente”: un escursionista un po’ girovago, un po’ vagabondo che parte da un’Italia che contiene l’85% delle bellezze culturali e dei monumenti del mondo e si dirige verso la giovane e, delle volte, rude America, l’America delle insegne al neon, l’America dei:
“[…] principi mendicanti, … nomadi dell’azzardo / … saccheggiatori di racket / […] / l’uomo coi pantaloni buffi, la ragazza cittadina / […] / … piccoli eroi che attraversano il denaro facile […]” (“Atlantic City Fuggiasca”),
… ma anche verso l’America delle bellezze naturali, come quelle che si intravedono in “La luce bandita (Los Angeles)” in cui possiamo ammirare l’oceano e le spiagge di Venice Beach:
“… dove le piste svernano sulle maree / e le palafitte sono sillabe trasparenti / dell’arte innominabile / e le stelle assomigliano a labbra cardinali …”,
… e poi verso l’America della natura imponente, come quei fenomeni naturali che incontriamo in “South Dakota”:
“Le terre dell’inferno spento / sono crateri che colano sulle soglie / dei fagiani dalle zampe delicate / e dai fasti piumaggi / Badlands, bende avvelenate / sulle strisce delle frontiere nere / come lune alla fine delle carezze / sono danza di spettri / colline basse e ghiaccio di laghi / scoperchiati dalle pianure / dissetate / le anime delle Grandi Pianure / dipingono la preistoria dell’arcobaleno / con il buio delle mire / la roccia scolpisce grandi volti / sul monte Rushmore …”,
e, infine, verso quella natura (anche umana), stravagante, affascinante e anche delle volte brutale, che incrociamo in “La Terra delle querce (Oakland)”:
“Il giorno sul lago Merritt / fu arrischiato di sentinelle ignare / […] / Fu odore di querce prima del chiaro / rubarono i soli alle colline / e la fedeltà cerea al cielo, / come mano remota sul panno / di argenti saturi e felici.”
Sono numerosissime le poesie raccolte in questa antologia. Raccontano le sensazioni che ha provato il poeta di fronte a praticamente tutti e 50 gli Stati e molte città degli Stati Uniti e a cospetto di molte Regioni del Canada: uno sforzo creativo rilevante da parte del poeta, che ha voluto porgere un autentico tributo a queste due nazioni e ai grandissimi spazi dei loro territori e alle corrispondenti complessità delle loro società, paesi relativamente giovani, ma che, come si evince da tanti “schizzi” poetici di Galgano, conservano echi e rimandi alla vecchia Europa a cui queste nazioni sono ancora fortemente legate.
Ci sarebbe molto da commentare su tutte le poesie di questa collezione, ma ho scelto di concentrarmi sulle poesie che cantano la mia New York City, le immagini di cui il prisma di Andrea Galgano mi ha restituito delle impressioni convincenti e riconoscibili.
Iniziamo con la Brooklyn delle mie nascite e infanzia che si è espanso da un iniziale quartiere densamente popolato e molto simile, direi forgiata nell’immagine delle grandi città di tutta l’Europa di fine ‘800 e inizio ‘900, che è venuto a trovarsi, negli anni ’50 dell’ultimo secolo e a quelli a venire, in gran parte “modernizzato” e collegato lungo la sua grande distesa di territorio al resto della città attraverso ponti e superstrade ad alta velocità come, ad esempio, la Brooklyn Queens Expressway della mia fanciullezza, eccitante per i ragazzi di allora per i suoi giganteschi pilastri di supporto e dirompente per il chiasso che produceva, che Galgano mi ha fatto ricordare, con un po’ di nostalgia, nella poesia, “Brooklyn Bridge”:
“… sono venti scoperchiati / e benzina del traffico sui sottopassi, / sole estremo sul ghiaccio relitto / e andatura di ponti che si incrociano / … / Si infiltra la intatta bellezza degli archi, / intaglia il moto delle rade dell’East River / come scroscio di candore curvato …”
nei cui versi si riesce persino a sentire il boato del traffico e respirare l’olezzo delle sue emissioni. Le immagini sono frastagliate, i suoni distorti e gli odori pungenti, come se fossero riflessi su un prisma iridescente. Anche le immagini delle persone sembrano arrivarci in alta velocità come se fossimo dentro uno di quei treni della metropolitana elevata sui binari sospesi a sbirciare dai finestrini dentro alle finestre davanti alle quali passiamo:
“… l’estremo frammento del padre / che dà da mangiare alla sua bambina / la donna che non paga e si alza sul tavolo impervio …” (“Brooklyn Heights-Prospect Park)
Andrea Galgano onora anche il quartiere di Brooklyn in cui io sono cresciuta fino a tutti gli anni del Liceo, prima di iniziare l’Università a Manhattan. Il mio Williamsburg, allora quieto luogo preminentemente residenziale abitato soprattutto da famiglie middle class di origini italiane come la mia e da ebrei, molti di questi fuggiti dalle persecuzioni in varie parte del Nord Europa e, per la maggior parte, ortodossi, gli uomini con i riccioli alle tempie e le donne con le maniche lunghe, anche d’estate e le parrucche brutte in testa per coprire la loro bellezza dagli occhi di altri uomini. Essendo distante una sola fermata di metropolitana da Manhattan, questo quartiere è ora, con musei e teatri recuperati dai grandi palazzi e dalle vecchie fabbriche, diventato proprio il centro culturale della città stessa di New York e, con i ristoranti etnici e non, ricavati dai deliziosi piccoli negozi, l’hub della vita notturna della Grande Mela:
“… o nel guado audace di Williamsburg / dove iniziano le piccole luci dei vicoli, / gli antichi negozi striati, gli oggetti raccolti / e il narciso dei murales sparpagliato ad arco / sul ponte che si collega nel suo ferro algido …” (“Northeastern and Central Brooklyn – […] Williamsburg”).
Non vengono neglette nemmeno le attrattive delle grandi e popolatissime spiagge della città di New York con “… il sudore / che increspa gli aliti caldi del vento / impigliato nelle salse di Nathan’s / e nei ghiacciati bagni …”: (Coney Island, Brighton Beach, Manhattan Beach)
… luoghi da sempre e ancora frequentatissimi dai newyorchesi, non solo d’estate e dove il famoso Nathan’s hot dog di Coney Island ancora va a ruba in tutte le stagioni.
Andrea poi ripercorre il Bronx, dove ho vissuto per una decina di anni, quelli dell’Università e dei miei primi posti di lavoro come insegnante: la zona di Fordham-Belmont, quella “dai notturni italiani / e la clessidra di Arthur Avenue / schivata nel cielo viola ruggine”, e poi il bellissimo Riverdale con le sue “garitte inafferrabili” e Pelham Parkway, dove, trasferitici da Brooklyn, vivevamo ancora, giovanastri, con i nostri genitori e dove:
“L’orlo del sole è materia disadorna, / non ho saputo capire / se i mori incroci dei laterizi / hanno ciglia e sigilli di sguardi / come scavati sillabari / nella nota dileguata prima dell’inverno / questi vicoli che obbediscono / all’appello di un ordine scuro / squilibrano gli autunni-crepuscoli / come navate in ritardo / nella notte dei numeri.”
In quel Bronx, così famigerato e biasimato in quel famoso film di Paul Newman, ma, come si evince da questi bellissimi versi, nella sua enormità di territorio, per la maggior parte molto bello, avevamo persino il mare con la sua spiaggia spartana e quasi intonsa, Orchard Beach, che (“[salì] il suo lume / tra gli occhi delle baie / senza ora di stagione / come principio di alchimia”) e con la sua bellissima isola dei pescatori, City Island, che “…si dimentica il suo segreto / nascosta nelle geometrie delle vampe / e delle ostriche …”, un posto di uno charme straordinario, pieno come si riesce ad evincere, di ristoranti di pesce e passeggiate meravigliose. Anche questo è il Bronx! (… e ringrazio Andrea per avermi dato l’occasione di mostrare i suoi lati bellissimi.)
Vorrei concludere questo piccolo scritto e anche il ringraziamento ad Andrea per avermi restituita una New York City frastagliata e, a volte, anche abbellita dai suoi versi, parlando, se posso, degli altri posti più conosciuti a me e di cui sono più “abilitata” a parlare, come Morningside Heights, dove lasciavo la metropolitana per recarmi alla mia City College e City University of New York che, insieme alla Columbia University, è sempre raggiungibile da quella fermata, un posto incantevole e incantato per una studentella come ero allora, molto giovane e inesperta, alle prime armi nei giri del mondo che avrebbe continuato a compiere fino al presente.
“… poi Morningside e le colonne della Columbia / che espone l’inclinata salvezza delle costruzioni / la chiesa di Riverside /tra le pezze sospese dell’Hudson / senza deriva di fiele
distratti dal fondale studente e dai bicchieri / i tavoli che specchiano la luce delle facciate / e il ragazzo che porta il violino, la coppia / che versa l’alba strinta del cuore / sui primi acquazzoni dell’autunno sfumato / nei lunghi sogni delle ore di chiusura / all’uscita della metropolitana …”.
Un’incontro con un “mondo nuovo” , quello dell’Università fatta a New York, che è simile, molto simile all’incontro del giovane poeta con questo “nuovo mondo” nel suo complesso.
Nessuna parte della City è trascurato da Andrea Galgano, dall’Uptown, dove, nella elegante Yorkside ho vissuto come giovanissima single con i suoi “… pianeti appena aperti …” al Downtown ricordato nel titolo, dal Village (East e West) al Lower East Side, da Chinatown a Little Italy, tutti minuziosamente fotografati e fatti suoi. Un lavoro sconfinato come le frontiere dei luoghi che lui ha scelto di cantare.
* Professore associata presso Università degli Studi di Perugia