di Andrea Galgano Prato, 25 maggio 2013
POESIA CONTEMPORANEA
pdf: 87 25 05 2013 I DESTINI DI EDGAR LEE MASTERS
 L’Antologia di Spoon River del poeta statunitense Edgar Lee Masters (1868-1950), con le sue oltre sessanta edizioni in italiano, è il libro che ha avuto più lettori di qualsiasi altro libro della poesia contemporanea. Ne sono stati tratti dischi, come, ad esempio, Non al denaro non all’amore né al cielo (1971) di Fabrizio De Andrè, che ha liberamente tradotto e trasformato nove poesie della raccolta.
L’Antologia di Spoon River del poeta statunitense Edgar Lee Masters (1868-1950), con le sue oltre sessanta edizioni in italiano, è il libro che ha avuto più lettori di qualsiasi altro libro della poesia contemporanea. Ne sono stati tratti dischi, come, ad esempio, Non al denaro non all’amore né al cielo (1971) di Fabrizio De Andrè, che ha liberamente tradotto e trasformato nove poesie della raccolta.
Fernanda Pivano, in una serie di articoli del «Corriere d’informazione», ha rievocato la genesi della prima edizione del 9 marzo 1943:
«Ero una ragazzina quando vidi per la prima volta l’Antologia di Spoon River: me l’aveva portata Pavese, una mattina che gli avevo chiesto che differenza c’è tra la letteratura americana e quella inglese. Si era tanto divertito alla mia domanda; si era passato la pipa dall’altra parte della bocca per nascondere un sorriso e non mi aveva risposto. Naturalmente c’ero rimasta malissimo; e quando mi diede i primi libri “americani” li guardai con grande sospetto. Ma l’Antologia di Spoon River la aprii proprio alla metà, e trovai una poesia che finiva così: «mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, l’anima d’improvviso mi fuggì». Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato: è così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti. Forse mi ricordavano un epigramma di Platone che avevo trovato nell’Antologia Palatina […]; o forse mi piaceva che un poeta ricominciasse a preoccuparsi di quello che succede quando un uomo bacia una ragazza; chi lo sa»
All’uscita della raccolta, Edgar Lee Masters venne paragonato a Dante, Eschilo, Zola o lo stesso Omero, che viene evocato in Blind Jack, ossia Jack il cieco. Oltre agli apprezzamenti per la musica dei versi e la vitalità accesa, arrivarono anche le accuse di realismo sordido e uno strano gusto per la rozzezza e la corruzione.
In Italia, Pavese convinse l’editore Einaudi a pubblicarlo, perché si trattò di «un bellissimo libro che non è poi di liriche, ma di personaggi; un libro che, a detta degli Americani stessi, contiene tutta l’America attuale», avendolo conosciuto grazie ad Antonio Chiuminatto, un amico italo-americano che gli spediva libri introvabili.
Annota Oreste Macrì: «Masters resta un maestro nell’aver scoperto la sorgente poetica del suo popolo, il singolare accento terrestre e familiare dell’essere comune, il piedistallo degli ultimi simboli celati nei duri e allucinati pezzi del reale».
Quando uscì il testo, Masters, pur nascendo con la passione letteraria, era un avvocato di successo che svolgeva il suo lavoro senza entusiasmo. Fu il padre a costringerlo a seguire la sua professione e, durante l’infanzia trascorsa a Petersburg e poi a Lewistown, ricordò di aver provato gli «spasimi per qualcosa che sembrava lontano nella vita, per quando sarei divenuto maturo; ma quel qualcosa era sempre più distante – è distante adesso, e lo sarà sempre».
L’inquietudine febbrile che lo spinse alla lettura di Goethe e a lavorare come strillone, tipografo e portatore di carbone per comprarsi da leggere, più tardi dirà, lo renderà affamato di poesia: «Scrivevo poesie a casa, all’ufficio, dappertutto, sulle liste della trattoria, sulle buste delle lettere».
Jorge Louis Borges, nella sua biografia sintetica di Masters riporta alla luce quel periodo: «trascorse… un’infanzia di acqua e di alberi e di passeggiate a cavallo o in carrozza. E anche di libri, perché nella casa dei Masters vi era uno Shakespeare dolorosamente illustrato, un esemplare delle avventure di Tom Sawyer e uno dei racconti di Grimm».
Dopo aver studiato allo Knox Village, si trasferì a Chicago per ribellione, finendo per lavorare in un ufficio legale.L’idea buona, da tempo coltivata, di scrivere la storia del suo villaggio, gli venne su un suggerimento del direttore di un giornale di St. Louis, il Reedy’s Mirror, che gli consigliò di leggere dei testi dell’Antologia Palatina, una raccolta di epigrammi e epitaffi di più di trecento poeti, a partire dal IV sec. a. C. fino alla tarda età bizantina.
Sotto lo pseudonimo di Webster Ford, iniziò a inviare i primi testi a William M. Reedy che glieli pubblicò, fino a raggiungere i 244, nell’edizione definitiva nel 1916. Nove anni dopo, nel 1924, pubblicò la raccolta The New Spoon River, nel contesto dello sviluppo della vita industriale, ma il successo non fu identico.
Masters visse della rendita dei diritti d’autore, abbandonando l’avvocatura, e continuando, finchè potè, a scrivere numerosi sonetti, lavori teatrali e poemetti storici, ma tutti sfortunati e di scarso successo. Nonostante le interessanti biografie, prime fra tutte quelle di Twain e Whitman e un’autobiografia, morì in disgrazia, per una polmonite, all’età di ottantun anni in Pennsylvania e sepolto a Petersburg.
Il suo epitaffio, To-morrow is My Birthday, tratto da Toward the Gulf, recita: «Buoni amici, andiamo ai campi… / Dopo una piccola passeggiata e vicino al tuo perdono, / Penso dormirò, non c’è cosa più dolce. / Nessun destino è più dolce di quello di dormire. Sono un sogno di un riposo benedetto, / Camminiamo, e ascoltiamo l’allodola».
L’ «autore di un solo libro», come scrisse Mario Praz, racconta la vita ordinaria degli abitanti di Petersburg, cittadina dell’Illinois, bagnata dal Sangamon, dove fisse fino agli 11 anni e di Lewistown, sempre nell’Illinois, bagnata dal fiume Spoon, dove egli rimase fino all’età di 22 anni.
Le vite degli abitanti del Midwest vengono condensate in pochi versi, come epitaffi sulle loro tombe. Annota Antonio Spadaro:
«Di fronte alla morte non c’è schermo che resista, e così gli epitaffi si rivelano come brucianti confessioni che ora manifestano storie segrete, ora stati di coscienza, ora verità innominabili. Non c’è più velo o barriera: le infedeltà coniugali sono svelate, gli interessi segreti sono dichiarati, le astuzie smontate e le falsità annullate. Ogni esistenza è un microcosmo individuale, che però si innalza a descrivere quel macrocosmo che è la vita umana. Spesso i singoli personaggi ne citano altri, e così è possibile leggere ogni storia da punti di vista differenti: i fili che partono da questi epitaffi si intrecciano tra loro, anche in uno scontro di destini».
La pagina-lapide che inscena dettagli, gesti, frammenti, destina figure nel significato morale delle azioni come exempli, in un linguaggio moderno e quasi monologante, rappresenta l’avvolgimento di una vita immortale.
La poesia unisce le linee misteriose della vita e della morte, identifica, ad esempio, i personaggi nel mestiere che svolgono e nel loro volo di istanti, come accade a Dippold l’ottico: «Che cosa vedete adesso? / Globi di rosso, giallo, porpora. / Un momento! E adesso? / Mio padre e mia madre e le mie sorelle. / Sì! E adesso? / Cavalieri in armi, belle donne, visi gentili. / Provate questa. / Un campo di grano – una città. / Molto bene! E ora? / Una giovane donna e angeli chini su di lei […] Provate questa lente. / abissi d’aria. / magnifico! E ora? Luce, soltanto luce, che fa di ogni cosa sottostante un mondo giocattolo. / Benissimo, faremo gli occhiali così».
Pavese scrive: «[…] vivendo noi tutti nel mondo delle cose dei fatti dei gesti, che è il mondo del tempo, il nostro sforzo inconsapevole e incessante è un tendere, fuori del tempo, all’attimo estatico che ci farà realizzare la nostra libertà. Accade perciò che le cose i fatti i gesti – il passare del tempo – ci promettano di questi attimi, li rivestano, li incarnino, ed essi divengano simboli della nostra liberata coscienza».
Il frammento dell’esistenza diviene il simbolo di un collegamento che la morte ha reso solenne e «inchiodato all’anima». La bruciante confessione, narrata nello stile confacente al personaggio, rende ragione a una commedia umana di tasselli diseguali, che non riescono a nascondere all’infinito il magma del nostro essere, lo specchio impietoso di una emersione personalissima, il gemito di una conoscenza, libera da ogni convenzione, dovere o insano bigottismo, come accade in questo ritratto dell’Editore Whedon:
«Per denaro insabbiare uno scandalo / o divulgarlo ai quattro venti per vendetta, / o per vendere il giornale / distruggendo reputazioni, o vite, se necessario / per vincere a ogni costo, salvo la pelle propria. / gloriarsi in un potere demoniaco, minare la civiltà, / come un ragazzo paranoico butta un tronco sulle rotaie / e l’espresso deraglia. / essere direttore, com’ero io. / poi, giacer mene qui – vicino al fiume / dove sbocca la fogna, / e scatole vuote e immondizie finiscono, / e si nascondono gli aborti».
Considerare la poesia di Spoon River, solo ed esclusivamente per gli aspetti libertari, anti-puritani, per rendere Edgar Lee Masters «un ben misero e trascurabile libellista», è un errore di valutazione in cui si gioca il vigore del testo, che rimane inquadrabile nel «problema del senso dell’esistenza» e «nel problema delle proprie azioni: ardore e problemi essenzialmente morali e di non lontano sapore biblico» (Cesare Pavese).
La domanda d’infinito sull’aldilà è impregnata dal senso del limite e della morte, della fine come premessa autentica di chi ha attraversato, oltrepassandola, la caduta del compimento, in un mondo avviato alla scomparsa, ma non del tutto finito.
Il passaggio di questa persona viva nella fine e anche nella mortificata esistenza quotidiana, tracciata con realismo vivido e con messaggio solenne e universale, rende una perfetta fusione di soggettivismo e oggettività, per «dare una consistenza monumentale a ciò che v’è di più labile e irripetibile nell’animo umano» (Eugenio Montale), in un «verseggiare – conclude Pavese – così sobrio e pacato, che ha semplicemente l’ufficio di segnare il pensiero».
La condizione altra dell’aldilà non conclude «il chimico flusso circolare della vita» e personaggi come Conrad Siever, si aggirano «nel suolo e nella carne dell’albero» o di Marie Bateson:
«Vedete la mano scolpita / con l’indice puntato al cielo. / è questa la direzione, non c’è dubbio. / Ma come si può seguirla? / il bene è astenersi dall’assassinio e dalla lussuria, / perdonare, beneficare gli altri, adorare Dio / senza immagini. / Ma in fondo queste non sono che cose esterne / con cui più che altro si fa del bene a se stessi. / Il nocciolo interno è liberta, / è luce, purezza… ».
L’America degli sconfitti, che promana il suo trapasso come «l’alba della vita / che è pienezza di vita» (Jeremy Carlisle), permane nell’acuta tensione vitale della tomba che è un transito di ombre e non un approdo, come avviene in George Gray:
«Molte volte ho studiato / la lapide che mi hanno scolpito: / una barca con vele ammainate, in un porto. / In realtà non rappresenta la mia destinazione / ma la mia vita. / Perché l’amore mi fu offerto e io mi ritrassi dalla sua delusione; / il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; / l’ambizione mi chiamò, ma io temetti i rischi. / eppure avevo fame di un significato nella vita. / ora so che bisogna alzare le vele / e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. / Dare un senso alla vita può condurre a follia / ma una vita senza senso è la tortura / dell’inquietudine e del vago desiderio – / è una barca che anela al mare eppure lo teme».
La coscienza dell’esistenza socchiusa nel coro tragico cerca il compimento ultimo con «tanta sete d’amore e tanta fame di vita» (Minerva Jones) e ogni volta rinnova il suo andamento, verso l’inseguimento di una visione e di una tensione che smonta le vanità e che espone la sua vita ammaccata, eppure racchiude ironia, scacco, profondità.
L’inquietudine non rifluisce nel disincanto, ma anzi, nel vortice di un’eterna attesa promana il suo dramma sacro e di «saggezza evangelica» (Cesare Pavese).
La visione, pertanto, riesce a cogliere il segreto indecifrabile della vita, il mistero di una mistica popolare e semplice, che allorquando tocca frustrazione e durezza, non termina nella protesta, ma rinviene un’apertura ampia oltre il grigiore mortale, oltre l’ansia di una felicità perduta e distrutta:
«La terra ti suscita / vibrazioni nel cuore / e quello sei tu. / E se la gente scopre che sai suonare il violino / ecco, sei costretto a suonare, per tutta la vita. / […] Mai una volta diedi mano all’aratro, / che qualcuno non si fermasse per la strada / e mi portasse via a una danza o a un picnic. / finii con quaranta acri; / finii col violino scassato – / e una risata rotta, e mille ricordi / e nemmeno un rimpianto».
I morti dormono sulla collina, non solo legati alla terra, ma perché ciò che hanno vissuto con il loro vestito di errori, passioni, generosità, meschinità, rappresenta una continuità umana anche dall’altra parte, mentre è in gioco il senso del loro essere e del loro situarsi.
L’attesa di un’esperienza cerca e desidera il destino, nel marmo che compone l’anelito di una visione che accoglie il segreto dell’esistere, per una intima e richiamata promessa.
MASTERS LEE E., Antologia di Spoon River, Einaudi, Torino 2009.
Macrì O., «Antologia americana», in “La Gazzetta di Parma”, 27 maggio 1957.
MONTALE E., «Celebre e sconosciuto l’autore di Spoon River», in “Corriere della Sera”, 8 marzo 1950.
PAVESE C., Lettere 1924-1944, Einaudi, Torino 1966.
ID., La letteratura americana e altri saggi, Einaudi, Torino 1990.
PRAZ M., «Tragica arguzia di Spoon River», in “Il Tempo”, 10 marzo 1950.
SPADARO A., «”Il poeta dei destini”: E. L. Masters. “Antologia di Spoon River”», in «La Civiltà Cattolica», II, 2004, pp. 230-241.
© articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta®
www.polopsicodinamiche.com www.polimniaprofessioni.com
Andrea Galgano 25-05-2013 I destini di Edgar Lee Masters

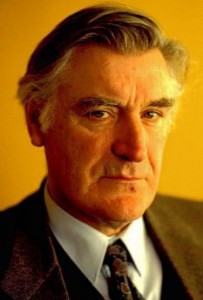


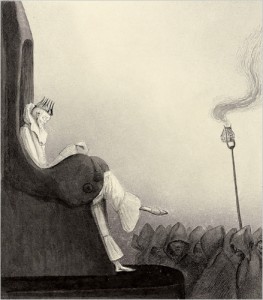 La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.
La vera funzione dell’Arte è rivelare la bellezza nascosta, l’impronta divina che è in tutte le cose.



