di Andrea Galgano 15 febbraio 2022
leggi in Pdf Claudio Damiani Prima di nascere
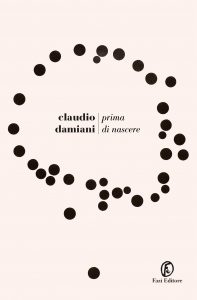 Prima di nascere di Claudio Damiani[1], appena edito da Fazi, è l’esito di un contrasto di una pre-nascenza e di una co-nascenza. Nella domanda sull’essere e sul nulla, nell’approvvigionamento essenziale del respiro, nella vertigine mai opaca del tempo e nella sospensione, la poesia di Damiani conosce questa dimensione del sangue e del sospiro e si appropria, dunque, di questo interstizio di esplorazione[2] tra cielo e terra:
Prima di nascere di Claudio Damiani[1], appena edito da Fazi, è l’esito di un contrasto di una pre-nascenza e di una co-nascenza. Nella domanda sull’essere e sul nulla, nell’approvvigionamento essenziale del respiro, nella vertigine mai opaca del tempo e nella sospensione, la poesia di Damiani conosce questa dimensione del sangue e del sospiro e si appropria, dunque, di questo interstizio di esplorazione[2] tra cielo e terra:
«Quando ero piccolo, quattro-cinque anni, / mi immaginavo prima di nascere / come sospeso nel cielo ( non so se qualcuno mi aveva detto / queste cose, o me l’ero immaginato io), / mi sembrava incredibile non essere esistito prima / e mi sembrava incredibile pure di essere esistito, / non capivo dove potevo stare, così in alto nel cielo, / dove potevo poggiare i piedi».
Si confronta con lo stupore esile delle cose, con i contrasti e con la paura, con gli ossimori esiziali del vivere e diviene poesia della misura e del colloquio, e, come aggiunge Davide Rondoni,
«del nitore, del debito oraziano e cinese, il poeta delle ariose e commoventi poesie sul fico, sull’infanzia, sull’Elba, sul Soratte, sui ragazzini a scuola, sugli “eroi” del feriale, ecco, questo poeta ha per così dire raccolto, quasi “costretto” tutte queste cose e voci e figure, le ha convocate, quasi citate in giudizio dinanzi al tribunale del tempo e della morte. E soprattutto ha citato in giudizio se stesso, la sua personale vicenda o guerra. Nudamente, spudoratamente. Con la sincerità di sempre, ma ancor più resa estrema, cordiale ma anche puntuta, dal confronto con il tema dei temi, la morte, appunto, e la sua ombra, ovvero la speranza – e viceversa».[3]
Vi è l’attesa e la minaccia, la saggezza di voltarsi dall’altra parte[4], che non è appena un disinteresse nichilistico ma semplicemente una deviazione, una feriale quanto magmatica sproporzione di sguardo.
Questo disarmo è un lievito di aria fresca che entra nel sangue, il corpo che si mischia alle nuvole che avvolgono la dimora del tempo abitabile, come archetipi di infanzia, nella vastità ampia del futuro e nell’interezza di un abbandono epifanico:
«Le farfalle mi venivano incontro / erano quelle piccole azzurre / della mia infanzia che volevamo acchiappare / ma anche cavolaie che volavano a coppie tra i cespugli / e farfalle notturne che mi facevano paura / tra i gradini della scala di casa, / mi venivano incontro e io le accarezzavo / e le baciavo, era come se volassi / nello spazio e mi venivano incontro / corpi celesti, asteroidi, comete / e io li sfioravo e li accarezzavo / e in ognuno abitavo / per qualche tempo, poi ritornavano le farfalle azzurre / e tutte le altre e si diradavano, / si vedeva che andavano in un luogo / come un centro di raccolta / forse andavano a riposare, a mangiare non so, / e io restavo solo / in un cielo completamente vuoto, / completamente solo».
E poi ancora, in quella ampia attesa cerca la risposta alle domande che non si riescono a dimenticare, non si accartoccia mai sul nulla, sulla finitudine e sul limite, bensì si appropria di un tempo che è di luce ed è incombente:
«Sto qui in attesa che il tempo passi / poi finirà e sarà come staccare / l’interruttore, come tagliare le vene / e non si sa cosa succederà / staremo al buio, o alla luce / o non staremo, non saremo niente / (anche se sembra impossibile che questo possa accadere, / da ricerche accreditate sembra che il nulla non possa esistere) / perché sappiamo tanto, abbiamo tanta scienza / ma di noi non sappiamo niente, / e con la scienza, con la tecnologia / ancor più stride la nostra mortalità / e precarietà, come se più la allontanassimo / la morte, più diventasse incombente / e insopportabile. Noi nati alla morte, / noi morituri ti salutiamo, o Cesare, / sfiliamo rigidi davanti al giorno / e nella mano abbiamo la medaglietta / e la stringiamo, col nostro numero inciso».
E se il dato della nascita non fosse che una volontà, una scelta come un piccolo passo («Se fossimo noi che abbiamo scelto di vivere / e di morire, come se qualcuno / ci avesse mandato in missione, / estratti a sorte, / o se ci fossimo fatti avanti, / avessimo fatto un passo, un piccolo passo…»), un’adesione al vivere, quando «con una spinta abbiamo bucato il mondo»?
L’emersione della poesia di Damiani è una conca di abissi, che fronteggiano anche la memoria, il niente (ancor prima del nulla), ma esplorano e vivono la percezione della natura e lo splendore lieve e dolce.
Un orizzonte esile, un fiancheggiamento di alberi, animali, fiumi, che esplodono di grazia nell’antichità ma si rivestono del tempo presente, del deposito del tempo presente.
L’universo nello sguardo, la prosa-mantra, la traccia del “quasi nulla”, lo scrutare lieve che sfida le tempeste e la lontananza, il fuoco e le fiamme invisibili dell’abisso che tiene sospesi, perché nella cifra di ogni tremore[5], «Il mistero è così fitto / e noi così fragili / che non ci sono speranze / o meglio, possono esserci solo speranze, / la speranza è la nostra scienza»:
«La polvere guardo nell’aria / e questa polvere sopra il tavolo / non la tolgo, la lascio, / voglio stare accanto a lei / e dei fili che sono per terra / non li levo, e le orme / delle scarpe, le lascio / e questa mosca anche lascio, morta / e questa cosa che era caduta per terra / e non so più dov’è / non so più che era. / E mi deposito anch’io / mi lascio andare sul letto, / lascio che l’aria mi circondi / come un ciottolo che la corrente trascina, / e che niente mi salvi».
La linea agostiniana[6] e rabdomantica trova la fecondità nel tremito fisso della carezza e della domanda, il nitore puro del cielo e il grande trapezio del mistero che avvolge il tempo:
«Pensa se fosse così: / che noi, mentre stiamo facendo una cosa / comunissima, tipo portare una cosa / sopra un tavolo, oppure cercarla / e ecco aprirsi una porta, e nella stanza / ci sono tutti! È una stanza immensa / e ti salutano gioiosi e applaudono / come un compleanno a sorpresa / e dicono: «Hai visto? Sei contento? / Come stai? Come ti senti?» / e tu lo senti che è stata come uno scherzo la vita / o un brutto sogno, oppure è stata / come una guerra sotto i bombardamenti / e ogni giorno c’erano le sirene, / o c’erano stati giorni belli anche, / di sole, di luce, di silenzio / tu camminavi da solo / in mezzo alle piante amiche»
[1] Damiani C., Prima di nascere, Fazi, Roma 2022.
[2] Guidi S., Punte di fiamma invisibili, in “L’Osservatore Romano”, 3 febbraio 2022.
[3] Rondoni D., Claudio trema. Su Claudio Damiani, “Prima di nascere”, in «Clandestino – Rivista», (www.rivistaclandestino.com/claudio-trema-su-claudio-damiani-prima-di-nascere/?fbclid=IwAR2_ZSRHZ3dIa4Vva2nUpKf-dIKUGuzBdzxmLLGWmkgCxn_XEmtx4H9pS0A), 7 febbraio 2022.
[4] Langone C., Il poeta Claudio Damiani ci insegna la saggezza del voltarsi dall’altra parte, in “Il Foglio”, 9 febbraio 2022.
[5] Minore R., Un classico travestito da contemporaneo, in “Il Messaggero”, 13 febbraio 2022.
[6] Affinati E., La poesia «dantesca» di Damiani, in “Roma Sette”, inserto di “Avvenire”, 13 febbraio 2022.
Damiani C., Prima di nascere, Fazi, Roma 2022, pp. 152, Euro 18.
Damiani C., Prima di nascere, Fazi, Roma 2022.
Affinati E., La poesia «dantesca» di Damiani, in “Roma Sette”, inserto di “Avvenire”, 13 febbraio 2022.
Guidi S., Punte di fiamma invisibili, in “L’Osservatore Romano”, 3 febbraio 2022.
Langone C., Il poeta Claudio Damiani ci insegna la saggezza del voltarsi dall’altra parte, in “Il Foglio”, 9 febbraio 2022.
Minore R., Un classico travestito da contemporaneo, in “Il Messaggero”, 13 febbraio 2022.
Rondoni D., Claudio trema. Su Claudio Damiani, “Prima di nascere”, in «Clandestino – Rivista», (www.rivistaclandestino.com/claudio-trema-su-claudio-damiani-prima-di-nascere/?fbclid=IwAR2_ZSRHZ3dIa4Vva2nUpKf-dIKUGuzBdzxmLLGWmkgCxn_XEmtx4H9pS0A), 7 febbraio 2022.


