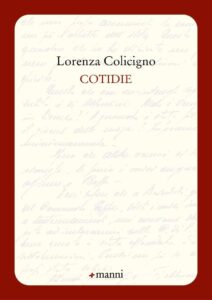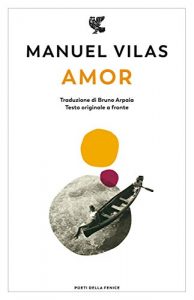A cura di Emanuele Emma ed Emanuela Falco.
A cura di Emanuele Emma ed Emanuela Falco.
Introduzione
Joyce Carol Oates è una scrittrice, poetessa, drammaturga e accademica statunitense.
Autrice e intellettuale americana eclettica, tra le più prolifiche della letteratura americana, ha pubblicato il primo libro nel 1963.
Da allora, ha frequentato ogni genere letterario in prosa e in versi: romanzi, racconti, narrativa per l’infanzia, poesie, drammaturgie, saggi.
Nell’arco di sessant’anni ha pubblicato oltre cento libri, alcuni dei quali, per la maggior parte romanzi del mistero, pubblicati sotto lo pseudonimo di Rosamond Smith e Lauren Kelly.
Ha vinto numerosi premi letterari, incluso il National Book Award, due O. Henry Award, la National Humanities Medal e il Jerusalem Prize nel 2019; è stata inoltre finalista del Premio Pulitzer sia per i romanzi Acqua nera (1992), What I Lived For (1994) e Blonde (2000), che per le raccolte di racconti The Wheel of Love (1970) e Lovely, Dark, Deep: Stories (2014).
Oates ha insegnato alla Princeton University dal 1978 al 2014 ed è Roger S. Berlind ’52 Professor Emerita in the Humanities col corso di Scrittura Creativa.
Insegna “Short Fiction” alla University of California di Berkeley ed è membro del consiglio di amministrazione della John Simon Guggenheim Memorial Foundation.
Con American Melancholy mette in mostra alcuni dei suoi migliori lavori degli ultimi decenni.
Coprendo soggetti grandi e piccoli, questa collezione tocca sia il personale che il politico.
Vengono indagate la perdita, l’amore e la memoria, insieme agli sconvolgimenti della nostra epoca moderna, le devastazioni della povertà, del razzismo e dei disordini sociali.
Sinkholes
take you where
you don’t want to go.
Where you’d been
and had passed smilingly through,
and were alive. Then.
Le Voragini
ti portano dove
non vuoi andare.
Dove sei stato
e dove sei passato sorridendo
ed eri vivo. Allora.
Too Young to Marry but Not Too Young to Die
Drowned together in his car in Lake Chippewa.
It was a bright cold starry night on Lake Chippewa.
Lake Chippewa was a “living” lake then,
though soon afterward it would choke and die.
In the bright cold morning after we could spy
them only through a patch of ice brushed clear of snow.
Scarcely three feet below,
they were oblivious of us.
Together beneath the ice in each other’s arms.
Jean-Marie’s head rested on Troy’s shoulder.
Their hair had floated up and was frozen.
Their eyes were open in the perfect lucidity of death.
Calmly they sat upright. Not a breath!
It was 1967, there were no seat belts
to keep them apart. Beautiful
as mannequins in Slater Brothers’ window.
Faces flawless, not a blemish.
Yet—you could believe
they might be breath-
ing, for some trick
of scintillate light revealed
tiny bubbles in the ice,
and a motion like a smile
in Jean-Marie’s perfect face.
How far Troy’d driven the car onto Lake Chippewa
before the ice creaked, and cracked, and opened
like the parting of giant jaws—at least fifty feet!
This was a feat like his 7-foot-3.8-inch high jump.
In the briny snow you could see the car tracks
along the shore where in summer sand
we’d sprawl and soak up sun
in defiance of skin carcinomas to come. And you could see
how deftly he’d turned the wheel onto the ice
at just the right place.
And on the ice you could see
how he’d made the tires spin and grab
and Jean-Marie clutching his hand Oh oh oh!
The sinking would be silent, and slow.
Eastern edge of Lake Chippewa, shallower
than most of the lake but deep enough at twelve feet
to suck down Mr. Dupuy’s Chevy
so all that was visible from shore
was the gaping ice wound.
And then in the starry night
a drop to -5 degrees Fahrenheit
and ice freezing over the sunken car.
Who would have guessed it, of Lake Chippewa!
Now in the morning through the swept ice
there’s a shocking intimacy just below.
With our mittens we brush away powder snow.
With our boots we kick away ice chunks.
Lie flat and stare through the ice
Seeing Jean-Marie Schuter and Troy Dupuy
as we’d never seen them in life.
Our breaths steam in Sunday-morning light.
It will be something we must live with—
the couple do not care about our astonishment.
Perfect in love, and needing no one to applaud
as they’d been oblivious of our applause
at the Herkimer Junior High prom where they were
crowned Queen and King three years before.
(In Herkimer County, New York, you grew up fast.
The body matured, the brain lagged behind,
like the slowest runner on the track team
we’d applaud with affection mistaken for teen mockery.)
No one wanted to summon help just yet.
It was a dreamy silence above ice as below.
And the ice a shifting hue—silvery, ghost-gray, pale
blue—as the sky shifts overhead
like a frowning parent. What!
Lake Chippewa was where some of us went ice-fishing
with our grandfathers. Sometimes, we skated.
Summers there were speedboats, canoes. There’d been
drownings in Lake Chippewa we’d heard
but no one of ours.
Police, fire-truck, ambulance sirens would rend the air.
Strangers would shout at one another.
We’d be ordered back—off the ice of Lake Chippewa
that shone with beauty and onto the littered shore.
By harsh daylight made to see
Mr. Dupuy’s 1963 Chevy
hooked like a great doomed fish.
All that privacy yanked upward pitiless
and streaming icy rivulets!
We knew it was wrong to disturb the frozen lovers
and make of them mere bodies.
Sweet-lethal embrace of Lake Chippewa
But no embrace can survive thawing.
One of us, Gordy Garrison, would write a song,
“Too Young to Marry But Not Too Young to Die”
(echo of Bill Monroe’s “I Traced Her Little Footprints
in the Snow”), which he’d sing with his band the Raiders,
accompanying himself on the Little Martin guitar
he’d bought from his cousin Art Garrison
when Art enlisted in the U.S. Navy and for a while
it was all you’d hear at Herkimer High, where the Raiders
played for Friday-night dances in the gym, but then
we graduated and things changed and nothing more
came of Gordy’s song or of the Raiders.
“TOO YOUNG TO MARRY BUT NOT TOO YOUNG TO DIE”
was the headline in the Herkimer Packet.
We scissored out the front-page article, kept it for decades in a
bedroom drawer.
(No one ever moves in Herkimer except
those who move away, and never come back.)
The clipping is yellowed, deeply creased,
and beginning to tear. When some of us stare
at the photos our hearts cease beating—oh, just a beat!
It was something we’d learned to live with—
there’d been no boy desperate to die with any of us.
We’d have accepted, probably—yes.
Deep breath, shuttered eyes—yes, Troy.
Secret kept yellowed and creased in the drawer,
though if you ask, laughingly we’d deny it.
We see Gordy sometimes, and his wife, June. Our grand-
children are friends. Hum Gordy’s old song
to make Gordy blush a fierce apricot hue
but it seems cruel, we’re all on blood
thinners now.
Troppo Giovani per Sposarsi Ma Non Troppo per Morire
Annegarono insieme nella sua auto nel lago Chippewa.
Avvenne in una notte stellata, fredda e luminosa.
Il lago Chippewa era un lago “in vita” all’epoca
anche se poco dopo soffocò e morì.
Nella fulgida e fredda mattinata seguente, dopo esser riusciti a spiarli
solo attraverso una lastra di ghiaccio ripulita dalla neve.
Un metro poco più sotto,
non si erano accorti di noi.
Insieme sotto il ghiaccio l’uno tra le braccia dell’altro.
La testa di Jean Marie appoggiata sulla spalla di Troy.
I capelli erano riemersi in superficie e si erano ghiacciati.
Gli occhi erano aperti nella perfetta lucidità della morte.
Seduti beatamente. Neanche un respiro!
Era il 1967 e non c’erano cinture di sicurezza
a separarli. Belli
come manichini nella vetrina dei fratelli Slater.
Volti illesi, neanche un graffio.
Potevi credere
che stessero respiran-
do, dal momento che, qualche scintillante
riflesso della luce rivelava
bollicine nel ghiaccio,
e l’accenno di un sorriso
sul volto perfetto di Jean-Marie.
Fino a che punto Troy aveva guidato la macchina sul lago Chippewa
prima che il ghiaccio scricchiolasse, cedesse, e si aprisse
come giganti mascelle – almeno di quindici metri!
Un risultato come il salto in alto di Troy, 2 metri e 96 centimetri.
Nella neve salmastra erano visibili le tracce della macchina
sulla sabbia della spiaggia in cui d’estate
ci stravaccavamo e prendevamo il sole
sfidando il tumore della pelle a colpirci. E si poteva vedere
con quanta destrezza avesse girato il volante sul ghiaccio
proprio al punto giusto.
Si poteva notare
come avesse fatto girare e aderire le gomme alla superficie ghiacciata
e avesse fatto afferrare a Jean Marie la sua mano Oh oh oh!
L’inabissamento fu lento, e silenzioso.
La sponda est del lago Chippewa, meno profonda
di gran parte del lago, ma profonda abbastanza (3 metri)
da risucchiare la Chevy del Signor Dupuy,
rese visibile dalla spiaggia soltanto
la voragine nel ghiaccio.
E poi nella notte stellata
una caduta di 5 gradi Fahrenheit
e il ghiaccio si riformò sulla macchina sommersa.
Chi l’avrebbe mai detto del lago Chippewa!
Ora, di mattina, sotto al ghiaccio ripulito
c’è un’intimità scioccante.
Con i guanti portiamo via cumuli di neve farinosa.
Con gli stivali calciamo pezzi di ghiaccio.
Increduli lo fissiamo
Vedendo Jean-Marie Schuter e Troy Dupuy
come non li avevamo mai visti in vita.
La condensa dei nostri respiri nella luce di una domenica mattina.
Sarà qualcosa con cui dobbiamo convivere –
alla coppia non importa del nostro sconcerto.
Perdutamente innamorati, senza alcun bisogno di applausi
essendo stati ignari dei nostri applausi
al ballo della Herkimer Junior High dove
tre anni prima furono nominati re e reginetta.
(Nella Contea di Herkimer, New York, siete cresciuti in fretta.
Il corpo è maturato, il cervello è rimasto indietro
come il più lento maratoneta della squadra
applaudivamo con affetto scambiato per derisione adolescenziale.)
Nessuno voleva ancora chiamare i soccorsi.
C’era un silenzio sognante sopra il ghiaccio così come sotto.
E cambiava tonalità – argento, grigio-fantasma, blu
pallido – come il cielo cambia sopra di noi
quanto un genitore arrabbiato. Come!?
Il lago Chippewa era il luogo in cui alcuni di noi andavano a pescare
con i loro nonni. A volte, andavamo a pattinare.
In estate c’erano motoscafi, canoe. C’erano stati
annegamenti nel lago Chippewa di cui avevamo sentito
ma nessuno dei nostri.
Polizia, camion dei pompieri, sirene d’ambulanza squarciavano l’aria.
Sconosciuti si urlavano contro.
Ci era stato ordinato di allontanarsi dal ghiaccio del lago
che irradiava bellezza e di dirigerci verso la spiaggia affollata.
Dalla crudele luce diurna sorta per vedere
la Chevy del 1963 del signor Dupuy
agganciata all’amo come un grande pesce predestinato.
Tutta quella privacy tirò fuori fiumiciattoli di ghiaccio
che scorrevano senza pietà!
Sapevamo che fosse sbagliato disturbare gli
amanti congelati e renderli meri corpi.
La morsa dolce e letale del lago Chippewa
Ma nessuna morsa sopravvive al disgelo.
Uno di noi, Gordy Garrison, avrebbe scritto una canzone.
“Too Young to Marry but Not Too Young to Die”
(riecheggi di “I Saw Her Little Footprints
in the Snow” di Bill Monroe), che cantava con la sua band “The Raiders”,
accompagnandosi alla chitarra Little Martin
che aveva comprato da suo cugino Art Garrison
quando Art si era arruolato nella marina americana e per un po’
era l’unica cosa in auge alla Herkimer High, i Raiders
suonavano ai balli del venerdì sera in palestra, ma poi
ci diplomammo e le cose cambiarono e nient’altro
uscì fuori dalla canzone di Gordy o dai Raiders.
“TOO YOUNG TO MARRY BUT NOT TOO YOUNG TO DIE”
fu la prima pagina dell’Herkimer Packet.
Ritagliammo l’articolo e lo conservammo per decenni in un
comò.
(Nessuno si iscrive alla Herkimer eccetto
coloro che poi si trasferiscono e non tornano più.)
Il ritaglio è ingiallito, terribilmente sgualcito,
e sta iniziando a lacerarsi. Quando alcuni di noi guardano
le foto i nostri cuori cessano di battere – oh, solo un battito!
Fu una cosa con cui imparammo a vivere –
non ci fu nessun ragazzo fremente di morire tra di noi.
Avremmo accettato, probabilmente – sì.
Respiro profondo, occhi sbarrati – sì, Troy.
Un segreto mantenuto stropicciato e ingiallito nel comò
però, se doveste chiedercelo, ridendo negheremmo.
A volte vediamo Gordy, e sua moglie, June. I nostri nipo-
ti sono amici. Canticchiamo la sua vecchia canzone
per farlo arrossire
ma sembra crudele, siamo tutti sotto anti
coagulanti ora.
Hometown Waiting For You
All these decades we’ve been waiting here for you. Welcome!
You do look lonely.
No one knows you the way we know you.
And you know us.
Did you actually (once) tell yourself—I am better than this?
One day actually (once) tell yourself—I deserve better than this?
Fact is,you couldn’t escape us.
And we have been waiting for you. Welcome home!
Boasting how a scholarship bore you away
like a chariot of the gods except
where you are born, your soul remains.
We all die young here.
Not one of us outlived young here.
Check out obituaries
in the Lockport Union Sun & Journal.
Car crash,
overdose.
Gunshot, fire.
Cancers of breast,
ovaries, lung,
colon. Heart
attack, cirrhosis
of liver.
Assault, battery.
Stroke! And—
did I say over-
dose? Car
crash?
Filling up the cemeteries here.
Plastic trash here.
Unbiodegradable Styrofoam here.
Three-quarters of your seventh-
grade class now
in urns, ash and what remains
in red MAGA hats.
Those flashy cars
you’d have given your soul
to ride in,
just once, now
eyeless
rusting hulks
in tall grass.
Those eyes you’d
wished might crawl
upon you like ants,
in graveyards
of broken glass.
Atwater Park where
you’d wept
in obscure shame
and now whatever
his name who’d trampled
your heart, he’s
ash.
Proud as hell
of you though
(we admit)
never read a
goddamn word
you’ve written.
We never forgave you. We hate winners.
Still, it’s not too late.
Did I say overdose?
Why otherwise are you here?
Ti Abbiamo Aspettato
Ti abbiamo aspettato per tutti questi decenni. Benvenuto!
Sembri davvero solo.
Nessuno ti conosce come ti conosciamo noi.
E tu ci conosci.
Ti sei davvero (una volta) detto – Valgo più di questo?
Un giorno (una volta) ti sei davvero detto – Merito più di questo?
Il fatto è: non potevi sfuggirci.
E ti abbiamo aspettato. Benvenuto a casa!
Fregiandoti di come una borsa di studio ti abbia portato via
come un carro degli dèi, senonché
dove nasci, la tua anima permane.
Moriamo tutti giovani qua.
Qui nessuno è riuscito ad invecchiare.
Controlla i necrologi
nel Lockport Union Sun & Journal.
Incidenti d’auto,
overdose.
Sparatorie, fuoco.
Tumori al seno,
ovaie, polmone,
colon. Crisi
cardiaca, cirrosi
epatica.
Aggressione, percosse.
Infarto! E –
ho detto over-
dose? Incidenti
d’auto?
Si riempiono i cimiteri qua.
Buste di plastica,
polistirolo non biodegradabile qui.
Tre quarti della tua classe
di seconda media è adesso
nelle urne, cenere e quel che rimane
nei cappelli rossi MAGA. *
Quelle auto pacchiane
per cui avresti dato l’anima
pur di salirci su,
almeno una volta, ora
senz’occhi
carcasse arrugginite
nell’erba alta.
Quegli occhi che volevi
brulicassero su di te come formiche,
nei cimiteri
di vetri rotti.
Il giardinetto Atwater dove
piangevi
colmo di vergogna nascosta
e adesso qualunque sia
il nome di chi abbia fatto sobbalzare
il tuo cuore, è
cenere.
Orgogliosissimi
di te però
(ammettiamo)
non abbiamo mai letto
una fottuta parola
di ciò che hai scritto.
Non ti abbiamo mai perdonato. Odiamo i vincenti.
Tuttavia, non è troppo tardi.
Ho detto overdose?
Altrimenti per quale altro motivo sei qua?
*Acronimo di “Make America Great Again”, slogan della campagna elettorale di Trump del 2016.
Old America Has Come Home to Die
Old America has come home to die.
From Oklahoma oil fields where the sun
beat his head and brains boiling in a stew
of old memories. Penance for my sins
I never owned up to.
From Juneau, Alaska, where he’d fished
coho salmon on the Mary Flynn.
From Black Fly, Ontario,
where he’d been a hobo farmhand,
and from New Jericho, Manitoba,
where he’d mined gypsum sand,
Old America has come home to die.
Bad memories like shreds of tobacco on the tongue,
you can’t spit off.
From Big Sky, Montana, where
he’d been a cowboy. From
Western Pacific, Sandusky,
and Santa Fe Railway, from the Gulf
Islands and Skagit River, Washington,
where he’d worked construction,
Old America has come home to die.
Bosses treat you like shit on their shoe
they can scrape off any time.
And they do.
From the Great Lakes, where
he’d worked freighters
in minus-
zero
weather, lost
half his damn fingers and toes
to frostbite. From the mines
at Crater Falls, Idaho,
where his lungs turned the hue
of anthracite. And from Moab,
Utah, where he’d been incarcerated
seven years for a rob-
bery he hadn’t done,
Old America has come home to die.
Romantic life of a “hobo”
lasts until your legs go.
Old America freckled with melanomas,
straggly hair to his shoulders
like the boy-General Custer,
and fester-
ing sores
on his back, sides, and belly
has come home to die
where no one remembers him —
“Uncle Eli?”
who’d sent postcards
from the West long faded
in Granma’s photo album
as out of a void
in an era before Polaroid
Old America has come home to die.
Old America with a blind left eye.
Old America with a stump
of his gangrenous left leg, amp-
utated at the knee.
How bad I treated my family
who loved me.
Come home to say I am sorry and I love you.
Great-Granma’s youngest sister’s
son Eli who’d left the farm in 1931
to work on the Erie Canal, but no —
disappeared somewhere west
beyond Pocatello, Idaho. We’d guessed
you’d died in the Yukon, or in
the Eagle Mine in Utah. Capsized
in the Bering Strait, or vaporized
at the Fearing Nevada Test Site
or murdered by railroad cops
and flung into the Mississippi —
poor Uncle Eli!
Sins I have committed these many
years, I regret. Wash my soul
clean before I die.
Trying to explain why he’d left home except —
Where is Marta? Please
let me see Marta — his brother’s wife
he was in love with, and Marta told him
she was pregnant, and he abandoned
her to her violent husband like a coward.
Years I never thought of Marta, or Ma —
any of you. Now, that’s all I think about.
Forgive me how bad I behaved
when I was young . . .
Old America, we are not cruel
people, but the fact is mostly we’ve
forgotten you. And Great-Aunt Marta
too—died in 1961. And her oldest
son Ethan, who’d be the one
you’d want to see, is gone, too —
somewhere south of the 38th parallel,
Korea.
Where are my brothers—Frank, Joseph, Frederic?
My sisters—Margaret, Elizabeth?
My cousin Leah?—so many cousins . . .
Old America, frantic to repent,
has brought us presents —
flute carved out of a walrus tusk, Inuit
doll and soapstone skulls, beaded belts and
miniature pelts and something that causes Maya to scream,
Oh God—is that an Indian scalp?
Old America has come home to die
this first week of December
in time for Maya to videotape
an interview with Great-Uncle Eli
for her American Studies seminar at Wesleyan —
Life of an Oldtime “Hobo.”
Her classmates will be impressed —
Old America is like awesome, fantastic —
and her professor will grade an A —
Tragic, vividly rendered & iconic.
La Vecchia America è Tornata A Casa a Morire
La Vecchia America è tornata a casa a morire.
Dai giacimenti di petrolio dell’Oklahoma dove il sole
gli spaccava la testa e il cervello bolliva in un minestrone
di vecchi ricordi. Penitenza per i miei peccati
che non ho mai confessato.
Da Juneau, Alaska, dove aveva pescato
salmone argentato sulla Mary Flynn.
Da Black Fly, Ontario,
dove era stato un bracciante hobo*,
e da New Jericho, Manitoba,
dove aveva estratto gesso,
la Vecchia America è tornata a casa a morire.
Brutti ricordi come filamenti di tabacco sulla lingua,
che non puoi sputare.
Da Big Sky, Montana, dove
era stato un cowboy. Dalle
tratte ferroviarie della Western Pacific, Sandusky,
sino a quelle di Santa Fe, dalle Isole
del Golfo e il fiume Skagit, Washington,
dove aveva lavorato nei cantieri,
la Vecchia America è tornata a casa a morire.
I padroni ti trattano come merda sotto le loro suole
che possono raschiar via quando vogliono.
E lo fanno.
Dai Grandi Laghi, dove
aveva lavorato sulle navi cargo
sotto
zero
aveva perso
metà delle sue dannate dita delle mani e dei piedi
per congelamento. Dalle miniere
di Crater Falls, Idaho
dove i suoi polmoni erano diventati color
antracite. E da Moab,
Utah, dove era stato detenuto
sette anni per una ra-
pina che non aveva commesso,
la Vecchia America è tornata a casa a morire.
La vita romantica di un “hobo”
dura fintantoché le gambe non cedono.
La Vecchia America macchiata di melanomi,
capelli in disordine sulle spalle
come quelli del Generale Custer, e
piaghe
infette
sulla schiena, fianchi e pancia
è venuta a morire
dove nessuno si ricorda di lui –
“Zio Eli?”
che aveva inviato cartoline
dall’ovest sbiadite dal tempo
conservate nell’album di foto della nonna
come uscite dal nulla
in un’era prima della Polaroid
la Vecchia America è tornata a casa a morire.
La Vecchia America con un occhio sinistro cieco.
La Vecchia America con la sua protesi
alla gamba sinistra incancrenita, am-
putata al ginocchio.
Quanto ho trattato male la mia famiglia
che mi amava.
Torno a casa per dire che mi dispiace e che vi amo.
Il figlio della sorella più piccola della bisnonna,
Eli, che aveva lasciato la fattoria nel 1931
per lavorare al Canale Erie, ma no –
scomparve da qualche parte nell’ovest
oltre Pocatello, Idaho. Ci eravamo immaginati
che fossi morto nello Yukon, o
nelle miniere di Eagle nello Utah. Annegato
nello Stretto di Bering, o vaporizzato
nello Spaventoso Nevada Test Site*
o assassinato dai poliziotti ferroviari
e scaraventato nel Mississippi –
povero Zio Eli!
Dei peccati che ho commesso in tutti questi
anni, me ne dolgo. Purifico la mia anima
prima di morire.
Cerco di spiegare perché
avesse lasciato casa, solo che –
Dov’è Marta? Vi prego
fatemi vedere Marta – la moglie di suo fratello
di cui era innamorato. Marta gli disse
che era incinta e lui come un codardo
la abbandonò al suo violento marito.
Anni in cui non ho mai pensato a Marta, o a mol-
ti di voi. Adesso, è l’unica cosa a cui penso.
Perdonate quanto mi sia comportato male
da giovane…
Vecchia America, non siamo gente
crudele, ma il fatto perlopiù è che
ti abbiamo dimenticata. E anche la prozia Marta
morì nel 1961. E il suo figlio più grande
Ethan, quello che
ti farebbe piacere vedere, è morto anche lui –
da qualche parte nel 38esimo parallelo sud,
Corea.
Dove sono i miei fratelli – Frank, Joseph, Frederic?
Le mie sorelle – Margaret, Elizabeth?
Mia cugina Leah? – così tanti cugini…
Vecchia America, convulsa nel ravvedersi,
ci ha portato dei regali –
zufolo di zanna di tricheco, bambola
eschimese e teschi di pietra ollare, cinture di perle e
tappeti di pelliccia animale e qualcosa che fa urlare Maya,
Oh dio – è la testa di un indiano?
La Vecchia America è tornata a casa a morire
questa prima settimana di dicembre
giusto in tempo per fare in modo che Maya registri
un’intervista con il prozio Eli
per il suo seminario in American Studies a Wesleyan –
La vita di un “Hobo” di altri tempi.
I suoi compagni di classe saranno impressionati –
La Vecchia America è un qualcosa di stupendo, fantastico –
e il suo professore le darà una A –
Tragica, vividamente rappresentata e iconica.
*Un hobo è un vagabondo che adotta in maniera tendenzialmente volontaria uno stile di vita senzatetto improntato alla semplicità, al viaggio, all’avventura, alla ricerca interiore, alla marginalità, svolgendo talvolta lavori occasionali.
*Sito, istituito l’11 gennaio 1951 per test sulle armi nucleari
That other
They laughed, but no. You
don’t remember that.
What you think you remember—
it wasn’t that.
Yes—you remember
some things. And
some things did
happen. Except not
that way.
And anyway, not
to you.
Quell’altro
Ridevano, ma no. Tu
non lo ricordi.
Ciò che pensi di ricordare –
non corrisponde al reale.
Sì – ricordi
alcune cose. E
alcune cose sono davvero
successe. Però non
in quel modo.
E in ogni caso, non
a te.
Traduzione di Emanuele Emma ed Emanuela Falco.
 Il fango, le trincee, la morte, i reticolati, il gas, le granate, la fine della gioventù e l’esperienza del limite compongono l’esperienza dei War Poets, ora racchiusa nel volume, curato da Paola Tonussi, per Ares, in cui viene restituito un bagliore come fiore estremo, attraverso racconti, testimonianze, versi del primo grande conflitto del ‘900.
Il fango, le trincee, la morte, i reticolati, il gas, le granate, la fine della gioventù e l’esperienza del limite compongono l’esperienza dei War Poets, ora racchiusa nel volume, curato da Paola Tonussi, per Ares, in cui viene restituito un bagliore come fiore estremo, attraverso racconti, testimonianze, versi del primo grande conflitto del ‘900.