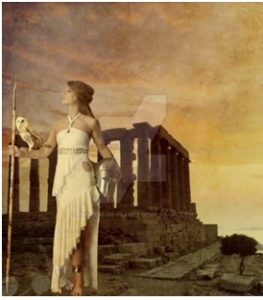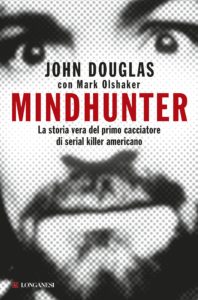di Enrico Facco 7 aprile 2020
leggi in pdf LA PANDEMIA E IL TAO DEL NUOVO UMANESIMO
 La pandemia da COVID-19 sta mettendo dura prova il mondo intero. È un momento drammatico, di cruciale importanza per l’umanità, per la sua sopravvivenza, le reciproche relazioni tra singoli e tra i popoli e per l’ecologia dell’intero pianeta. È un problema di straordinaria complessità e come tale ha implicazioni che si estendono ben oltre la sola gestione tecnico-sanitaria ed economica del problema, per quanto di cruciale e prioritaria importanza.
La pandemia da COVID-19 sta mettendo dura prova il mondo intero. È un momento drammatico, di cruciale importanza per l’umanità, per la sua sopravvivenza, le reciproche relazioni tra singoli e tra i popoli e per l’ecologia dell’intero pianeta. È un problema di straordinaria complessità e come tale ha implicazioni che si estendono ben oltre la sola gestione tecnico-sanitaria ed economica del problema, per quanto di cruciale e prioritaria importanza.
La cultura occidentale moderna è evoluta in direzione sempre più materialista e tecnico-scientifica con una prospettiva individuale essenzialmente egocentrica. La volontà di potenza che la anima ha prodotto grandi risultati, che sono sotto gli occhi di tutti e non sono in discussione. Tuttavia, non c’è nulla al mondo che sia solo buono ed ogni conquista, in quanto prodotto di una visione parziale, comporta inevitabili e imprevisti effetti indesiderati. Non è dunque da meravigliarsi se il grande e rapido progresso ha portato come danno collaterale la minaccia di una catastrofe ecologica, con un rischio che potrebbe estendersi fino anche alla scomparsa del genere homo dalla faccia della terra entro la fine del secolo.
Nonostante l’autoproclamata intelligenza e superiorità dell’uomo, non sembra che ci siamo comportati in modo più evoluto di una colonia di batteri in provetta. Infatti i batteri in coltura inizialmente crescono in maniera esponenziale, avendo un’apparente disponibilità illimitata di nutrienti; poi, man mano che si accumulano i prodotti di scarto e i nutrienti cominciano a scarseggiare, la crescita rallenta fino a fermarsi per poi morire alla fine annegati nelle proprie deiezioni. In altre parole, l’umanità deve inesorabilmente riscoprire la necessità di adeguare sé stessa e il suo comportamento alla realtà e quindi alla Natura, invece che pretendere che il mondo si adatti tout court alle sue propensioni, desideri e velleità.
In questi ultimi due secoli abbiamo inaugurato una rivoluzione scientifico-tecnologica senza precedenti, ma abbiamo utilizzato la nostra mente in modo radicalmente utilitaristico secondo la limitata prospettiva della coscienza ordinaria per crescere confinati entro l’orizzonte degli interessi individuali e di gruppo, ignorando il resto del mondo e alienandolo da noi come una problema irrilevante: il risultato è che una parte dell’umanità ha raggiunto un benessere e una sicurezza senza precedenti (e questo è il lato buono), ma al costo di creare grossi squilibri tra ricchi e poveri e tra uomo e natura; nonostante il progresso, complessivamente non sembriamo più felici di prima e continuiamo a marciare verso il precipizio ecologico, come i topi dietro al pifferaio magico verso il burrone.
Occorre dunque un cambiamento epocale, superare lo spirito del tempo del XX secolo, fare un salto di qualità che apra a una nuova e più ampia prospettiva, un cambiamento di paradigma. La personale opinione è che la via corretta sia quella più antica e insieme più moderna, ossia riscoprire e comprendere profondamente la concezione della complementarietà degli opposti dei filosofi presocratici e del Taoismo (invece dell’inconciliabile separazione postaristotelica) e la dynamis di Ippocrate (l’inscindibile interrelazione mente-corpo-ambiente). Quest’ultima trova una corrispondenza in ambito biologico nella recente definizione degli esseri viventi e del mondo come sistemi complessi in inscindibile relazione, reciproca trasformazione e coevoluzione. Se un tale concetto appare come una nuova e illuminata concezione scientifica, esso è da sempre patrimonio della grande sapienza degli antichi, da Buddha a Laotze, a Parmenide e Eraclito, il cui paradigma, non a caso, è più compatibile con quello della fisica quantistica di quanto non lo sia il pensiero occidentale classico.
Quella sapienza è stata tuttavia persa per un uso quasi esclusivo della ragione in senso logico-analitico. Essa ha prediletto la mente discriminante, che conosce distinguendo e separando: è certamente uno strumento valido e potente, ma è come un bisturi, che può salvare la vita ma anche uccidere, se usato male. Se ci si limita solo a sezionare per comprendere gli elementi e i meccanismi di base dei fenomeni osservati (prospettiva del riduzionismo scientifico), si perde inesorabilmente la percezione e la comprensione dell’intero: è la metaforica capacità di vedere l’albero ma non la foresta, con tutte le relative conseguenze.
Il problema era già stato ben definito da Platone nel Sofista, dove l’Ospite di Elea (Parmenide) afferma: “Lo slegare ogni cosa da tutte le cose è il più completo annullamento di ogni principio di ragione”. Sembra invece che questo sia l’unico modo di usare la ragione che oggi conosciamo: tuttavia un modo alienato. All’analisi deve essere dunque conseguire la sintesi, il riunire ciò che abbiamo arbitrariamente separato e isolato da quel sistema complesso che è la Natura, come lo è ogni essere vivente; ma solo la saggezza e la sapienza possono consentire di perseguire questo obiettivo oltre i limiti delle singole discipline.
La verità dell’inscindibile complementarietà degli opposti, concetto che appare strano all’uomo occidentale moderno, è ben definita da Eraclito: “Belle per il Dio, sono tutte le cose. E giuste; ma gli umani ne hanno ritenute giuste alcune, ingiuste le altre. Ciò che si oppone converge, e dai discordanti bellissima armonia… È la malattia che rende piacevole e buona la salute, la fame la sazietà, la fatica il riposo”. Ogni cosa appare ed è percepibile grazie al suo contrario con cui è in relazione complementare e dinamica: così anche per il piacere e il dolore e per il bene e il male, questi ultimi sapientemente simbolizzati nella Genesi come frutti di un’unica pianta.
Dunque questo momento di incertezza, isolamento e paura per la sopravvivenza può diventare uno stimolo formidabile per riscoprire e apprezzare in modo autentico il suo contrario, ossia il valore della vita, del lavoro, degli affetti e del contatto umano, il rispetto dell’altro, dell’appartenenza allo stesso mondo e della cooperazione: l’ “essere con” e “parte di”, non “altro da”.
Questa prospettiva può consentire ad ognuno di affrontare meglio la drammatica pandemia che si sta abbattendo nel mondo contemplando “l’intero”, ossia considerarne anche il senso e le conseguenze implicate nel nostro essere al mondo, oltre alla ricerca degli strumenti tecnici per gestirla e risolverla; e così si può affrontarla con maggiore serenità, determinazione e responsabilità, rendendola occasione per un rinnovamento radicale di cui c’è un indifferibile bisogno. È da contemplare dunque l’intima appartenenza della pandemia a questo momento storico, che ne sarà segnato in modo indelebile nella storia. È da considerare attentamente che la virtù più importante dei sistemi complessi è quella non solo di reagire ma di modificare sé stessi in risposta agli stimoli. Ritengo quindi verosimile (e lo spero) che, quando il grave momento sarà superato, nulla sarà più come prima, perché cambierà qualcosa nella nostra percezione e nella nostra consapevolezza, come nel nostro sistema immunitario e nel modo di reagire al virus; se così sarà, è importante cogliere l’opportunità di momento difficile per trasformarci tutti da soggetti passivi, mere vittime degli eventi, ad artefici di un profondo e necessario rinnovamento.
Un virus, la creatura biologicamente più infima, ha messo in ginocchio l’umanità assieme alla sua arroganza e volontà di potere, mettendo in evidenza i limiti degli assiomi e delle teorie, delle credenze e dei dogmi che hanno dominato lo spirito del tempo attuale. Quest’ultimo appare sempre più come una torre di Babele che ha raggiunto la confusione delle lingue e deve essere abbandonata. Nel progressivo deterioramento dei valori, l’economia si è trasformata da valido strumento di gestione delle risorse a fine ultimo, una sorta di teologia economico-finanziaria dogmatica – della quale gli ipermercati sono la cattedrali – che ha imposto all’umanità i suoi comandamenti, cui sottomettersi in nome di una produttività fine a sé stessa come principale se non unico valore. Sul piano sanitario, l’obiettivo della produttività e della riduzione dei costi (in sé ineccepibile), adottato come criterio dominante di gestione, ha comportato la perdita della resilienza del sistema, ossia della capacità di far fronte ai mutamenti improvvisi delle necessità; il mito della globalizzazione e della delocalizzazione ha portato alla difficoltà di approvvigionamento di merci per la riduzione di produttività nelle aree critiche lontane e problemi relativi al loro trasporto e anche all’indisponibilità dei presidi sanitari ai paesi che ne hanno bisogno ma non li producono.
La nuova emergenza richiede inoltre di semplificare radicalmente le norme e superare le rigidità dei criteri di stabilità per poter sopravvivere e far ripartire l’economia, fatto che potrebbe preludere ad un augurabile positivo mutamento delle regole europee. Ovviamente nulla di quanto è stato fatto fino ad oggi è in sé sbagliato ma solo la pretesa di validità assoluta e di esclusività di ogni singola idea, che, quando è portata all’estremo, finisce inesorabilmente per produrre risultati contrari facendo diventare cattiva anche la cosa inizialmente buona. Come afferma un antico adagio, la differenza tra il farmaco e il veleno è solo la dose.
È quindi ora di reagire e approfittare del momento per iniziare a riflettere seriamente su come vogliamo e dobbiamo essere, dalla sfera privata a quella sociale e politica, nazionale e internazionale, per essere all’altezza dei tempi, del mondo e della Natura di cui siamo parte. È il momento di progettare l’ineludibile rinnovamento, dopo l’appiattimento culturale, le arbitrarie semplificazioni politiche (con le relative soluzioni, necessariamente inadeguate a problemi complessi) e il sopore consumistico, che nei decenni scorsi si è associato ad un progressivo calo del quoziente di intelligenza in tutto l’Occidente, favorendo egoismi idioti e disgregazione sociale.