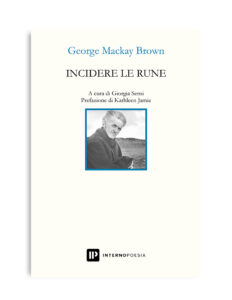di Andrea Galgano 4 aprile 2017
leggi in pdf L’indocile energia di Kathleen Jamie
su Atelier Poesia 10 aprile 2017
sul sito di Ladolfi Editore 12 aprile 2017
 Kathleen Jamie (1962) è una poetessa di incroci scrutati e sorpresi con grande forza poetica. Sono dispiegamenti simbolici, affermati attraverso una densità attonita e immersa che conduce nella visione interiore attraverso sporgenze, drammi, attraversamenti cangianti e vivi.
Kathleen Jamie (1962) è una poetessa di incroci scrutati e sorpresi con grande forza poetica. Sono dispiegamenti simbolici, affermati attraverso una densità attonita e immersa che conduce nella visione interiore attraverso sporgenze, drammi, attraversamenti cangianti e vivi.
Nella vastità della sua opera, emerge La casa sull’albero[1], edito da Giuliano Ladolfi Editore, a cura di Giorgia Sensi, restituendoci un mondo attraversato da speciali contraddizioni e confini infiniti, e riuscendo a farci vivere il confronto tra culture con dolce spietatezza, e lo spostamento spasmodico di natura umana e natura sociale con acume e vitalità.
Giorgia Sensi nell’Introduzione scrive:
«Ciò che colpisce in tutta la poesia di Kathleen Jamie è l’immediatezza abbinata alla profondità di pensiero. La sua è una lingua molto lucida e scarna, priva di accademismi, che non ha bisogno di orpelli, solo apparentemente semplice, e i cui ritmi sono costruiti in modo da ottenere tutta la naturalezza della lingua parlata. È una lingua distillata, rarefatta, ricca di sorprendenti metafore, la cui musicalità viene esaltata dal ritmo e dagli accenti della parlata scozzese, in modo particolare quando è lei stessa a leggere la sua poesia».[2]
Poetessa, scrittrice, saggista (interessanti i suoi saggi Findings (2005) sulla fauna e flora scozzese, e Sightlines (2012) sulle Orcadi), nata nel Renfrewshire, Scozia, nel 1962, ha studiato filosofia all’università di Edimburgo. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia: Black Spiders (1982); The Way We Live (1987); The Queen of Sheba (1994), Jizzen (1999), The Tree House (2004), The Overhaul (2012), The Bonniest Companie (2015), ricevendo diversi premi prestigiosi, quali un Somerset Maugham Award, un Forward Poetry Prize (Best Single Poem), un Paul Hamlyn Award e un Creative Scotland Award. Per due volte ha vinto il Geoffrey Faber Memorial Prize.
Il suo volume di poesie scelte, Mr & Mrs Scotland Are Dead (2002), che raccoglie la maggior parte della poesia scritta dal 1980 al 1994, è stato finalista del Griffin Poetry Prize. Nel 2004 la sua raccolta The Tree House (2004) ha vinto il Forward Poetry Prize (Best Poetry Collection of the Year) e nel 2005 lo Scottish Arts Council Book of the Year Award. La sua raccolta, The Overhaul (2012) ha vinto il prestigioso Costa Award ed è stata finalista del TS Eliot Prize. Fellow della Royal Society of Literature e nel 2011 è diventata Professore di Scrittura Creativa all’Università di Stirling.
Il rigetto di ogni occlusione tradizionale e sociale dell’anima scozzese, non è solo ribellione o movimento umano, è il rigoglio di un’appartenenza che deve rinnovarsi per restituirsi a se stessa. Una tradizione che non abbia rinnovamento è orpello museale, non si nutre, rimane impolverata nella stantia camera del tempo consumato, senza che l’anima si rigeneri.
Ecco l’arrivo del Perturbante, la Regina di Saba, che porta ribellione, scompaginando ogni grettezza sociale e pregiudizio, rivestendo di bellezza e identificazione, la preesistente tensione di un coro di donne. Ella compare tra la torba e la felce delle Pentland Hills, il muschio di Curriehill Road, «grida che il più saggio dei nostri uomini / la metta alla prova: / Battete la Scozia in cerca di un Salomone! / Come da copione: laggiù dal fondo della folla / qualcuno ringhia; / ma chi ti credi di essere? / e mille ragazze ridenti con lei / prendiamo fiato / e gridiamo / LA REGINA DI SABA!»:
«Scozia, ne hai invocato il nome / una volta di troppo / nei tuoi salotti presbiteriani. / Lei ha sentito, sì / fin nella pagana Arabia / il tuo volpigno latrato di povertà, ereditato / come il naso lungo, una vena di cocciutaggine, / un cane di ceramica che non t’è mai piaciuto / ma di cui non ti puoi disfare». (La regina di Saba).
Non è una questione di genere o di appartenenza regionalistica, il volto dell’uomo, che scrive poesia, è autenticamente liberato dalla scena che mette in gioco, dalla libertà che occupa la sua pagina, e dal conseguente rischio di un corpo a corpo senza fine, della sua domanda elementare, non dell’essere donna o scrivere letteratura al femminile:
«Vedi quelle file di punte di selce / nei nostri grandi musei archeologici / così sontuosi a Edimburgo – / Ti poni mai domande sulla nostra storia? […] Non sono punte di frecce quelle / ma esposizione di lingue di nonna, / le lingue tenaci di nonne / tutte morte e sepolte / tornate alla torba e ai ruscelli, / salvo per le loro lingue / brusche e taglienti, conservate / per generazioni nella terra / con amuleti malefici, conservate / tutte tranquille in vetrine nella penombra / dei nostri musei, e / non si tradiscono. Ma se tu osi / sognare e fantasticare / del cacciatore scomparso, del cervo saggio fuggito; / taci…e le sentirai, / perché non smettono mai di borbottare […]» (Punte di freccia).
La questione dell’identità si pone, nella poesia di Kathleen Jamie, come un sostrato primordiale e originario, proiettato nell’ultimità, scandito nella natura come sipario del mondo vivente, in cui gli occhi posano le loro scintille e tastano i segni di una genesi. Conoscere anche qui è nascere insieme oppure ri-nascere.
Ed è nel dettaglio del mondo nascente (animali, uccelli, fiori, alberi, paesaggio naturale scozzese), che la poesia accumula la sua linfa e il suo principio. È natura iscritta che «può essere quella sconfinata e selvaggia dei grandi paesaggi scozzesi, delle isole ormai disabitate e dei loro siti archeologici, delle colonie di sule, delle orche e della balene, come quella che lei stessa può osservare dalla finestra della sua cucina, binocolo sempre a portata di mano, ma in entrambi i casi la conversazione e l’interazione con il mondo naturale è sempre presente»[3].
È l’arcaica grafia dell’indicibile pedinamento del tempo antico, essere pietra cieca nel passato sparpagliato, dove il margine del volo si trascina attraverso il cielo. Un cielo immenso e custodito nel gemito del vento che sospinge un suono, forse umano, desolato. Un grido incessante, come in una penuria, nell’aria che si muove.
Si legge in Stormi di oche:
«Stormi di oche scrivono una parola / attraversando il cielo. Una parola / battuta come un gong / prima che io nascessi. / Il cielo si muove come bestiame, muggendo. / Sono vuota come pietra, come campi / arati ma non seminati, nuda / e cieca come una pietra. Cieca / alla parola, cieca a ogni suono tranne al richiamo delle oche. / Filo spinato avvolge, arcaica grafia, / un cancello. I barbigli / fanno segnali al vento come se / fosse sordo. La parola fischia / troppo forte per i miei sensi. Via. / Non come il passato sparpagliato / qui intorno. Né la morte improvvisa. / Non come un amante che impareremo/ a conoscere, per sempre connessi. / Il margine del volo si trascina attraverso il cielo. / Cosa scrivono gli uccelli sul crepuscolo? / Una parola mai detta né letta. / Gli stormi volgono verso casa, / sul gemito muto del vento, un suono / forse umano, desolato».
Kathleen Jamie compie, in Jizzen («il letto del parto», 1999), una rinnovata geografia interiore che conduce memorie incluse a compiersi nei richiami e nelle rievocazioni, a riportare alla luce la stupefatta e numinosa spazialità.
Qui il gesto poetico è un suono rammemorativo che rimanda al dettaglio per vibrare. La tonalità sensitiva e uditiva aiuta a comprendere un ricordo che si presenti fica in tutto il suo umbratile splendore rievocativo. Rievocare è richiamare ciò che primordialmente si riporta in superficie, per renderlo proprio, non perderlo, dissotterarlo come un particolare universale.
È la primitiva sospensione del tempo sulla Terra che, facendosi passaggio di sponde, riconvoca nostalgie di gioie e detriti, limiti e confini oltrepassati, per farsi poesia che crea, che rinviene le linee perdute, riconducendo, infine, il mondo «da un nido cinguettante / sospinto dalle canne» o «da una stupefatta barchetta di santi», sulla limata fosforescenza delle acque che brillano su dita, remi e sul dardo della prua:
«Ricordi come remavamo verso il cottage / nella baia disegnata a falce, / quella notte dopo che il pub / ci lasciò andare tra le sue porte girevoli / e spingemmo sulla ghiaia / finchè l’acqua umettò i fianchi / il loch sussurrasse la parola “barca”? / Non ricordo chi remava. Gli scherzi cessarono. / Il tonfo dei remi, lo scricchiolio e lo sciabordio / del loch si prolungarono nel cuore della notte. / In quella correte ebbi paura: / lo scialle freddo della brezza, / le colline gibbose; di ciò che l’acqua celava / tra tronchi e scafi nucleari a orologeria. […] Certo, fu avventato, un loch così grande, la marea, / ma siamo vivi – e abbiamo perfino fatto figli / con donne e uomini non ancora incontrati / quella notte che uscimmo, e reclamammo come nostri / il cielo e l’acqua salmastra, i colli feriti / che i mirtilli tempestavano di nero, / le nostre cavigliere luccicanti nell’acqua bassa / mentre issavamo i remi e saltavamo giù, / per tirare la barca in secco sulla spiaggia del cottage».
Il mondo partoriente, rinato o riscoperto, non è solo segnale della dimensione esterna, ma anche, come accade nella sua poesia, l’esito di una ecografia, che diviene ninnananna e poi preghiera ultima, affinchè il cuore del figlio appena nato possa sopravvivere al suo.
Tutta la scrittura di Kathleen Jamie sembra nascere da un tremore primordiale, in cui il sentimento singolo, e singolare, racchiude la universale potenza dell’esistente. È da questo stupore primigenio che tutto ha inizio, come il primo dettaglio che ripete i secoli-bardi, o le prime dolci e folli settimane di vita, arrese come un accenno di primavera che veleggia sull’ovest, prima di sollevare i panni: «un raro volo di cigni», «colli sui quali si rattrappisce la neve».
È una maternità di attesa che si scopre in una promessa veggente, come argento vivo sollevato «in una rete di suono, / poi per pietà, abbassato», come solstizio dei giorni che si aprono, disgelo di un mondo riconsegnato in una spirale bellissima, ricolma di benvenuto alle cose semplici e alle allineate stelle di Orione:
«[…] e benché comportasse un viaggio / sulla neve che scuriva, / le braccia occupate da te in una coperta, / dovetti camminare fino in cima al giardino, / per toccare in un complice omaggio tra uguali, i tronchi / a spirale dei nostri prugni, il muschio, / il posto del pettirosso sull’agrifoglio. / Con la schiena sul muro della ferrovia, / cercai di ricordare; / ma perfino le mie impronte si cancellavano / e le stelle nascenti di Orione / negavano ciò che sapevo: che mentre noi venivamo / lanciati su una lettiga tra le porte girevoli della sala parto, / loro erano là, allineate sul soffitto, / accese di ansia / per quella difficile cessione, / prima che fossimo due, dal mio uno».
Fino alla sperdutezza della rincorsa piangente dell’io narrante, che immagina di mettere in una cesta di giunchi intrecciati il suo dono (novello Mosè), lavorato dal Firth, scivolato lentamente in un fiume.
Questa maternità, allora, è l’accesa rifioritura del tempo perduto, o il suo tentativo almeno. Una poesia-donna che si scuote nella tranquillità, che afferma l’impavido spirito acre e dolce del rododendro, che nasconde l’intimo essere «nativo / come la lingua o la memoria umana / del nostro suolo leggermente acido».
La poesia di Kathleen Jamie segue questo sentiero di rinascita e di appartenenza con estrema trasparenza. Anche nei relitti, nei detriti temporali, si scorge una pienezza che è secolare, mai un vuoto, bensì una mancanza colmata di stupore, come l’acqua non toccata che risale dal pozzo: «Immagina le vele volare come cigni, / donne trasportate infranti / mentre i corni ululano, / e le spranghe delle porte sbattere / dentro questa cavità, dove un tordo fa il nido».
La rievocazione è un metodo di lontananze che si approssimano. È il lavoro delle donne che piegano e spiegano il lino o la pelle di una selkie rimboccata dietro una roccia, e la poesia deve rincorrere questa nascita continua e immortale: «[…] Piume di luce solare, riflesse dal coltello del burro / tremolano sul soffitto, / e un’ultima brusca torsione delle spalle / partorisce mia figlia, e a seguire / la placenta, come un pugno di alghe violacee».
Tale immortalità si esplica nelle addizioni suggestive di Spirea, in cui, la riapparizione dell’essere, dapprima seppellito in un salmo uggioso, si riapproprierà della vita con le gocce delle labbra e con i semi estivi: «Così la seppellirono, e si volsero verso casa,/ un salmo uggioso / li avvolgeva come nebbia, / non sapevano che il liquido / che gocciolava dalle sue labbra / si sarebbe fatto strada là sotto […]».
Giorgia Sensi, acutamente, commenta: «Secondo la tradizione poetica gaelica le poete venivano sepolte a faccia in giù, (sepoltura riservata anche alle streghe), evidentemente per tacitare e punire entrambe. Chi ha sepolto questa poeta, però, non ha tenuto conto del ciclo di rinascita che questo tipo di sepoltura determinerà: semi estivi restano impigliati nella sua treccia e questi l’aiutano a dissotterrarsi»[4].
Il suo territorio poetico (la sua “psicogeografia”) racchiude una fertile e feconda iterazione, che soggiace una domanda: come possono vivere gli esseri umani in un giusto rapporto con il mondo naturale e come possano appartenere a ciò che la realtà porge, cosicchè la vecchia idea dell’anima o il cuore, la mattina, possano volteggiare sul letto, simulando pietà, «prima di infilare / la tromba delle scale / e riversarsi fuori nella luce».
La trama del suo “cuore-makar” continua a vivere al di là del dolore, in una pienezza di mondo (popolato di alberi, fiori, squali, balene, pipistrelli), fosforescente e riscaldato, che rompe le superfici, rilascia mude:
«Dovessi capitare su quel colle / dove crescono le ciliege selvatiche / sarà meglio sia presto, o verranno / ad attaccar briga gli uccelli dagli occhi gialli, / rivendicando i frutti per se. / Selvatiche significa noccioli a malapena / rivestiti di polpa, ma è buffo detto da me. Una bocca / contiene una ciliegia, una ciliegia / un nocciolo, un nocciolo / il ramo in fiore / che devo trovare prima che il vento / sparpagli ogni traccia di fioritura, / e venga il frutto, e gli uccelli dagli occhi gialli» (Prima del vento).
Questa ricchezza, presente in modo compiuto in The Tree House (2004), è la prova di una esplorazione ferace e un respiro tratto da uno strappo di bagliori lontani. È la casa a custodire il rifugio-segreto dell’esistere[5], il pulsare di una nostalgia di assoluto, mentre noi rimaniamo aggrappati al «nostro difficile / ancoraggio ctonio / in questa terra che le mele addolciscono, / senza le quali avremmo potuto vivere / il lungo riflusso della mezza età / soli in baracche e soffitte, / svegli nei sotterranei della mente / alla luce della luna», e portiamo i nostri insediamenti «legati stretti accanto al fiume / dove siamo meglio rappresentati / in giardini di romice / e di alchemilla, bici di bambini / abbandonate sull’erba; / dove abbiamo messo insieme / con assi e casse da imballaggio / una, chiamiamola, dimora […]».
Lo sguardo della poetessa si appropria di una traiettoria che non epura nulla e che si mette in ascolto delle cose, attraverso le cose, che accoglie in ogni circostanza minuta che divampa, stagliate nelle pieghe dei colli, nelle brume delle piogge, nel sapore del ferro del sangue, come un incontro segreto in una fresca imboccatura di grotta o come membra sollevate, prima del vento: «Sei stremato, ontano, / in questa età della pioggia? / Dai tuoi rami / pendono grumi di lichene / come polmoni di fata. Tutta la settimana, / turbini di vento, frammenti di nebbie: / ontano, che hai spiegato / di fronte ai ghiacciai in ritirata / prima una foglia poi un’altra, / non vuoi insegnarmi / un modo di vivere / su questa terra umida, ambigua?».
In The Overhaul (2012), Kathleen Jamie revisiona i suoi contorni sospesi, scandaglia le sue baie arcuate di attese e pazienze («è un gioco fatto di attesa, / e pazienza, pazienza»), di segreti, estuari e piccole valigie di tenebre, attraverso una lingua dicibile che vede e non pone mediazioni[6], riesplorando la luce e le brezze pazze, i lunghi tragitti e i rilasci delle maree, i tremori dello sguardo, l’intima natura dell’essere che si espone, il mondo visitato dalle creature («Un cielo striato di fuoco, / un firth addobbato d’oro, nuvole grigie si muovono come contadini / attirati da una profezia» oppure): «Che specie – / ancora a scandagliare / la stessa baia arcuata, tutti / a sperare nel meraviglioso, / tutti ad agognare una vita diversa» (La spiaggia).
O ancora seguendo la meraviglia dei falchi pescatori, rivissuti in sonetti brevi e interminabili, come il loro viaggio dal Senegal alle burrasche di nido, mentre «si rincorreranno lieti bisbigli oggi in città».
La frammentazione del reale rappresenta l’apice di uno spezzamento di schegge che distillano la ricomposizione di ciò che si ricrea. Il linguaggio permette una riconnessione sperduta ed ultima in una comunicazione che diventa relazione liminale.
Ne Le lune di Galileo, i satelliti di Giove ruotano attorno al pianeta, come i figli della poetessa le girano attorno, «mentre la Terra gira, crescono / dentro la loro vita, lasciandomi / poco tempo per osservare, occhio / all’oculare, / come si rivela una verità – / come le piccole lune scivolano / dal loro casuale allineamento, / ciascuna per descrivere di nuovo / intorno all’ospite comune / il proprio inalterabile corso», però nessuno strumento, nessuno splendente granello di voce che chiama dall’altra parte del mondo potrà rassicurare e in questa domanda, così irrinunciabile, poiché già il domani sta per arrivare, come un neonato insonne e una nuvola compare dal nulla.
Così come l’oblunga distesa di luna, con poche stelle, illumina un interno: i fili di perline, la scrivania, i libri, l’attesa di luce che si sposta su uno schizzo di fiore al muro o sul pavimento di pino. Il primo dettaglio come l’ultimo impossibile segno di bellezza estesa. Lo sguardo privilegiato è ravvivato da una relazione unica e irripetibile, dove il respiro si fa prossimo, la mancanza franta o disfatta, la primitiva sproporzione delle forme, vengono salvate dallo stupore infinitesimo che impregna, attraverso il potere della Natura e del suo Avvenimento:
«[…]- ma bacche rosse / di biancospino si tendevano verso di me, / e tra le foglie cadute / sbocciavano fiorellini bianchi / tardivi. Cercai / di chiamarti, o credo / di averlo fatto, ma il tuo nome / mi si appassì sulla lingua, / […] potrei scomparire per una vita,/ forse sette anni!- / e una joie de vivre così repentina / che quando un fosso mi si spalancò / davanti all’improvviso / lo saltai, leggera come una ragazzina- / sì, lo saltai di netto, / senza neppure pensarci su». (Incantesimo).
L’ultima raccolta, The Bonniest Companie[7] (2015), ha una infinita velocità di esecuzione percettiva che ricalca le forme materiche e stupite del reale: le sue dimore e i fogli di Machado nella brezza, il suo significato familiare e la mancanza di figure sbirciate in una affettività lontana, e, infine, l’ibridazione dei confini linguistici e territoriali (scogliere, valli, cime, spiagge), «sull’orlo frastagliato della terra», le nubi in fuga, il bacio salato di Fianuis, dove ascoltare «una breve quiete, / le note di una pispola piccole come semi».
La poesia di Kathleen si annuncia qui in tutta la sua gamma temporale e temporanea, ma in cui, spesso, l’immaginazione subisce scompensi e fratture, flussi e cicli, come il tempo del crepuscolo che si allontana, svanendo, aggrappandosi alle sue radici[8] (anche nelle scelte lessicali, vicine al passato), quando l’anima, immersa nella Storia, sobbalzerà al tocco del mondo:
«Una scarpinata di trecento metri, poi un cumulo di vecchie pietre- / un lavoro manuale, / e sempre lo stesso fiume, che scintillava / laggiù / quando i Romani vennero, videro, / e ben presto ci ripensarono. / Troppe montagne, troppe / tribù minacciose / le cui abitudini non ci garberebbero granché / (ma che forse riusciremmo a uguagliare) / troppo grigiore nordico, troppa neve in lontananza. / Su, facciamo una sosta qui, riprendiamo fiato / e inaliamo quel dolce profumo di ginestra / che è in fiore oggi / guardiamo laggiù in fondo per miglia, da ora / e fino a che non ritornerà la lince, e il lupo». (Glaciale).
[1] JAMIE K., La casa sull’albero, a cura di Giorgia Sensi, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero (No) 2016.
[2] SENSI G., Introduzione, Jamie K., La casa sull’albero, p. 15.
[3] ID., cit., pp.8-9.
[4] ID., cit., p.11.
[5] CONNOLLY C., A writer’s life: Kathleen Jamie, (http://www.telegraph.co.uk/culture/3632092/A-writers-life-Kathleen-Jamie.html), November 21, 2004.
[6] KELLAWAY K., The Overhaul by Kathleen Jamie, review (https://www.theguardian.com/books/2013/jan/19/kathleen-jamie-the-overhaul-review), January 19, 2013.
[7] Il titolo rimanda agli ultimi versi della ballata tardo medievale del Cavaliere elfico Tam Lin, trascritta da Robert Burns nel 1792. Nella poesia Le cerve (The hinds), la poetessa, in una densa atmosfera di sonno e veglia, ricrea l’agile durezza di diciannove cervi, attraverso una predominanza acustica e una fluidità di movimento, che richiamano a una condizione (si pensi a Janet opposta alla Regina delle Fate nella ballata) simbolica moderna (con riferimento alla campagna per l’indipendenza della Scozia), compresa in una mimesi topografica e in una stratificata progressione temporale, affermate nella libertà finale. Per una interessante ricognizione del testo vedi: RUMENS C., Poem of the week: The hinds by Kathleen Jamie, “The Guardian”, (https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/oct/05/poem-of-the-week-the-hinds-by-kathleen-jamie), October 5, 2015.
[8] POWER P., The Bonniest Companie by Kathleen Jamie, “The London Magazine”, December 22, 2015.
 JAMIE K., La casa sull’albero, a cura di Giorgia Sensi, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero (No) 2016, pp. 180, Euro 15.
JAMIE K., La casa sull’albero, a cura di Giorgia Sensi, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero (No) 2016, pp. 180, Euro 15.
JAMIE K., La casa sull’albero, a cura di Giorgia Sensi, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero (No) 2016.
CONNOLLY C., A writer’s life: Kathleen Jamie, (http://www.telegraph.co.uk/culture/3632092/A-writers-life-Kathleen-Jamie.html), November 21, 2004.
KELLAWAY K., The Overhaul by Kathleen Jamie, review (https://www.theguardian.com/books/2013/jan/19/kathleen-jamie-the-overhaul-review), January 19, 2013.
POWER P., The Bonniest Companie by Kathleen Jamie, “The London Magazine”, December 22, 2015.
RUMENS C., Poem of the week: The hinds by Kathleen Jamie, “The Guardian”, (https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/oct/05/poem-of-the-week-the-hinds-by-kathleen-jamie), October 5, 2015.
SCOTT K., In the nature of things, “The Guardian”, June 18, 2005 (https://www.theguardian.com/books/2005/jun/18/featuresreviews.guardianreview15).