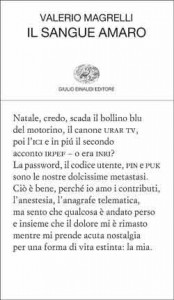CITTÀ DI CARRARA
SALA DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CARRARA
P.ZZA II GIUGNO
28 MARZO 2014
convegno
STALKING:
LA PAROLA ALLA DIFESA
intervento di Irene Battaglini
Le problematiche psicologiche all’origine del reato di stalking: una diversa prospettiva.
pdf Le problematiche psicologiche del reato di stalking: una diversa prospettiva
Prima di addentrarmi nel cuore dell’intervento, voglio ringraziare l’avv. De Giorgi e l’organizzazione del Convegno per aver dato l’opportunità a me e all’Istituto che rappresento di portare il contributo della visione psicologica di questo complesso fenomeno. Lo stalking, come reato e come processo psicologico, investe la sfera più intima delle persone coinvolte, oltre alla più evidente sfera delle relazioni interpersonali e all’ambito delle ricadute psicosociogiuridiche, e certamente sanitarie, che si correlano all’incidenza di questo tipo di reato nella nostra popolazione.
Nella fattispecie, in qualità di Direttore di un’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana e responsabile della formazione di una Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR, sono chiamata a rispondere nei confronti degli stakeholders, dei contenuti che il nostro ente veicola attraverso diversi canali di comunicazione e aree di interesse. I canali possono essere:
•gli eventi aperti al pubblico (convegni, conferenze…)
•il contenuto didattico di lezioni, workshop, seminari e del piano di studi della Scuola di Psicoterapia
•la ricerca sperimentale e lo sviluppo di teorie e tecniche rispetto ai fenomeni di tipo psicosociale
•i progetti e le campagne di prevenzione e di intervento psicosociale
ma in ultima analisi posso dire che le dimensioni nelle quali sento maggiore la responsabilità relativamente al nostro atteggiamento verso lo stalking, sono quelle della metodologia e della deontologia seguite dai colleghi del nostro centro nei casi di:
•psicodiagnosi e stesura peritale
•sportello di ascolto attivo e primo intervento
•la mediazione familiare e penale
•sostegno psicologico
•psicoterapia individuale e di gruppo
Si sta sviluppando all’interno del nostro istituto una vera e propria sensibilizzazione ad esplorare e intervenire nel modo migliore nei casi di stalking, sia che questo riguardi la vittima di stalking sia che a rivolgersi a noi sia lo stalker.
La prospettiva psicologica dalla quale usualmente si osserva il reato di stalking si dirama quindi da tre vertici principali di osservazione:
•la prospettiva della vittima
•la prospettiva dello stalker
•la prospettiva della relazione interpersonale tra vittima, stalker e rete familiare o supportiva
Il “fear appeal” ovvero “l’appello alla paura” mediatico, veicolato da diverse fonti di informazione anche istituzionali, di questi ultimi tempi, ha posto l’accento sulle strategie di comportamento più efficaci per rispondere a quella che viene sentita come una minaccia non solo individuale, o relegata a problematiche della singola donna o del singolo uomo, ma anche sociale, con l’evidente obiettivo di consentire l’identificazione dei destinatari delle campagne di prevenzione nel profilo demoscopico della vittima o del reo, focalizzando l’atteggiamento su un sentimento di appartenenza ad un gruppo, e incentivando sicuramente il coraggio alla denuncia, o a desistere da propositi di stalking, tuttavia alimentando una stigmatizzazione sociale negativa in entrambi casi (che si sia vittima o carnefice, si tratta pur sempre di un invischiamento in una situazione considerata a rischio per la vita, la sicurezza, la libertà, la salute personale e dei propri cari).
Il nostro compito come studiosi della psiche, come teorici e come tecnici chiamati a intervenire o a prevenire, deve essere quello di inserire il caso singolo in una dimensione sociale più vasta in cui la rete sociale, le strutture e gli enti siano in grado di alimentare una condizione di maggiore sicurezza sociale, nel contempo – e quindi affidando i casi ai professionisti dotati di competenza e sensibilità – con lo specifico obiettivo di rendere a ciascun caso la sua specifica inerenza nella vita, nella storia e nel mondo interno di ciascuna persona coinvolta. Solo in questo modo sarà possibile non parlare più di stalking come fenomeno generico, in cui possono essere inseriti diversi comportamenti che costituiscono molestie per così dire relazionali o interazioni con contenuto o finalità minacciose, ma di una storia dotata di un proprio campo di significati psicologici e semantici, una storia, quella in particolare che vede due persone (non necessariamente un uomo e una donna) coinvolte in una relazione “a doppio legame”, in un cui la comunicazione è focalizzata intorno ad una forma astratta di interdipendenza, in cui la relazione è ottenibile soltanto attraverso una coercizione, un ricatto, una violenza.
Al Polo Psicodinamiche i professionisti della relazione d’aiuto di matrice interpersonalista sono chiamati a focalizzare la propria attenzione sulla richiesta del cliente (altrimenti detto anche paziente o utente, a seconda dei casi). Spesso la richiesta del cliente e direi quindi del paziente nella maggior parte dei casi, è implicita, nascosta, ambivalente, e spesso contiene elementi psicodinamici che si costellano sin dai primissimi incontri, se non addirittura già dal primo contatto telefonico. La richiesta è quindi una sorta di sintesi estrema di bisogno di aiuto, di affetto, di ascolto, di comprensione, di solidarietà, di consigli, di protezione e di accoglienza: ovvero attivare quelle risorse indispensabili ad affrontare un problema che investe potentemente la sfera delle emozioni e dei pensieri. Tuttavia questo ancora non è di pertinenza specifica dello psicologo ma di qualsiasi professionista o operatore coinvolto che sia attivatore di risorse, come anche della famiglia e della rete sociale più stretta, o delle associazioni di volontariato sociale. In una buona parte di casi assistiamo ad una vera e propria richiesta di “pronto soccorso psicologico”, che non sempre esita in un percorso che aiuti lo stalker o la vittima di stalking a diventare consapevole dei propri vissuti e dei propri bisogni e maturare psicologicamente, acquisendo strumenti che permettono al paziente di diventare autonomo o più autonomo nella gestione dello stress emotivo: più consapevole della propria fragilità e dei propri punti di forza, delle risorse nascoste che non sentiva e non sapeva di avere. Il pronto soccorso psicologico lavora prevalentemente con le tecniche della psicologia dell’emergenza e quindi si basa sulle teorie e le tecniche legate al disturbo post traumatico da stress. Lo psicologo interpersonalista e lo psicoanalista possono indagare ulteriormente le dinamiche alla base dello stalking, considerandolo alla stregua di qualsiasi altro di tipo di manifestazione sintomatica di un disagio profondo che alberga dentro il cuore e la mente della persona che lo porta. Quello che può e deve fare lo psicologo è utilizzare le componenti della richiesta di aiuto (che tecnicamente si definisce analisi della domanda) per stabilire una relazione di fiducia che si basi essenzialmente su due fattori chiavi: l’identificazione e l’empatia. Per fare questo occorrono un training e una conoscenza vasta e approfondita della sfera psicoaffettiva dell’essere umano, che parte dalla conoscenza del proprio mondo interiore e di quelle “parti” del terapeuta che entrano immediatamente in risonanza emotiva con le ferite del paziente. Identificazione ed empatia sono processi circolari che coinvolgono sia la sfera affettiva che quella emotiva, e coinvolgono il pensiero, la percezione, la comunicazione. L’identificazione e l’empatia consentono al paziente di stabilire una connessione immediata con lo psicologo, attivando quei processi che gli rendono possibile la relazione di transfert, ovvero la possibilità di trasferire nella relazione analitica i ricordi e le emozioni, tradotti in atti analitici, che sono all’origine dei vissuti e che costituiscono la base sulla quale è stata costruita la storia di stalker o di vittima di stalking, permettendogli di uscire dall’identificazione determinata dallo stigma sociale di cui parlavamo prima, vale a dire l’etichettamento sociale in categorie predeterminate, specialmente in quei soggetti dotati di bassa autostima in cui il “danger control” non si attiva direttamente con una risposta adattiva e protettiva, come invece fa più facilmente chi è dotato di una alta autostima. I soggetti dotati di maggiore autostima hanno una percezione maggiore della propria autoefficacia, e di conseguenza sanno reagire in modo più appropriato alle situazioni ad alto stress. Vi è una correlazione diretta tra stigma sociale, bassa autostima, reato di stalking. Torniamo ad una prospettiva psicoanalitica interpersonale. Gli elementi che vi porto sono frutto di una raccolta di dati e di interviste con i colleghi che operano al Polo Psicodinamiche.
Che cos’è la relazione di transfert, chiamata anche relazione di traslazione? Il transfert è sostanzialmente una normale proiezione che può essere positiva (transfert positivo), con connotazioni di stima, affetto, amore per il partner della relazione, oppure avere una valenza negativa (transfert negativo) quando le emozioni che vengono messe in gioco dal transfert sono per lo più di competitività, invidia, gelosia, aggressività o anche con connotati ambivalenti. Nell’ambito del colloquio clinico, nella relazione tra analizzato e analista per lo più nel linguaggio che descrive questo tipo di relazione, viene comunemente usato il termine di transfert al posto di quello di proiezione.
Avrete notato come abbia equiparato l’aiuto allo stalker e alla vittima di stalker anche sul piano metodologico. Di fatto, per lo psicoanalista attento alla relazione interpersonale, non è difficile annotare quali sono quegli elementi di Ombra che sono costellati dalla figura dello stalker e che qualche la vittima tende a proiettare quasi esclusivamente sul suo persecutore. Se la vittima è costretta a subire i comportamenti dello stalker, lo stalker a propria volta è ingabbiato in una dimensione psicologica che non gli permette di cambiare il suo comportamento, per la resistenza della vittima a disinnescare i sentimenti di odio, di rabbia, di paura che la attraversano e la cui responsabilità attribuisce totalmente allo stalker. Quello che è possibile fare, immediatamente, è a mio avviso una prima riorganizzazione del confine di identità. Nella relazione stretta tra vittima e carnefice, si assiste ad una distribuzione specifica di ruoli che è contestuale ad una diffusione dell’identità. L’atto di identificazione primaria con l’analista e l’instaurarsi del transfert, è in primo luogo il primo di atto di separazione della vittima dal carnefice. Di fatto, questo rivolgersi allo psicologo non può essere letto come un mera affermazione di bisogno di aiuto, ma come un primo aggancio ad una nuova realtà, in cui la comunicazione non sia più perversa e denotata da un lessico proprio del possesso e dell’erotomania, ma sia una comunicazione sana, basata su reciprocità e rispetto degli spazi verbali e prossemici, e dalla garanzia di non invasione, di non intrusione. Dalla garanzia di un abbraccio simbolico che permetta alla persona di non essere più considerata un oggetto della comunicazione, ma di essere un soggetto nella comunicazione. Probabilmente lo stalker ha le proprie spalle un vissuto di manipolazione e di inganno, è stato un bambino illuso e probabilmente abusato, se non fisicamente, psicologicamente, e che porta con sé un disturbo di personalità o una sindrome psicoaffettiva molto grave e dolorosa. Questo non significa a priori che sia necessario perdonare il reato, tutt’altro. La collocazione in una dimensione giuridica coincide con la presa d’atto di essere in una realtà adulta in cui ci si assume la responsabilità dei propri atti, delle proprie parole, e anche dei propri sentimenti. In ogni caso, sebbene non venga quasi mai detto, ci si deve assumere la responsabilità giuridica e dinamica del proprio inconscio, e di quelle cose che sebbene non soggette al controllo della volontà o che si ribellano al dominio dell’Io, in ogni caso arrecano danno a noi stessi o al nostro prossimo. Riprendiamo le fila dunque del nostro primo colloquio, supponiamo con una vittima di stalking. Esiste la probabilità che la nostra vittima nella relazione di transfert attivi delle dinamiche di manipolazione e che tenti di innescare anche una competizione inconscia tra stalker e analista, sfidando quest’ultimo con prove sempre più estenuanti di resistenza all’aggressività e alla seduzione. E che proprio nella relazione analitica rimetta in atto non già quello che apparentemente è un vissuto persecutorio, ma quello che vi sta più sotto, ovvero il desiderio di una relazione che incentivi gli aspetti persecutori, connotata da possesso, alta erotizzazione, gelosia con tratti talvolta deliranti. Si tratta solo di esempi, di connotazioni che possono esserci o meno, ma che tuttavia si riscontrano quasi sempre nei resoconti clinici dei colloqui che avvengono nel nostro centro. La dinamica che precipuamente connette stalker e vittima di stalker è del tipo carnefice-vittima, ed è verosimilmente di tipo sadomasochistico. Non necessariamente questo si esplicita nella sessualità, tuttavia ad una indagine più approfondita spesso emerge che entrambe le parti non hanno esperito una sessualità sana nella propria vita passata, e in alcuni casi si assiste a ricordi di abusi fisici, psichici e sessuali subiti durante la prima infanzia e l’adolescenza, o a situazioni di emarginazione e deprivazione affettiva.
In qualche modo sappiamo che esiste un legame molto preciso tra vittima e carnefice, che sebbene non intacchi la responsabilità giuridica e penale di un atto criminoso e violento e non modifichi l’assetto delle forze in campo, tuttavia amplifica enormemente la possibilità di uscire dalla situazione di stress non ricadendo nella stessa identica trappola con un partner successivo. Infatti, è noto che coloro che sono vittima di stalking, lo siano non casualmente e qualche volta ripetutamente. La responsabilità emotiva e dinamica è quindi il nostro strumento principe per permettere alla vittima di non cadere nel tranello del proprio persecutore, diventando in grado di intercettare non tanto la cattiveria del carnefice, quanto la propria inconscia tendenza ad essere manipolati, ingannati, perseguitati, soffocati, controllati. In altre parole, di essere oggetti nelle mani di qualcun altro considerato più forte e più grande, più degno di amore anche di noi stessi. Il sentimento di indegnità della vittima è infatti uno dei più dolorosi, ciò non di meno anche il carnefice si vive a propria volta come vittima di una “condizione” esterna che non gli permette altra scelta se non la coercizione per ottenere amore e affetto, ovvero quel riconoscimento e quel sostegno che avrebbe voluto e dovuto ricevere dalla figure parentali e che è curiosamente costretto a chiedere con la forza. D’altro canto, la vittima dentro di sé coltiva l’idea di meritarsi un simile trattamento, forte di un’esperienza in cui le è stato insegnato che l’amore e la sofferenza sono spesso sinonimi intercambiabili, che piacere e dolore sono due facce della stessa medaglia, e che in ogni caso è giusto subire un maltrattamento in quanto è l’unico modo per sentirsi al sicuro… un pensiero della vittima potrebbe tipicamente essere questo: “Se non mi ribello al genitore maltrattante, lui mi proteggerà e non mi abbandonerà. Se quindi persevero nella condotta che merita punizione, otterrò maggiori attenzioni negative e quindi maggiori probabilità di essere utile al mio carnefice”. Vedete come la spirale perversa che si innesca non può essere detonata se non attraverso un chirurgico e nello stesso tempo rapido lavoro di consapevolezza anche attraverso tecniche che permettano la risoluzione di alcuni nodi transferali connotati da forti contenuti rimossi.
A questo proposito voglio soffermarmi sulla particolare tecnica che viene utilizzata nel nostro centro, che consiste nel combinare la psicoterapia individuale di frequenza settimanale con una sessione quindicinale di psicoterapia di gruppo della durata di tre ore, in cui viene esplorato il mondo interiore del trauma attraverso lo psicodramma psicoanalitico. Con questo metodo combinato, con una cifra mensile relativamente accessibile, è possibile praticare una psicoterapia del profondo di altissima qualità con la facilitazione e l’accelerazione consentite dal pathos e dalla forza della psicoterapia di gruppo, che inoltre consente alla persona un cambiamento di status da soggetto isolato e stigmatizzato a persona degna a tutti gli effetti di stare in un gruppo in un ambiente sano, protetto, coordinato da esperti e connotato da empatia e simpateticità nei confronti del proprio vissuto, quale che sia, con cui condividere spavento e rabbia via via che le emozioni affiorano e si rivelano con tutta la loro dolorosa intensità.
Voglio tuttavia esplorare ancora con voi il mondo interno dello stalker e della vittima di stalking, che si apre alla nostra vista come un coacervo indistinto di legami non neutrali, di emozioni violente, di energia non canalizzata. Si tratta in alcuni casi di una vera e propria realtà illusoria cui entrambi appartengono, e che rappresenta a mio avviso il topos dinamico più complesso e più nascosto. Infatti, è caratterizzata da una costante che possiamo chiamare patto segreto o accordo implicito, che si ritrova spesso nelle coppie di amanti (la coppia di amanti può essere costellata anche da marito e moglie, vale a dire è una categoria psicologica e non sociogiuridica); un contratto silenzioso quindi, che quando rivela il proprio autoinganno lascia nei pazienti un vissuto di vuoto e di depressione caratterizzato da un dolore sordo, profondo e prolungato che con molta probabilità sarà stato preceduto da un periodo di rabbia e di dolore più vivo ma più superficiale, che ha costituito il motore per avviare la macchina della consapevolezza, (per passare dalla fatalità alla scelta, dall’interdipendenza all’intersoggettività).
Per uno psicologo, ma anche per un avvocato o un mediatore, può essere difficile conciliare le violenze narrate dalla vittima con i sentimenti di amore e attaccamento provati nei confronti del suo “aguzzino”, un fenomeno definito “Sindrome di adattamento” nelle esperienze di abuso e “Sindrome di Stoccolma” nelle vittime dei sequestri di persona. Nei bambini vittime di abusi e maltrattamenti, è significativamente presente l’idealizzazione difensiva del genitore abusante o dell’aggressore. La stigmatizzazione di fatto origina nelle psicodinamiche familiari, a causa del genitore che non agisce ma assiste e colpevolizza il bambino maltrattato o abusato. La vittima quindi non tende semplicemente ad assumersi la colpa di quanto accaduto, ma ad assumersi la colpa del genitore. Introietta, si dice, il super-Io del genitore, per tollerare la violenza, creando un adattamento disfunzionale che arreca un danno non soltanto fisico, sociale o morale, ma psicologico: psicologico perché danneggia le strutture difensive primarie dell’Io, alimentando una catena di “coazione a ripetere” che spesso la vittima è costretta a mettere in atto nella vita adulta, incappando in figure che hanno coordinate psicopatologiche non dissimili da quelle degli abusatori primari. Si pensi al fenomeno del gaslighting, frequente sebbene già analizzato dalla criminologia. In un influente articolo intitolato Some Clinical Consequences of Introjection: Gaslighting (“Alcune conseguenze cliniche dell’introiezione: Gaslighting”), gli autori argomentano come il gaslighting coinvolga la proiezione e l’introiezione dei conflitti psichici dal molestatore alla vittima: “questa imposizione è basata su un tipo molto particolare di «trasferimento» di conflitti mentali dolorosi e potenzialmente dolorosi”. La vittima può avere “una tendenza a incorporare e assimilare quello che gli altri esternalizzano e proiettano su di loro, e il gaslighting può essere una configurazione molto complessa e altamente strutturata che coinvolge contributi da molti elementi dell’apparato psichico”.
Il processo di “identificazione con l’aggressore”, introdotto da Anna Freud e ampliato da Ferenczi, offre una valida spiegazione psicodinamica di questo infelice seppure utile meccanismo di difesa. Utile a che cosa? A salvaguardare l’integrità di un Io asserragliato da attacchi continui, da aggressioni esterne da parte di coloro che dovrebbero invece prendersene cura ed educarlo, e pertanto ledendo alla base i processi di instaurazione della fiducia in se stessi, negli altri, nel mondo. Praticamente tradendo il patto di protezione umana che è implicito tra genitori e figli.
Proviamo ad immaginare la nostra mente come un vaso che, dotato di una sua struttura in qualche modo flessibile, pur non perdendo la sua caratteristica di vaso si trasformi in un vaso comunicante, in grado di acquisire e accumulare informazioni dall’esterno non solo attraverso le percezioni proprie, ma anche attraverso quelle di un’altra persona. Questo tipo di struttura è stata capace, in età evolutiva, di farci costruire un rapporto simbiotico con il care giver e di permetterci di comunicare con il mondo tramite le figure di accudimento anche quando non eravamo in grado di parlare o esprimerci diversamente. Nell’orizzonte della vittima di stalking e dello stalker, la relazione non consiste nel confronto affettivo tra due identità, ma nel confondersi ancora con il mondo interiore di un’altra persona, alla quale chiede di sostituire quella figura assente che non è stata o non è più in grado di nutrirla psicologicamente, e che comunque è quasi sempre una figura primaria. Di fatto quindi la relazione vittima-carnefice è connotata da un alto grado di regressione e ricalca i modelli operativi interni e l’organizzazione psichica familiare o parentale. Questo solleva un interrogativo molto importante. Riguarda il rischio che ciascuno di noi corre di poter essere un potenziale stalker o vittima di stalking. A nostro avviso, è necessario essere tutelati nel nostro lavoro dal rischio clinico, poiché la nostra mente possiede di dotazione quella struttura primaria di vasi comunicanti che furono utili alla sopravvivenza e che può essere utilizzato proficuamente e con saggezza in tutte le relazioni affettive, come per esempio l’innamoramento, ma ancora di più nella relazione con i figli. Sappiamo che qualsiasi organo, e così la mente, può ammalarsi se sottoposto a forte stress, e di conseguenza è necessario sapere che tutti coloro che si occupano di relazioni, che siano avvocati, psicologi, operatori sociali, rischiano quindi direi rischiamo di incappare in uno stress veicolato da situazioni contingenti. Lo spill over (una sorta di contagio), ovvero il traboccamento di contenuti psichici è un’ipotesi da prendere sempre in considerazione, ed è per questo che sono vivamente consigliate le supervisioni anche di gruppo con uno psicologo esperto, per tutte le professioni che hanno come punto focale la relazione tra esseri umani.
Bibliografia minima e statistiche di riferimento
Acquadro Maran, D., Pristerà, V., Varetto, A., Zedda, M., Stalking: aspetti psicologici, in «Psicologi a confronto», anno 4 n. 2 – ottobre 2010.
j