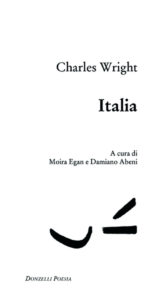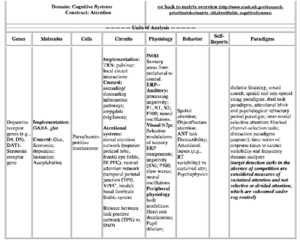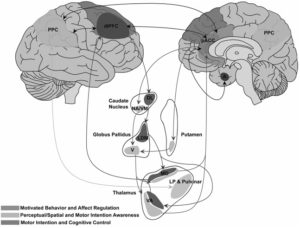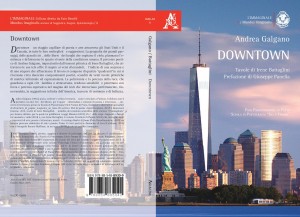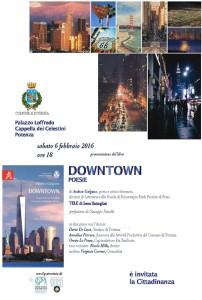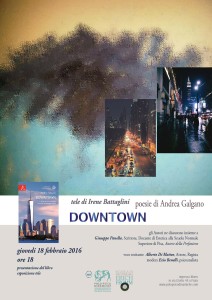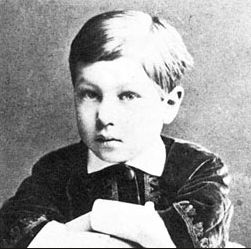di Andrea Galgano 7 giugno 2017
leggi in pdf JACOBO CORTINES: L’OSPITALE LIMPIDEZZA
 La pubblicazione, per Elliot di Roma, dell’antologia di poesia di Jacobo Cortines (1946), Passione e paesaggio (Poesie 1974-2016)[1], finalmente edita in Italia, grazie alla sapiente cura di Matteo Lefèvre, rende ragione non solo alla passione riunita della sua opera ma anche alla ospitale e fragrante limpidezza del suo gesto poetico, ravvivato e ricompattato attraverso l’esposizione di una vocazione segreta e lineare.
La pubblicazione, per Elliot di Roma, dell’antologia di poesia di Jacobo Cortines (1946), Passione e paesaggio (Poesie 1974-2016)[1], finalmente edita in Italia, grazie alla sapiente cura di Matteo Lefèvre, rende ragione non solo alla passione riunita della sua opera ma anche alla ospitale e fragrante limpidezza del suo gesto poetico, ravvivato e ricompattato attraverso l’esposizione di una vocazione segreta e lineare.
Nato a Lebrija, in Spagna, in Andalusia, ha insegnato per molti anni Letteratura spagnola presso l’Università di Siviglia e, oltre a saggi accademici su Felipe Cortines Murube, Luis Cernuda e Fernando Villalón, libri di prose e memorie, ha pubblicato cinque raccolte di poesia, per le quali ha ottenuto importanti riconoscimenti, sin dagli esordi di Primera entrega (1978), passando per Pasión y paisaje (1983), Carta de junio y otros poemas (1994) e Consolaciones (2004), con cui ha ottenuto il “Premio de la Crítica”, fino a Nombre entre nombres (2014).
Dal 1996 è membro della Real Academia Sevillana de Buenas Letras e da alcuni anni dirige, con Ignacio Garmendia, la collana di poesia «Vandalia» per la Fundación José Manuel Lara, che promuove l’importanza della della cultura spagnola contemporanea.
Ha inoltre tradotto in castigliano i Trionfi (1983) e il Canzoniere (1989) di Petrarca e l’opera di Cesare Sterbini, il librettista di alcune opere di Rossini.
Leggere la sua poesia significa sperimentare una figuratività cristallina, che sfugge a ogni pietrificazione e frantumazione, e che spinge, dapprima, alla consegna di una disegnata biografia morale e poi a una intatta profondità perlustrata nella realtà, unendo l’intensità al varco unico e corposo dell’immagine.
Lo sfondo classico, che si dispone sul classicismo e sulla sfrontata nitidezza di Petrarca prima e Leopardi poi[2], raggiungendo il raffinamento di Góngora e Lorca, dipana il perpetuarsi di un dialogo inesausto e di una forma di riflessione[3] di una verità in atto che lavora, si allaccia al tessuto più profondo dell’essere e alla materia primaria del suo continuo presente, come un mormorio di gioia disperata.
Matteo Lefèvre afferma:
Nella sua poesia Cortines dialoga con se stesso e con gli altri in un rapporto costante con l’ambiente che inevitabilmente condiziona l’uomo e la sua erranza nella storia, una storia fatta di volti, momenti luoghi; privata e universale insieme. In pressoché tutti i suoi libri l’autore ricorre con sicurezza al lessico e agli stilemi cari alla tradizione – da quella estetizzante degli esordi a quella classicista – esibendo un campionario delle possibilità che si offrono all’imitatio ben al di là dei confini della modernità e proponendo uno spettro che spazia dalla variazione sui temi più battuti dalla poesia di ogni tempo (amore, morte, solitudine, memoria ecc.) alla reinterpretazione e perfino alla demistificazione di questi ultimi alla luce di un disincanto dettato dall’esperienza, da un’intelligenza che non sembra piegarsi ad alcuna “ortodossia”, ad alcuna idea reçue. […] Cortines dipana il regesto delle immagini per metterle in discussione, squadernarle a volte, per operare su di esse un originale lavoro di decostruzione umana e letteraria.[4]
Così il gesto si plasma gradualmente, il lavoro si concentra in una sequenziale scalata di immagini che, scompongono le mete di ogni lacerato dolore e la linea di ogni chiassoso dramma interiore[5], per raggiungere la piana di ogni bellezza possibile e il suo scenario, l’impronta che ritma il mondo, la stratificazione di crepe e precipizi e la frazione della passione ritirata, come la spiaggia-specchio che riflette le palpebre serrate:
è così che ti incontro con le gambe fiorite, / con le spalle dischiuse, ignuda sulle labbra, / ma la fretta ti avvolge e riempie bocca e occhi / senza freni nell’ansia che il collo ti corrode. / La tua testa si rompe, i tuoi piedi si spaccano / e il tuo ventre riversa tra le ombre il suo fuoco. / Comincia l’avventura. Nuove forme emergono / e in tormenta ruotiamo col vento verso il lampo, / come pioggia tra tenebre, come tuono tra i tuoni. / Perdute le memorie stimolano i presenti / come stalle dischiuse a selvaggi destrieri. / È la spiaggia, / lo specchio che riflette le palpebre serrate / come felici fossili che la morte assaporano. (Passione fissa).
L’unione della passione e del paesaggio non è solo la chiusura e il reperto di un trauma, ma anche lo sguardo di orizzonti oltre le ortiche negli occhi, il dramma e la palpebra serena, il sogno mortale e il disvelamento di una estranea infinitudine[6].
L’immagine si allinea così in un lungo processo di racchiusa contemplazione e decostruzione, in cui la varietà stessa di un canto andato racchiude l’inquieta ricerca della realtà, il suo farsi luce, il suo denso ricominciamento, il richiamo di ogni eco e la chiarezza nuda di ogni notte (e note) di terra.
L’accadimento di questa notte di tenebra contiene il grembo di un’aurora nuova e sorgiva che recupera gli stilemi di un’antica promessa rinascimentale, attraverso
un serrato confronto con il linguaggio della tradizione classicista: «se corridoi segreti» e «labirinti» possono ben accamparsi anche nel territorio del lessico simbolico, al contrario alcuni vocaboli e sintagmi richiamano in modo esplicito importanti modelli rinascimentali, che non vengono evocati esclusivamente come serbatoio linguistico, ma per i temi e il senso profondo che veicolano. Non parliamo soltanto dell’eloquente explicit del testo, in cui i «gigli» e la «sonora solitudine» rimandano scopertamente ai versi, famosissimi, di San Juan de la Cruz e di Garcilaso de la Vega, forse i due migliori poeti del Cinquecento spagnolo, ma anche della rete di lemmi e figure che si dipanano nell’intero corpo della lirica e che in diversi casi sono veri e propri calchi degli autori appena ricordati[7]:
Ecco la Noche de tierra di Cortines:
Oscuro come seno atro di tenebra, / come di fiamma viva spento tremito, / cieco ferire che nascosto bruci / gli infami labirinti che si offrono! / Non la tua voce ascolto che innamori, / né respiro da te il suo profumo, / solo la tua tarlata invidia incontro / occulta nei tuoi corridoi segreti. / Sopito sta il mio odio nell’oblio / di una notte sì amara alle sue cure. / Sopito sta il mio pianto e quasi alieno / a questo aspro sentire che alimenti. / Non seguirò le tue orme, né i miei passi / scaleranno l’aurora che nascondi. / Spegni, allora, il tuo fuoco, non attendo / né gigli né sonora solitudine.
La propulsione della pienezza è un ritorno dopo un assedio, la vita che ritorna dopo il colmo di ogni sperduta e implacabile finestra, il dettaglio che toglie dallo scranno la profondità lucente che ritorna, nell’estate e nel suo apice rigoglioso di ricordo.
Qui la nominazione è uno sguardo che include l’aperto battito oscuro delle cose e il solco-eco tracciato come righe di un quaderno:
Con l’estate ritorna l’immagine al ricordo: / il giardino con gli archi di cipresso sfrondato, / i nardi, la bignonia, il muro rosso e bianco, / il terreno innaffiato quando viene la sera, / la cinta di eucalipti, il rumore dei pioppi, / il sentiero che porta alle dolci colline, / la luna è un’arancia rotonda in mezzo ai rami. / È luglio e la finestra piena è di gelsomini (Ritorno nell’estate).
I notturni o le sere imminenti di Cortines sono fondali che splendono e increspano ogni trama nel taciuto tremito del sangue, nel respiro e nel rumore di argento e vento, dove si afferma ogni riflesso fondo di acqua e paura, come un rinvenimento di bordi. L’agnizione screpolata delle cose è il cuore nudo della sera. Ecco la nudità esposta nella scena di Cortines, da una parte il fuoco spogliato della passione, dall’altra un legame fertile dell’apollineo con l’omaggio vivissimo dei particolari di ogni veduta. È una luce di lontananza, sia interiore sia esteriore:
Nella sera dorata il mio cuore è nero, / come una lunga notte dove s’accresce il vuoto, / freddo dell’indicibile nel candido sudario / delle ore che tessono la morte silenziosa. / Fragile fu il ricordo della blanda allegria / i cui resti dispersi sono sotto la polvere, / testardo il desiderio di quello che giammai / giunse tiepidamente come una primavera. / La sera è oro e sangue, e quasi seta il cielo, / che romperà la luna con il suo argento nudo, / e blu sarà la notte di questa lunga estate, / mentre un’altra s’annega nelle sue sporche lacrime. (Cuore nella sera).
Esiste una democritea perturbazione[8] in questa dichiarata ed estrema felicità, laddove «i piani della natura si intersecano, gli oggetti si umanizzano, e in cui risaltano ardite similitudini, metafore, analogie e sinestesie, spesso fondate su un’aggettivazione che in più di un’occasione deborda il criterio puramente descrittivo[9]».
Il biancore dell’istante penetra nella cristallina dilatazione di ogni tremore: è trasparenza, distanza, intensità, profumo che si annuncia, freschezza di ogni densità. L’invito di ciò che si manifesta è un angolare compimento del reale, dove ogni istante scrive il suo tempo e il suo diluvio:
Era bianco l’istante e il suo biancore dolce / come la mano tenera il palmo cristallino / i cristalli flessuosi e il petalo di unghie / e le piccole fragole di gemme tra le piume / sopra il becco brillante che rovescia all’indietro / testa ali e anche la coda fino a lasciarla andare / come nube nell’aria e scatenare il vento / ricordare la brezza tremante sulla spiaggia / la schiuma l’arenile sdraiati dolcemente / come il fiore caduto solitario sul marmo / dimentico del ramo che il suo biancore intenso / combina con il verde sopra il vetro e sull’acqua / ed esala profumo come quando è tra i rami / o nella sera stanca per il caldo del giorno / come un corpo assopito su lenzuola pulite / il cui fresco biancore invita ad allungarsi / a fermare la notte e accogliere la luna / il pallido silenzio che percorre le labbra / l’avorio di ogni dente la carne impallidita / distante ed impalpabile come rose lontane (Biancore dell’istante).
In Carta de junio y otros poemas, Cortines unisce la speranza dell’elegia al disincanto della nostalgia. È il frutto di una inedita commistione di scenari che insediano i luoghi perduti e le lettere di giugno, il paradiso dell’infanzia e l’intricato ricordo[10].
Gli angoli non riposano prima di ogni splendore di cielo e prima di ogni vanità silente. La scrittura, pertanto, segue ciò che si è perduto come sparpagliata vita da rivivere e commossa inesorabilità. Questo sguardo ricambiato e ricolmo di amore custodisce ogni paura e buio, fino alla pace dell’anima.
Ogni tormenta cessa se i tuoi occhi / spargono il proprio azzurro. Che serena / diventa l’aria allora e quanto pura / la nuova luce. Quando tu mi guardi / le nubi del mio pianto, la tristezza, / come la notte, nera, l’incuranza, / i venti dell’angoscia, i dispiaceri / rochi come il tuonare sordo, il tedio / devastatore e freddo, l’amarezza / come pioggia di fiele, le aspre ire, / che rodono il mio cuore, si dissolvono / e tutto è pace nel profondo, e nasce / come un fiore silente l’allegria / di sapersi guardato nel tuo sguardo. (Nel tuo sguardo).
Il solitario e pensieroso autoritratto riflesso alla finestra scheggia la lingua rarefatta della morte e i fogli concentrano il loro biancore dove dipanare lo sguardo di amore e fiele. Poi ancora il silenzio di ombra e di notte, l’armonia dell’oscurità sulla linea carbone di commiato e inazione, sopravvivono al fondo dell’oscurità irrespirabile e incrinata. L’istante di ombra si propone in modo continuo: «La morte è nel rintocco di quei passi / che avanzano dalla tastiera al tavolo, / dalla sedia al balcone, alla strada, / ad un cielo di nubi bianconere, / al fondo screpolato e silenzioso / delle ore che oscure e stanche passano. / Una morte tenace, il cui sudario / sono i fogli che in bianco sopravvivono» (Fogli in bianco).
La finitezza della lettera di giugno ha latitudini oraziane e paterne, si ricollega al passato letterario ma è anche domanda di una vivida traiettoria esistenziale, colma fino al singhiozzo e mescolata
all’irruenza del ricordo personale con l’olimpica necessità di fare ordine, con la misura che l’epistola richiede pur nel dolore, nel tradimento o nell’incomprensione. E il tutto è filtrato da un linguaggio che è, sì, sempre sorvegliato, ma non sfocia mai nella gravitas, come pure in certi casi il genere richiederebbe; un linguaggio che ha in sé l’immediatezza e la pacatezza del colloquio, poiché ciò che prevale è l’amore profondo, anche se in parte disatteso, per il genitore giunto al termine dei suoi giorni, la solidarietà tra anime che si sanno simili per tanti aspetti, dalla vocazione artistica all’insoddisfazione e alla depressione.[11]
Ecco lo sprofondato inizio della lettera. Lo splendore di cenere saccheggia la patina del tempo e il piccolo universo, l’amore dei colori, i suoni, i desideri, la solitudine. Le infinite domande di Cortines impolverano ogni inquietudine e strazio, perpetuando la lotta come l’abbandono, il pianto e le ferite della verità nuda.
È un mondo chiaroscurale che conduce a ogni affilamento di sorpresa e di mondo, ricoprendo ogni curva di tempo. La vita, che si impone e si dispone in tutte le sue tracce e entusiasmo, è l’indice che nomina ciò che ci appartiene e che lasciamo, è orma ritornata, è stellata chiara, è cuore, stuporoso e silente, negli assetati campi dell’estate, come una voce che implora o il sonno che si sveglia.
Torna il paesaggio e la casa, gli oliveti, la torre, la luna tra i pioppi e il corso del cielo, i frutti e l’abisso. Cortines recupera una dimensione e, allo stesso tempo, la affranca, la desidera e la riempie di speranza. Attraverso lo sguardo paterno e la tensione, risana speranze, abiti e stanze, poi sguardi e erranze estreme, poiché «Non è stato un errore la tua vita, / e la speranza che per te ora chiedo / è in te se vuoi vederla. Apri gli occhi / e guarda il tuo dolore che può essere / cura migliore di ogni altro rimedio. / La verità è dolore, tu lo sai; / con la verità nuda puoi raggiungere / la più alta pace che hai mai immaginato»:
Dov’è la tua illusione, i sogni dove? / Odi le mie domande oppure il tempo / ha ormai chiuso il tuo cuore e il tuo sentire? / È un’altra sera di un mese qualsiasi. / In poltrona, abbattuto, te ne stai, / o ti trascini goffo alla tua stanza / per scordarti del giorno con l’aiuto / del farmaco efficace che ti immerga / nel corposo riposo della notte. / Vorresti non svegliarti, ma il domani / arriva uguale a ieri, imperturbabile, / alieno alla stanchezza e al tuo volere.
Con Consolaciones (2004), vincitore del prestigioso “Premio de la Crítica”, partendo da Liszt, Cortines torna, compiutamente, alla discrezione dell’origine che riporta l’amore all’amore, la natura arcadica[12] al mito domestico, la sperdutezza intensa del tempo alla fecondità di una «religio non rivelata, forse solo intravista, senza dubbio vitalistica, una speranza che, pur con tutte le cadute a cui va incontro, si fonda sulla dolcezza del ricordo, sulla necessità di godere appieno della vita e di quello che offre, dagli affetti della natura[13]».
È una precaria condizione che però offre il fianco alla naturalezza del poeta che insegue il generoso incanto naturale, la polvere delle estati, i ricordi rotti e le spiagge. La sponda dei trapassi fa brillare la verità nuda, la compassione, il canto d’amore e la tenebra sfolgorano («Se abito la tenebra o nel fango / consumo le mie ore, non per questo / dispero di vederti. So che un giorno / io vedrà la tua gloria, che i miei occhi / si apriranno alla luce e la mia carne / rimarrà pura al tatto della tua. […] Nel fango io ti penso. Nella tenebra / aspetto lo splendore del tuo arrivo»):
Non la sera di maggio chiara e fresca, / nella pace del parco, tra le rose / fiorite per far sì che grate fossero / della vecchiaia le ore condivise. / Non sul sentiero con tranquilli passi / per vedere disfarsi tra le spighe / lo splendore del sole rosso e d’oro / che diffonde la bruma sopra i colli. / Non l’uno accanto all’altro o faccia a faccia / ricordando con calma i più felici / momenti di una vita, i comuni / frutti sbocciati da una stessa carne. / Non così, ma distanti, silenziosi, / tra quattro mura spente e solitarie, / come tanti che non sono mai giunti / a scacciare da sé colpa e delitto (Tramonto con figure).
Oppure le acque silenziose (della vita, del tempo, dell’essere) allargano le rive nel tempo fertile delle scene. La memoria compone il suo transito e rivela la spogliata melodia degli istanti smarriti. Contro il dolore rimane ciò che gli sopravvive e gli vive come pace, ripetendo forse un passato perpetuo lungo la deriva:
Bianche colline di dorate viti, / blu la macchina di questo lungo fiume / nell’oscura palude, vaga bruma / la sorpresa dell’aria in lontananza. / Come riposa l’anima alla vista! / Qui sono nato io, e qui dimentico / di lotte, di doveri e di castighi, / voglio seguire il corso della vita / per percepire il tempo ad ogni passo / con tutto il suo dolore e l’allegria / giù fino al mare come queste acque / che silenziose allargano le rive (Beatus ego).
È il compito della poesia, rintracciare le istanze lontane, il decisivo soccorso del segreto, il grido unico nella penombra delle albe e nell’aria secca dei deserti. Vibrare, per Cortines, equivale a vivere fino a essere «sfumatura, impulso, vincolo, battaglia, fino a essere esplosione, occaso, ombre». Anche tra le rovine e le ellissi, anche nei ritrovamenti dell’eternità fugace della gioia.
Il luogo è la densità dell’essere: la città, la campagna, il mare, l’alba rappresentano l’agonia e la resurrezione di un tempo doloroso e florido che gustano gli sfarzi e i respiri. Il pericolo è l’estraneità. L’essere esclusi dalla festa del mondo e del suo ricordo vivo come ombra errante.
Il poeta registra ogni sfondo e trasparenza, il contrappunto, la preghiera muta che sono «i passi / che ascolta un dio nel sole che declina», la terra che diventa carne della propria carne: «Giungo a te, terra mia, per sapermi una terra, / per essere una terra, come terra è la carne. / Umilmente divento un’altra volta sogno, / un po’ più che silenzio, giacchè fummo anche amore».
Perdita e recupero insieme, tratti dal sogno, che include ogni spostamento e deviazione e dà leggerezza alle ceneri. Esso è «il luogo in cui i morti tornano a visitare i vivi, a incontrarli fisicamente a volte; Cortines lo sa, sa quanto l’universo onirico rappresenti una distesa di dubbi tra due rive lontane, lo scenario transitorio del rimpianto ma anche del colloquio e della visione fugace […][14]»:
Di nuovo l’acqua copre la laguna / e un cielo grande in essa si riflette. / Ma tu, dolce sorella, tu che tanto / amavi l’iniziare dell’inverno, / altra laguna più estesa attraversi / altro e più grande cielo a te si offre. / Fuggisti così muta che silenzio / tutto si è fatto senza la tua voce / o il riso, e tutto in arida ombra giace / senza la ricca luce dei tuoi occhi. / Gli oleandri, l’orto, anche gli acanti, / i sentieri che portano alla valle, / il seminato, i picchi, la boscaglia, / tutto ciò che curavi qui è rimasto / come in attesa ancora dei tuoi passi / tra i nostri che di te le orme seguono. / Un sogno sogni assai profondo e noi / ben svegli sopportiamo le inclemenze / di un inverno senza te crudele. / Ora solchi le acque senza fine. / Naviga in pace nel ricordo nostro, / vivi il tuo sogno e sognaci con te (Inverno).
In Nombre entre ombres (2014), Cortines
dipana una specie di privatissimo epos, che vede implicati come personaggi tanto l’autore quanto i suoi familiari più vicini, dai genitori ai fratelli e ai nipoti, e che ha per centro tematico e ambientazione la campagna andalusa. Si tratta della terra dell’infanzia, di casolari, stalle, poggi e campi appartenuti alla sua stirpe più prossima, perduti e riconquistati nell’arco di un paio di generazioni; si tratta di questioni che vanno al di là del discorso didascalico, e più ancora di quello economico, poiché tali possedimenti hanno principalmente un valore affettivo, racchiudono l’essenza stessa dell’appartenenza a un territorio che è anche un mondo. È un universo fatto di legami ancestrali che la poesia è come sempre chiamata a “eternare”, un universo senza tempo, come l’età bambina e la prima giovinezza, quando ogni luogo, ogni vincolo sanguigno appare come fonte di unità[15].
Ancora una volta il recupero esistenziale di ciò che è perduto cerca rifugio in una natura antica e primordiale che si spinge fino a Virgilio e Varrone, ma ricostruisce una sostanza di gesto e genesi, immanenza e sostrato originario.
Il corso del tempo cinge la precisione pascoliana dei dettagli, la pienezza memoriale si dispone nei frammenti rurali[16] attraverso la radicale tensione poetica di un diorama[17] di figure che abitano il tempo e lo sfuggono, scomparendo in un eden prospettico e figurativo e in un’infanzia che spezza le tenebre, inondando la memoria di colline, pianure, gelsomini, lentisco e palme nane. La voce del fanciullino esplora un tempo ricostruito e strappato, avviluppato dal groviglio del tempo disarmato, arreso ed escluso nel mito trasfigurato:
E osserva la sua infanzia, e sorge il nome / come spezzando un’ampia e densa tenebra / e di luce inondando la memoria: / un patio con la ghiaia e i gelsomini, / una fitta foresta / con giumente e cavalli sotto, all’ombra. / Lentisco e palme nane sul pianoro / che nel torrente muore. Bianche groppe / di orizzonti stanchi. Ampie stalle, / scuderie e recinti. Ed il carretto / pieno di verdi giunchi che dei buoi / trasportano per tappezzare i viottoli.
L’elencazione della realtà non serve tanto riempire quanto a rinvenire un germoglio astrale remoto e scomparso. Il sogno prima risanato non basta e il nome sembra dissolversi:
La divisione ha inizio. / Ogni nome andrà ormai per proprio conto / per sbriciolarsi senza alcun consiglio / che lo possa impedire. / Così quel nome, il più amato un tempo, / quello della tua infanzia e giovinezza, / lo vedi demolito / senza salvare muri né finestre, / né passaggi, né entrate, né uscite. / Addio sognato sogno, addio per sempre.
Si avverte, ad un certo punto, come Cortines voglia rifondare la realtà partendo da ciò che già c’è. Un rifugio, un ritiro, o più semplicemente, un nido che diviene destino e trionfo, non già un’oasi, quanto piuttosto un mondo che nasce e risorge come dono commosso. Vita che si proclama e si designa, nonostante la sporcizia e l’abbandono, le crepe e le finestre senza vetri. Il terreno di spini e sterpaglie del presente porge di nuovo il suo incrinato frantume:
Il nome in me! Che irrompe nel presente, / come nube che scende e insieme avvolge / tutta la superficie mia, e mi lascio / impregnare al suo interno / per irrigare gli anni di arsura, / di aneliti infiniti, / di assenze e di penuria di speranze. / Il nome che si annida nel ricordo / e che vuole gettarsi nel futuro / per mutarsi, impaziente, / in sogno ormai compiuto.
Il nuovo patto tra le cose risanerà i nostri frammenti. Credere in ciò che c’è è la sfida oltre la contingenza e il rimpianto, per ravvivare la speranza dell’umano e il suo basamento, per affermare la fede nella realtà che non delude e riscattare il nome perduto e le notti ritrovate:
Credere in questa luce, in questi cieli / limpidi dove passa / un uccello che in musica trasforma / la mattinata, il pomeriggio o il vespro. / Credere nelle notti / punteggiate di stelle, misteriose, / non viste con le luci / delle cieche città contaminate. […] E mi sento legato stretto al tempo,
però in nessun passato, in un presente / che al contempo è vecchiaia, infanzia, tutto, / somma di eternità / fatta di istanti identici e distinti.
Il tempo che vive cerca il desiderio del riscatto, l’ordine dei giardini, la lunga estate, il fango primigenio e l’esodo dei giorni in una anteriore messe del nome tra i nomi, El Labrador, ultima coltre di un amore immenso:
Solitudine è pure il tempo nuovo, / e nella lunga estate / di crepuscoli rossi quante volte / a loro io ho pensato, a chi ormai giace, / Adamo ed Eva, accanto a questo nome / che non siamo riusciti a pronunciare e a riscattare insieme. / Che nostalgia impossibile / di un abbandono che non ha altra fine / che il comune riposo / sotto la stessa terra amata, eppure / senza vedersi né parlarsi o udirsi. / Frutti entrambi di un’anteriore messe / come anche noi di questa. Frutti tutti / del fango primigenio a cui torniamo. / Parti di una medesima catena, / di cui non conosciamo inizio e fine, / come pure il momento / del segnato passaggio all’altro lato.
 CORTINES J., Passione e paesaggio (Poesie 1974-2016), a cura di Matteo Lefèvre, Elliot, Roma 2017, pp. 128, Euro 17,50.
CORTINES J., Passione e paesaggio (Poesie 1974-2016), a cura di Matteo Lefèvre, Elliot, Roma 2017, pp. 128, Euro 17,50.
[1] CORTINES J., Passione e paesaggio (Poesie 1974-2016), a cura di Matteo Lefèvre, Elliot, Roma 2017.
[2] Matteo Lefèvre scrive: «Da Petrarca, ad esempio, con Orazio sullo sfondo, l’autore riprende da un lato la padronanza degli strumenti retorici e il rigore della versificazione, dall’altro l’attenzione alla natura e al paesaggio – quello andaluso nel suo caso – e la costante indagine psicologica, che declina l’umano in tutte le sue sfumature. E a ciò si aggiunga anche un innato istinto filosofico, che sfiora l’inquietudine pensosa e insieme lucidissima di certo Leopardi, uno degli autori più ammirati dal poeta, del quale sfrutta altresì certe sinuosità del verso», (cit., La traiettoria di un “classico” del xxi secolo, in Cortines J., cit., p. 8).
[3] LUCAS A., El verso despacio de Jacobo Cortines, in “El Mundo”, 1 maggio 2016.
[4] LEFEVREM., cit., p.9.
[5] (http://www.20minutos.es/noticia/2709432/0/poeta-jacobo-cortines-reune-su-obra-pasion-paisaje-mirada-al-interior-ser/), 30 marzo 2016.
[6] (http://sevilla.abc.es/cultura/libros/20141104/sevi-jacobo-cortines-poemario-201411032044.html), 4 novembre 2014.
[7] LEVEFRE M., cit., pp.12-13.
[8] LUQUE A., Jacobo Cortines: “Escribir poesía en Sevilla es una forma de felicidad”, (http://elcorreoweb.es/historico/jacobo-cortines-escribir-poesia-en-sevilla-es-una-forma-de-felicidad-MIEC792538), 27 ottobre 2014.
[9] LEFEVRE M., cit., p. 10.
[10] Cfr. LAMILLAR J., El desorden del canto: notas sobre poesía española del siglo xx, Editorial Renacimiento, Sevilla 2000, pp. 131-132.
[11] LEFEVRE M., cit., p. 14.
[12] DIAZ DE CASTRO F., Consolaciones. Jacobo Cortines, in “El Cultural”, 3 marzo 2005.
[13] LEFEVRE M., cit., p. 16.
[14] ID., cit., pp. 17-18.
[15] ID., cit., p. 21.
[16] ALBERT M. J., El paso del tiempo de “Nombre entre nombres”, en “Cordopolis”, 17 febbraio 2015.
[17] RIVERO TARAVILLO A., Nombre entre nombres, en “El Mundo”, 17 ottobre 2014.
CORTINES J., Passione e paesaggio (Poesie 1974-2016), a cura di Matteo Lefèvre, Elliot, Roma 2017.
(http://www.20minutos.es/noticia/2709432/0/poeta-jacobo-cortines-reune-su-obra-pasion-paisaje-mirada-al-interior-ser/), “20 minutos”, 30 marzo 2016.
(http://sevilla.abc.es/cultura/libros/20141104/sevi-jacobo-cortines-poemario-201411032044.html), 4 novembre 2014.
ALBERT M. J., El paso del tiempo de “Nombre entre nombres”, en “Cordopolis”, 17 febbraio 2015.
DIAZ DE CASTRO F., Consolaciones. Jacobo Cortines, in “El Cultural”, 3 marzo 2005.
González-BARBA A., Jacobo Cortines: «El poeta tiene que estar muy pendiente del mundo en que vive y del dolor humano», in “ABCdeSevilla”, 15 aprile 2005.
LEFEVRE M., In dialogo con Jacobo Cortines, un petrarchista del XXI secolo (http://diacritica.it/traduzione-e-inediti/in-dialogo-con-jacobo-cortines-un-petrarchista-del-xxi-secolo.html), in «Diacritica», i, 1, 2015, pp.111-126.
LUCAS A., El verso despacio de Jacobo Cortines, in “El Mundo”, 1 maggio 2016.
LAMILLAR J., El desorden del canto: notas sobre poesía española del siglo xx, Editorial Renacimiento, Sevilla 2000.
LUQUE A., Jacobo Cortines: “Escribir poesía en Sevilla es una forma de felicidad”, (http://elcorreoweb.es/historico/jacobo-cortines-escribir-poesia-en-sevilla-es-una-forma-de-felicidad-MIEC792538), 27 ottobre 2014.
RIVERO TARAVILLO A., Nombre entre nombres, en “El Mundo”, 17 ottobre 2014.